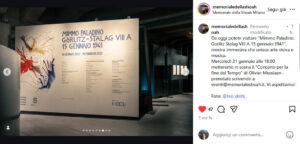Negli ultimi anni, la compensazione delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) mediante progetti di riforestazione è diventata una strategia molto popolare, adottata da governi e aziende per dichiararsi “carbon neutral”. L’idea sembra semplice e seducente: piantare alberi per assorbire la CO₂ generata da attività umane, in particolare dalla combustione di combustibili fossili. Tuttavia, un recente studio (pubblicato nel giugno 2025 su Communications Earth & Environment), condotto da Alain Naef e colleghi, dimostra che questa soluzione, se adottata su larga scala per bilanciare l’intero contenuto carbonioso delle riserve fossili conosciute, è insostenibile sia dal punto di vista economico che spaziale.
Gli autori hanno calcolato quanta superficie forestale e quali risorse finanziarie sarebbero necessarie per compensare, attraverso afforestazione (creazione di nuove foreste su terreni che ne erano precedentemente privi), tutte le emissioni di CO₂ associate alla combustione delle riserve esistenti di petrolio, gas e carbone. I risultati sono impressionanti e preoccupanti: per compensare le emissioni da tutte le riserve fossili bruciabili, sarebbe necessario piantare alberi su una superficie pari a circa 1,3 volte l’intera estensione del Nord America, ossia oltre 25 milioni di chilometri quadrati. Un’area di questa grandezza è chiaramente indisponibile, considerando le esigenze alimentari, urbane ed ecologiche già in atto nel pianeta.
Il problema non è solo geografico. Anche sotto il profilo economico, la compensazione risulta impraticabile. Gli autori hanno confrontato il valore delle riserve fossili delle maggiori compagnie petrolifere con i costi stimati per la loro compensazione tramite rimboschimento. Ne risulta che molte grandi compagnie risulterebbero finanziariamente insostenibili se fossero obbligate a compensare pienamente le emissioni derivanti dal loro prodotto. Il costo medio per tonnellata di CO₂ rimossa tramite riforestazione è variabile, ma anche con stime conservative i costi totali supererebbero di gran lunga i profitti ottenibili dai combustibili stessi.
Inoltre, la rimozione del carbonio tramite alberi non è una soluzione permanente. Le foreste piantate possono essere colpite da incendi, siccità, malattie o cambiamenti nell’uso del suolo, che rilascerebbero nuovamente il carbonio assorbito. In altre parole, la cattura del carbonio tramite afforestazione è reversibile, mentre le emissioni fossili sono definitive.
Lo studio evidenzia anche una questione etica: affidarsi alla piantumazione per giustificare l’uso continuo dei combustibili fossili rischia di trasformarsi in una scusa per ritardare la decarbonizzazione. Invece di ridurre le emissioni alla fonte, si posticipano decisioni strutturali affidandosi a compensazioni future, spesso ipotetiche o non verificate.
La riforestazione ha certamente un ruolo nel contrasto al cambiamento climatico. Può contribuire a rimuovere parte della CO₂ atmosferica, migliorare la biodiversità e rigenerare suoli degradati. Tuttavia, non può e non deve essere vista come una strategia principale o sostitutiva della riduzione delle emissioni. I modelli climatici più affidabili indicano chiaramente che la priorità assoluta è interrompere progressivamente ma radicalmente l’uso dei combustibili fossili, accompagnando questa transizione con misure di efficienza energetica, fonti rinnovabili e tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio.
In sintesi, lo studio di Naef e colleghi rappresenta un monito importante: non possiamo piantare alberi per uscire dalla crisi climatica. La vera soluzione non si trova nel cercare scorciatoie verdi, ma nell’affrontare il cuore del problema – la nostra dipendenza dai combustibili fossili – con politiche coraggiose, innovazione e cambiamenti sistemici.