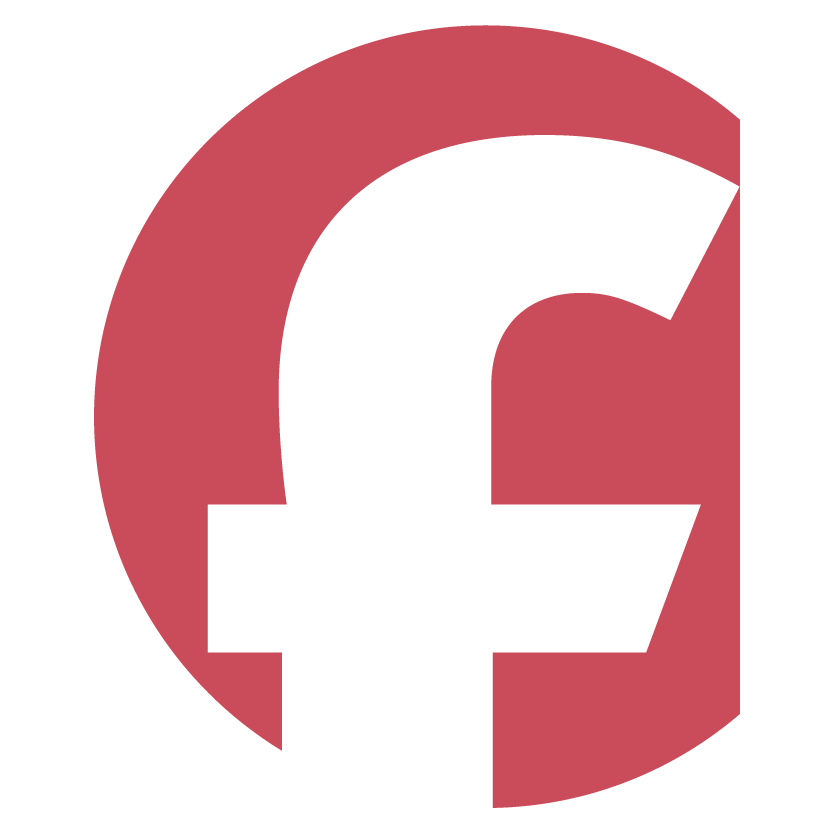L’attacco israeliano del 9 settembre sul palazzo di Doha ospitante la delegazione di Hamas continua a generare fibrillazioni. Il Qatar convoca il vertice panislamico, taccia Israele di terrorismo, parla di attentato contro tutto il mondo arabo e accusa gli Usa di inerzia. Washington si barcamena tra versioni incompatibili e prova a rabbonire gli emiri. Per comprendere la tensione è bene cogliere le implicazioni del fatto, associandovi i potenziali cambi di paradigma di cui esso si fa sintomo.
Netanyahu non è nuovo ad alzare il tiro, avendo già acceso le polveri contro Libano, Siria e Iran. Come nel caso iraniano, ha nuovamente attaccato durante una tornata di trattative promosse dalla Casa Bianca. A Doha, infatti, è stata centrata la sede in cui Hamas, con la mediazione qatariota, stava discutendo l’ennesima ipotesi di tregua nella Striscia avanzata da Witkoff. E di nuovo si potrebbe dire che dove gli Usa provano a costruire Israele demolisce. Ma oltre a chiarire una volta di più quanto conti la liberazione degli ostaggi per il governo israeliano, occorre considerare il salto di qualità. Il Qatar infatti è Paese amico per l’Occidente: grande importatore di armi da Usa, Germania, Italia e Francia, ospite della maggiore base statunitense fuori confine, legato a doppio filo alla finanza europea nonché protetto speciale della Turchia, che è membro Nato. Inoltre è ormai da anni un partner di primo rango per le azioni diplomatiche di Washington con il mondo islamico, con una relazione privilegiata sottolineata dal dono del Boeing fatto fatto al neoletto Trump.
L’imbarazzo di quest’ultimo è più che giustificato, nel tentativo di apparire al contempo estraneo ma non succube. Sa bene che un’azione del genere, oltre a rischiare il colpo di grazia sugli Accordi di Abramo, può compromettere 80 anni di politica Usa in Medioriente. L’estremo affronto può spingere le petrolmonarchie sunnite a superare le rivalità, convergendo nel vedere in Israele il vero soggetto destabilizzatore della regione e finendo tutte per seguire l’esempio saudita nello stringere intese di distensione bilaterale con l’Iran.
Se poi la destabilizzazione viene da una potenza atomica latente, come è Israele, allora il vulnus appare sistemico, allargandosi alla crisi della deterrenza nucleare, travolgendo la logica concordata delle minacce simmetriche che Usa e Urss istituirono con la Guerra fredda per scongiurare, in tacita reciprocità, il ricorso ad armamenti forieri di mutua distruzione assicurata. Diversamente, il suo possesso nelle mani di un attore fuori controllo lascia paventare non semplicemente la nuclearizzazione e la proliferazione cautelativa di altri soggetti, ma la derubricazione dell’atomica a dispositivo convenzionale.
Salendo ancora di livello incrociamo lo sdoganamento di un uso piratesco della diplomazia, prestata come esca per azioni anomiche. Gli Usa risultano viepiù esposti al pericolo di essere trascinati da Israele nei gorghi del discredito, patendo la taccia di “Stato canaglia” che – quantunque coniata da Washington nel 2001 per giustificare la sua lotta senza freni al cd. “Asse del Male” –ora il Qatar rivolge al regime israeliano. Tanto più alla luce di un modus operandi consolidato nella prassi dei servizi israeliani, cui gli Usa hanno aderito in diverse occasioni, incluso l’omicidio del generale iraniano Soleimani nell’aeroporto di Baghdad nel 2020 durante il primo mandato di Trump – per giunta usato come precedente da Erdoğan per giustificare le azioni contro i curdi su suolo siriano e iracheno.
A tutto ciò si connette la ferita inferta alla credibilità degli Usa in veste di egemone globale messo alle strette da un sodale cui non si può dire di no, quindi costretto al funambolismo del dissociarsi dall’azione senza ammettere di essere stato aggirato. Ossia, tra la connivenza e l’impotenza. Ma la mossa di Israele sul Qatar aggiunge un elemento assai critico, in un frangente in cui al resto del mondo, vista la formula multipolare promossa da Sco e Brics, si offrono opzioni di affiliazione alternative agli Stati Uniti. Un quid che insinua negli amici un dubbio pericoloso per i presupposti di un’egemonia: gli Usa sono in grado di tutelare i loro protetti, almeno da minacce mosse dall’interno della loro sfera di influenza?
La rivista Politico ha da poco divulgato il contenuto di una prima bozza della prossima National Defence Strategy sul tavolo di Trump, che avallerebbe l’esigenza di deflettere dalla sfida frontale con la Cina per ragioni di insostenibilità sistemica, così da concentrarsi sul “giardino di casa”. In effetti, le esternazioni su Canada, Groenlandia e Panama, le mosse sulla Colombia, la pressione armata sul Venezuela, la leva dei dazi e delle spese Nato ne danno riscontro. Se ciò risponde al vero, questa sorta di rivisitazione della Dottrina Monroe spiega le frizioni tra il neoisolazionismo Maga da un lato e, dall’altro, il Pentagono, l’agenda neocon e l’universalismo liberale di piega interventista, tutti congruenti con gli interessi del complesso militare-industriale.
In ogni caso, è da escludere che il disimpegno contempli il Medioriente, esposto com’è, con tutta la sua caratura geostrategica, alla penetrazione di influenze concorrenti. Pertanto, stante la concatenazione di allerte attivata dall’attentato di Doha, la priorità di somma urgenza sta – per quanto risulti possibile – nel tirare il morso israeliano, anche al costo di sabotaggi domestici. Diversamente, non si vede cosa Washington possa aspettarsi dalla condiscendenza.