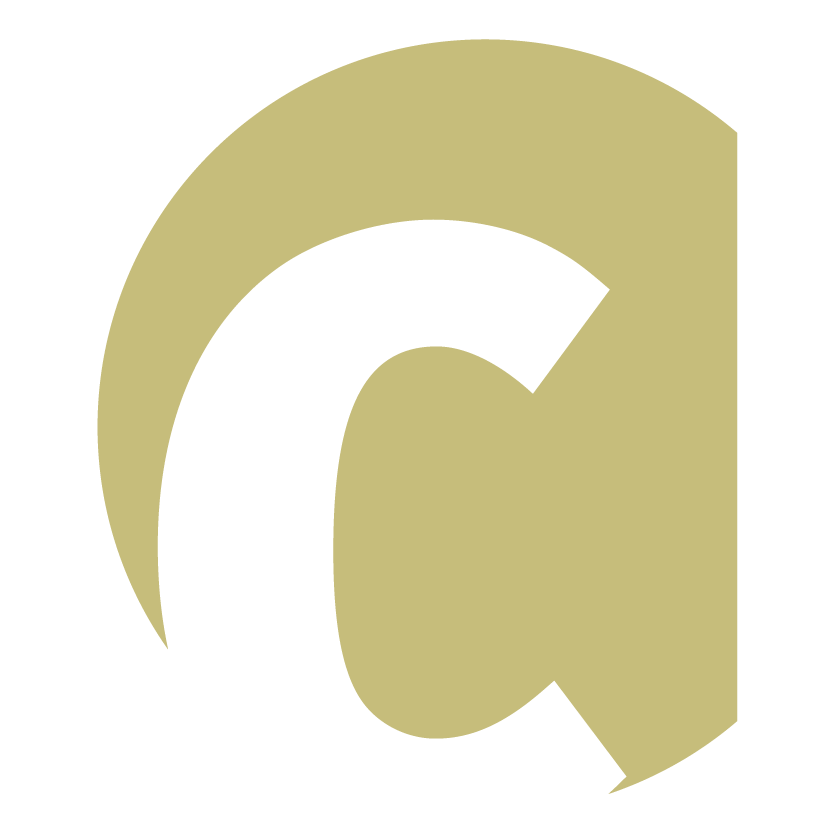Marcella Reni, notaio calabrese, è stata una delle pioniere della giustizia riparativa in Italia. Fondatrice di Prison fellowship Italia, ispirata dalla sua fede cristiana, da oltre quindici anni promuove percorsi di riconciliazione tra detenuti e vittime attraverso il “Progetto Sicomoro”. In occasione del Giubileo degli operatori di giustizia, condivide con il Sir la sua esperienza e il significato di un cammino che unisce fede, diritto e umanità. La sua testimonianza mostra che la giustizia riparativa non è teoria astratta ma esperienza concreta di riconciliazione e rinascita. In un tempo segnato da conflitti, paure e rancori sociali, il suo lavoro ricorda che “nessuno è solo il suo errore” e che dalla forza del perdono può scaturire una nuova vita. Un messaggio che il Giubileo degli operatori di giustizia è chiamato a raccogliere e rilanciare.
Come è nato il suo impegno con Prison fellowship e cosa l’ha spinta a lavorare con i detenuti e le vittime?
È nato per caso. Non avevo alcuna intenzione di occuparmi di carcere, anzi pensavo: chi sbaglia deve pagare, si butta la chiave e basta. Poi, come notaio, mi capitò di incontrare un giovane detenuto accusato ingiustamente. Lo vidi distrutto, senza speranza. Gli promisi una preghiera, che poi dimenticai. Due anni dopo tornò a ringraziarmi: nei momenti in cui aveva tentato il suicidio, sentiva come una voce interiore che gli diceva “fuori qualcuno prega per te”. In quel momento capii che non era stato il mio ricordo, ma Dio a non essersi dimenticato di lui. Da allora ho cambiato sguardo:

l’uomo non è mai solo il suo errore.
Il Progetto Sicomoro è al centro della vostra missione. Di cosa si tratta?
È un percorso che facciamo in carcere mettendo insieme detenuti e vittime dello stesso tipo di reato, anche se non si tratta dei loro casi diretti. In otto incontri settimanali, inizialmente c’è uno scontro duro, doloroso. Poi succede qualcosa: i detenuti acquistano consapevolezza della ferita provocata, mentre le vittime trovano una forma di ristoro non nella pena inflitta, ma nella responsabilità assunta dall’altro. È una dinamica sorprendente, che accade sempre, in ogni carcere, a ogni latitudine.
Ci può raccontare qualche storia che le è rimasta nel cuore?
Ne ho tantissime. Una giovane donna, a cui avevano ucciso il padre perché non voleva che lei sposasse un uomo legato alla ’ndrangheta, ha incontrato in carcere un ex killer. Per tre settimane lo ha insultato senza sosta. Alla quarta, lui ha raccontato la sua vita segnata dalla violenza familiare:“Questa vita non l’ho scelta io, è la vita che ha scelto me”.Lei è crollata in lacrime e da quell’incontro è nata un’amicizia capace di sanare ferite antiche. C’è poi la storia di Elisabetta, mamma di un ragazzo quindicenne ucciso davanti al fratello gemello. Era piena di odio, voleva vendicarsi. Dopo il percorso, disse: “Per me è stato come entrare in un tunnel di odio e scoprire alla fine una luce. La mia liberazione è venuta dal carcere”. Oggi è una delle nostre più attive volontarie. Potrei raccontare ancora: un trafficante internazionale che ha scelto di scrivere un libro contro la droga per i giovani, un killer pluriomicida che solo ascoltando la testimonianza di una vittima di rapina ha compreso il dolore causato da ogni suo gesto. Sono storie che mostrano come la violenza sia un grido che chiede di essere ascoltato. Quando accade, tutto cambia.
Lei ha visto anche le famiglie trasformarsi…
Sì. Spesso sono proprio i legami familiari a guarire. Ricordo Mario Congiusta, papà di Gianluca, giovane imprenditore ucciso in Calabria. Non ha mai smesso di chiedere giustizia, ma nel carcere ha trovato una nuova vita. Dopo il Sicomoro la sua casa, segnata dal dolore, è tornata a profumare di cibo, il pianoforte del figlio è stato scoperchiato e suonato. Diceva: “Partecipare a questo progetto mi ha ridato la vita”. E questo, per un padre ferito, vale più di una sentenza.
Oggi il carcere italiano vive molte difficoltà. Qual è, dal suo punto di vista, la sfida più urgente?
Le nostre prigioni sono sovraffollate e inadeguate. Dentro ci sono tanti che dovrebbero stare altrove:tossicodipendenti, malati psichiatrici. Si muore di caldo d’estate e di freddo d’inverno. Ma il problema più grande è la recidiva: sette detenuti su dieci tornano a delinquere. Se questo accadesse in una scuola o in un ospedale, ci chiederemmo perché. In carcere no. Eppure è un problema di tutta la società: politica, impresa, associazioni, Chiesa.Serve più coraggio e più fiducia nel reinserimento, altrimenti l’unica cosa che restituiamo alla società è più rabbia.
La fede cristiana come ha plasmato questo cammino?
Il Vangelo mi ha insegnato che nessuno è riducibile al suo errore. Don Oreste Benzi diceva: “L’uomo è più grande del suo peccato”. Lo vedo ogni giorno: la giustizia riparativa non chiede perdono, lo mostra. E quando avviene, è una forza che ricostruisce. Non è buonismo, è concretezza. È vedere la vita ricominciare dove sembrava finita.
Che significato ha per lei il Giubileo degli operatori di giustizia?
Per me significaricordare a giudici, avvocati, forze dell’ordine, volontari che dietro ogni errore c’è una persona con dignità.Non si può tornare indietro, ma si può riprovare a vivere bene. È il cuore del Giubileo: una restituzione. Ogni anno organizziamo il pranzo di Natale in carcere, servito da chef stellati o da vittime di reato. Vogliamo che “i primi servano gli ultimi perché gli ultimi si sentano primi”. Lo stesso spirito deve animare il Giubileo:restituire un po’ della fortuna che noi abbiamo avuto a chi non l’ha avuta.
Quale appello si sente di rivolgere oggi alla società civile e alle istituzioni?
Di non considerare il carcere un luogo separato. Chiedete a un bambino di disegnare la città: non disegnerà mai il carcere, come se non esistesse. E invece è parte della città. Bisogna cambiare sguardo. Creare percorsi alternativi, comunità educanti, case di accoglienza. Sostenere progetti come le Apac (Associazione di protezione e assistenza ai condannati ndr), strutture gestite dagli stessi detenuti con una sovvenzione statale che altrove funzionano. E soprattutto ricordare che

queste persone torneranno tra noi: se tornano guarite è un bene per tutti, se tornano arrabbiate e disperate è un rischio per tutti.