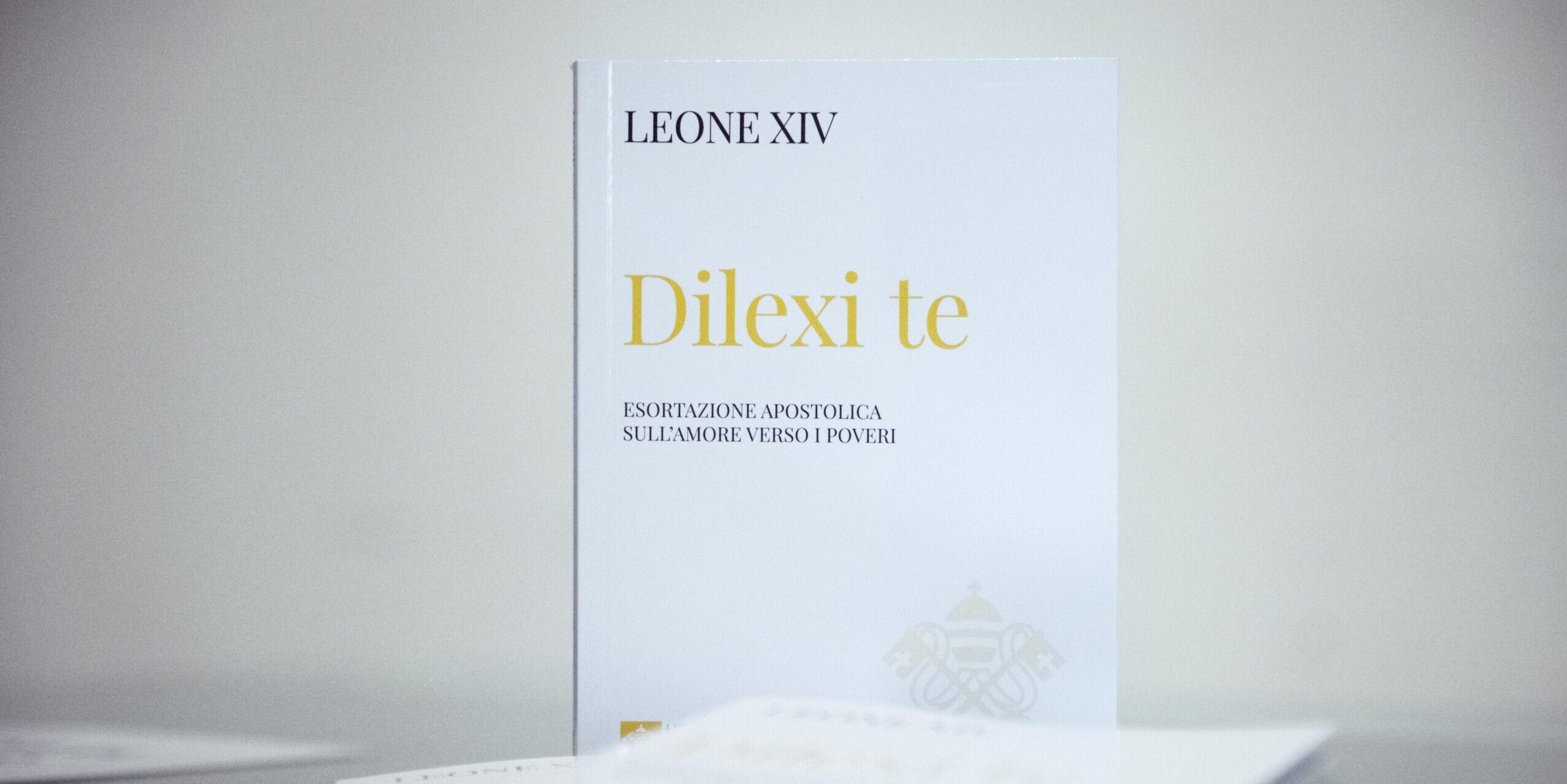
“Senza i poveri, la Chiesa non è se stessa, perché è in loro che Dio rivela il suo volto”. È la convinzione di padre Frédéric-Marie Le Méhauté, teologo francescano e autore del volume “Rivelato ai più piccoli” (Castelvecchi), a commento dell’esortazione apostolica Dilexi te di Papa Leone XIV. Nel testo, il Pontefice propone una visione della povertà come luogo teologico e della Chiesa come comunità che ritrova la propria verità solo accogliendo e camminando con gli ultimi.
Padre Le Méhauté, il Papa scrive che i poveri non sono “un problema da risolvere, ma fratelli e sorelle da accogliere”. Come cambia lo sguardo della Chiesa se parte da qui?
Siamo abituati a vedere la povertà in termini di mancanza. I poveri – diciamo – sono “senza”: senza denaro, senza storia, senza voce, senza potere. Una definizione che amo usare è questa: sono coloro di cui si parla sempre senza di loro. Le Scritture però ci invitano a un’altra visione. Dilexi te ricorda che la scelta dei poveri è prima di tutto una scelta di Dio. L’opzione preferenziale per i poveri non nasce da un programma umano, ma dal cuore stesso di Dio.
I poveri non sono “un problema da risolvere, ma fratelli e sorelle da accogliere”.
Questa prospettiva cambia la teologia della povertà.
Sì. Papa Leone XIV amplifica ciò che Benedetto XVI aveva già affermato: la povertà è un luogo della rivelazione. Il Papa non si limita a dire che Gesù è nei poveri, ma va oltre: è Dio, per primo, che va incontro ai poveri. Quando incontro una persona di strada, non incontro automaticamente Gesù. Incontro una persona concreta, e in quell’incontro qualcosa della rivelazione può avvenire. È perché Dio ha scelto i poveri – non perché siano migliori – che essi diventano luogo della sua presenza. Come dice Gustavo Gutiérrez: Dio non sceglie i poveri perché sono buoni, ma perché Lui è buono.

Dio non sceglie i poveri perché sono buoni, ma perché Lui è buono.
C’è chi teme che questa scelta di Dio per i poveri escluda gli altri.
È un’obiezione antica. Ma la scelta di Dio non è esclusiva, è universale: sceglie i poveri per la salvezza di tutti. Padre Joseph Wresinski parlava di “esaustività”: se costruiamo a partire dai più forti, qualcuno resterà fuori. Se invece partiamo dai più deboli, alla fine tutti troveranno posto. È un messaggio potente: costruire la Chiesa e la società a partire dagli ultimi è l’unico modo per includere davvero tutti.
Il Papa invita a non “ignorare i poveri e vivere come se non esistessero”. Lei ha avuto esperienze forti in questo senso.
Sì, e la prima è stata uno choc. All’inizio della mia vita religiosa, lavoravo con un gruppo di cristiani del Quarto Mondo. Dopo essermi presentato come religioso, un uomo mi chiese: “Che cos’è un religioso?”. Risposi con sicurezza: “È qualcuno che ha fatto voto di castità, obbedienza e povertà”. Appena sentì la parola “povertà”, mi afferrò per il collo e mi disse: “Di povertà non mi parlare. Tu non sai che cos’è”. Aveva ragione. Io non so che cosa significhi dormire sotto un ponte, avere fame, vivere nella solitudine. La mia povertà è una scelta. La loro no.
Chi è padre Frédéric‑Marie Le Méhauté
Teologo francescano impegnato da anni nello studio e nella pratica pastorale presso le comunità ai margini della società. Il suo lavoro teologico concentra l’attenzione sulla povertà come «luogo teologico» e sulla rivelazione di Dio nei volti degli ultimi. Ha maturato esperienze dirette con gruppi del cosiddetto Quarto Mondo e con centri per bambini di strada, raccontando spesso come la condivisione quotidiana e la presenza concreta trasformino la comprensione del Vangelo. La sua prospettiva unisce riflessione dottrinale e prassi pastorale, mettendo al centro la dignità e la soggettività dei poveri.
Questa consapevolezza cambia il modo di intendere il voto di povertà.
Assolutamente. C’è una differenza tra vulnerabilità e precarietà. Tutti siamo vulnerabili, ma non tutti siamo precari. La vulnerabilità è universale; la precarietà no. Non si tratta di idealizzare la povertà. La miseria va combattuta, le cause strutturali vanno eliminate. Ma scegliere di condividere la vita dei poveri è un segno di comunione.

C’è una differenza tra vulnerabilità e precarietà. Tutti siamo vulnerabili, ma non tutti siamo precari.
Può raccontare un momento in cui ha sentito questa comunione concreta?
Quando vivevo in un centro per bambini di strada in Congo. Una sera li sento dire: “Frédéric è un bianco non come gli altri”. Chiesi perché. Un bambino rispose: “Perché accetti di mangiare il riso con noi”. Quel riso scotto e insapore era per loro un segno di fraternità. Non servono grandi discorsi: basta restare, condividere, sedersi con loro. I poveri non chiedono parole, ma presenza. È lì che si rivela un Dio che si fa vicino.

I poveri non chiedono parole, ma presenza. È lì che si rivela un Dio che si fa vicino.
Il Papa aggiunge che vivere come i poveri è il segno della verità della nostra missione.
Sì, perché è lì che Dio si dona. Se incontriamo Dio nei poveri, allora vivere con loro è l’unico modo per ricevere la rivelazione. E il Papa è molto lucido quando avverte: “Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in cui pretenda di stare tranquilla senza occuparsi creativamente e cooperare con efficacia affinché i poveri vivano con dignità e per l’inclusione di tutti, correrà anche il rischio della dissoluzione, benché parli di temi sociali o critichi i governi”. È un monito che riguarda tutti noi.
“La realtà si vede meglio dai margini”, scrive Leone XIV. Che cosa significa per la teologia?
Significa che dobbiamo cambiare prospettiva. Papa Francesco parlava già della “misteriosa sapienza dei poveri”. È una verità evangelica: “Hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli”. I poveri sono maestri di Vangelo. Meditare la Passione con loro è un’esperienza straordinaria. “Anche a me hanno sputato addosso”, dicono. “Quando si cade come Gesù, è difficile rialzarsi”. Per loro, la storia di Cristo non è passata: è presente.

I poveri sono maestri di Vangelo. Per loro, la storia di Cristo non è passata: è presente.
L’opzione preferenziale per i poveri
Espressione fondamentale della dottrina sociale della Chiesa, l’“opzione preferenziale per i poveri” afferma che ogni azione ecclesiale – dalla teologia alla pastorale, dalla liturgia all’impegno sociale – deve partire dallo sguardo e dalle condizioni degli ultimi. Introdotta in modo esplicito nel magistero con il Documento di Puebla (1979), è stata poi ripresa da Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e approfondita da Papa Francesco, che la definisce “una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica”. Non significa escludere gli altri, ma assumere il punto di vista di chi soffre, come via per leggere il Vangelo e costruire una Chiesa realmente evangelica e inclusiva. È, in definitiva, un criterio di verità e di discernimento nella sequela di Cristo.
In che modo questa sapienza può cambiare anche la Chiesa?
Dilexi te afferma che l’accelerazione dei problemi contemporanei “non è stata solo subita, ma anche affrontata e pensata dai poveri”. Significa che i poveri hanno un pensiero. Possono analizzare la realtà e offrire soluzioni. Non sono oggetti di compassione ma soggetti di storia, parola e responsabilità. Il Papa denuncia un sistema dominato da una “minoranza felice” che accumula ricchezze e impone sacrifici ai più deboli. È un grido contro l’invisibilità dei poveri.
Lei parla anche di cecità nella Chiesa. Che cosa intende?
Papa Leone XIV non si limita a criticare le strutture del mondo: dice con franchezza che anche la Chiesa può soffrire della stessa cecità. In Francia, ad esempio, abbiamo compreso solo recentemente quanto sia stato decisivo ascoltare le vittime di abusi per affrontare davvero il dramma della pedocriminalità.

Vedere la realtà dai margini significa proprio questo: mettersi all’ascolto di chi ha sofferto, di chi è stato escluso o ridotto al silenzio.
È l’unico modo per capire fino in fondo le ferite che attraversano la società e la Chiesa.
Il Papa riconosce con realismo che “ci sentiamo più a nostro agio senza i poveri”. È un passaggio molto forte.
Sì, e molto vero. I poveri disturbano le nostre abitudini, ci mettono di fronte a limiti che preferiremmo ignorare. Ma è proprio lì che inizia la conversione. Per san Francesco, tutto nasce dal bacio al lebbroso. Dietro ogni volto ferito, scopre un fratello: il brigante, il lupo, il sultano. Tutto diventa fraternità.
Questa visione attraversa anche la storia della Chiesa.
Sì, e Dilexi te la collega a Dilexit nos, l’enciclica di Papa Francesco sull’amore del cuore di Cristo. Leone XIV mostra che i due amori – per Dio e per i poveri – sono inseparabili. L’impegno verso i poveri non è una conseguenza della fede: è un’epifania, un atto quasi liturgico, perché non si può separare il culto di Dio dall’attenzione ai poveri. Senza i poveri, la Chiesa non è se stessa.
Qual è, secondo lei, il messaggio più urgente di Dilexi te?
Che la cura dei poveri non è un’attività tra le altre, ma fa parte dell’essere stesso della Chiesa: “L’amore dei poveri è la garanzia evangelica di una Chiesa fedele al cuore di Dio”. È la misura della sua verità. Se vogliamo incontrare Gesù nella verità – e non un idolo – lo troveremo solo nella vicinanza e nella compagnia con i poveri.




