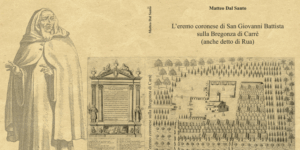Con Sara Salin al suo fianco nel palco dell’auditorium Santa Caterina, ha concluso l’edizione 2025 del Festival Carta Carbone a Treviso. «Sono rimasta molto affascinata da Anna Kulischoff, dalla sua vita controcorrente con coraggio schierandosi contro le convenzioni e il potere del momento, in nome degli ideali socialisti e della lotta per l’emancipazione delle donne» afferma Tiziana Ferrario (68 anni di cui quasi 40 vissuti in Rai da conduttrice del TG1 e da inviata fra Afghanistan e Iran), che nel centenario della morte pubblica Anna K. Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff (Fuoriscena, pagine 240, euro 17).
Madre della figlia di Andrea Costa, compagna di vita di Filippo Turati, Anna era anche “la dotora dei poveri” a Milano – dopo esser stata la prima donna laureata in medicina a Napoli e aver inutilmente inseguito la specializzazione in ginecologia al Bo come ricercatrice di Achille De Giovanni, preside della Facoltà.
«A cavallo fra Ottocento e Novecento fu un periodo di grande trasformazione, con le fabbriche che si riempiono di donne, pagate meno degli uomini, e di bambini. Anna è con le donne massacrate di fatica nelle fabbriche, di botte per la violenza domestica, vittime di incesti e aborti clandestini. Una condizione davvero disumana e lei si batte nelle prime leghe sindacali, per il diritto al voto fino all’approvazione nel 1902, nonostante tutto compreso lo scetticismo di Turati, della legge sulla tutela del lavoro» scandisce Ferrario.
Qual è il profilo di questa donna che rischiava di essere un po’ dimenticata?
«Parlava cinque lingue, leggeva i giornali internazionali, teneva rapporti con i movimenti socialisti in Europa. E ogni giorno Turati le scriveva i suoi dubbi politici da parlamentare e Anna rispondeva dandogli indicazioni. Dalla Crimea dov’era nata, era approdata in Svizzera perché voleva studiare e lo Zar negava alle donne questo diritto. E in Italia ha vissuto da donna straordinaria. Insomma, se Turati è considerato il padre del socialismo, Anna non va lasciata negli archivi perché allora lei è stata la madre del socialismo in Italia…».
C’è la prima donna premier in Italia, donne rettrici nelle Università e manager di primo piano. Si è davvero rotto il tetto di cristallo?
«Non credo che sia sufficiente essere donna per occupare questi posti, bisogna essere anche portatrici di valori che sostengano le altre donne. Cioè non basta mettere donne in posti di comando e responsabilità, se non sono portatrici di idee che migliorino la condizione di vita delle donne. Ho visto anche tante ancelle che venivano inserite nei vertici per fare le foglie di fico e comunque per portare avanti valori del patriarcato. Fare gli interessi delle altre donne, invece, significa essere donne scomode: rompere meccanismi radicati nei secoli e nel modello culturale della nostra società. Gli stipendi devono essere uguali per tutti, occorre ci siano tutele e non si mettono paletti lungo il percorso professionale delle donne, che la maternità non sia considerata un ostacolo, che gli uomini che molestano le donne nei posti di lavoro vengono pesantemente sanzionati. Insomma, provvedimenti che sradichino il potere maschilista».
Pace e guerre: il mondo si è globalizzato soltanto… all’insegna di 56 conflitti in corso?
«Il dibattito che abbiamo vissuto in questi anni anche in Italia tra chi pensa che la soluzione ai conflitti siano le armi e chi crede che invece la pace si costruisca in un altro modo, ecco mentre scrivevo il libro mi interrogavo sul clima del 1914. Come ci ha ricordato recentemente il presidente Mattarella, aveva grandi somiglianze con quello che stiamo respirando adesso e allora si risolse in una guerra mondiale. Oggi ci sono guerre dimenticate e altre da prima pagina. E c’è in Europa chi si sta armando pesantemente, pensando che sia la soluzione. Il passato ci dice che non è mai andata così: le soluzioni si sono sempre trovate al tavolo della diplomazia frutto anche di compromessi con i vinti. Gli errori del passato, pur in un contesto completamente diverso, dovrebbero insegnarci qualche cosa».
L’informazione non è più… un bene comune? Televisione, social e fake hanno avvelenato le fonti?
«Nelle democrazie il potere della stampa dovrebbe essere proprio il contraltare al potere della politica e quindi oggi il giornalismo non se la passa molto bene. Con giornalisti che hanno voglia di mettersi al servizio di qualcuno, mentre ce ne sono altri che vorrebbero fare il loro lavoro. La soluzione è di non rafforzare gli influencer come amano fare molti politici: li abbiamo visti entrare alla Casa Bianca o il governo israeliano utilizzarli per le fake news sulla distribuzione degli aiuti a Gaza mentre in realtà la popolazione moriva di fame. Mi permetto di consigliare ai colleghi di non accontentarsi né degli influencer né di una sola fonte di informazione. Abbiamo la fortuna di poter accedere a più fonti, di mettere a confronto le notizie perché purtroppo c’è ancora chi ama la censura. Il potere politico la applica anche in modo subdolo, magari con le querele temerarie o “punendo” uno per fare in modo che tutti gli altri si auto-censurino. Senza dimenticare l’episodio di Sigfrido Ranucci: quando si comincia a mettere le bombe ai giornalisti è un chiaro segnale di un pessimo clima…».
Foto da Pagina FB Carta Carbone