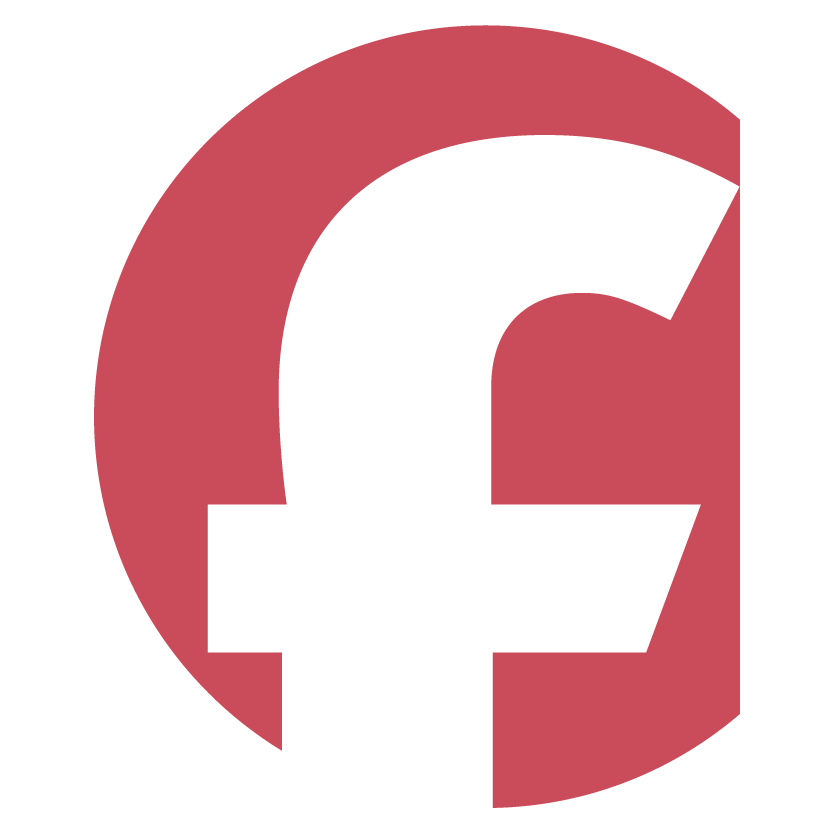“Io credo che in queste circostanze così drammatiche ci sia bisogno di un colpo un colpo d’ala, di politiche per così dire anticicliche, che rimettano sul tavolo opzioni realistiche, consensuali e non violente per la soluzione dei conflitti internazionali”. E’ Pasquale Ferrara, ex ambasciatore, docente di politica internazionale, a tracciare un percorso da seguire di fronte ad un contesto internazionale sempre più teso e incerto. Si profila per venerdì 15 agosto, l’incontro in Alaska tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, indetto sul destino dell’Ucraina, senza però né la presenza dell’Ue né del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sull’altra sponda del Mediterraneo, incombe la decisione presa dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu di assumere il pieno controllo della Striscia di Gaza, procedendo alla sua “occupazione completa”. Abbiamo chiesto al prof. Ferrara una lettura di quanto sta succedendo.
Tra balletti sulle presenze e assenze al tavolo delle trattative in Alaska, cosa la colpisce di più di questa iniziativa?
Non sono ancora chiari gli elementi fondamentali di questo incontro. Per il momento l’unica cosa certa è che Putin sembra aver ottenuto un approccio puramente bilaterale alla guerra con l’Ucraina, nel senso che i protagonisti sono Stati Uniti e Russia. Nei giorni scorsi gli europei si sono fatti giustamente paladini di un coinvolgimento diretto anche dell’Ucraina, con la presenza del presidente Zelensky, ma al momento, su questo punto essenziale, regna l’incertezza. L’altra grande assente sarebbe proprio l’Europa, e questo è paradossale, trattandosi di un conflitto che si svolge alle porte dell’Unione Europea, con un paese come l’Ucraina che ha ottenuto lo stato di candidato ufficiale a far parte dell’Unione.

Il rischio è che si tratti non già di una mediazione, ma di una decisione a tavolino tra le due grandi potenze, che avrebbe il sapore di una imposizione, più che di una composizione consensuale del conflitto.
Tuttavia, i giochi sono ancora aperti, speriamo che prendano una piega più ragionevole dal punto di vista politico-diplomatico.
Quali sono i requisiti minimi per una trattativa di pace…perché sia stabile e duratura?
In primo luogo, un vero accordo di pace per essere tale e avere i requisiti della sostenibilità nel tempo deve necessariamente prevedere il consenso attivo e convinto delle parti in causa. Ciò, in pratica, significa che non si può giocare a dadi con il destino dell’Ucraina, non si può disporre di un paese, se anche lo si facesse con le migliori intenzioni, su questo non è un soggetto ma un mero oggetto di trattativa. Si è parlato nei mesi scorsi nel concetto di una pace giusta, che per essere tale deve rispondere almeno ha dei requisiti minimi.

E cioè, ogni accordo che sia liberamente accettato dall’Ucraina nell’esercizio delle sue prerogative sovrane, senza pressioni, condizionamenti o ricatti esterni.
Questo non vuol dire che non si debbano fare compromessi e che non si debbano prendere decisioni dolorose, ma tutto ciò non può essere il risultato di un diktat. E in particolare sulla questione dei territori occupati dalla Russia ci dovrà essere una soluzione che non comporti la pura e semplice conquista russa, la presa d’atto dell’occupazione, ma l’apertura di un percorso che consenta di esaminare a fondo lo status di queste regioni. In altri termini, si può anche momentaneamente congelare la situazione, a condizione di delineare un’agenda per negoziati conclusivi in futuro. Nel frattempo, sarebbe già molto se si raggiungesse un cessate il fuoco duraturo, per mettere fine ad una carneficina senza senso.
Dall’altra parte del Mediterraneo Israele pensa a invadere Gaza in “nome della pace”…era il progetto che si erano prefissati fin dall’inizio?
Io credo che Netanyahu, dopo il 7 ottobre, abbia sin da subito coltivato un duplice disegno. Da una parte, chiudere una volta per sempre la vicenda palestinese, con l’accantonamento definitivo della soluzione a due stati, l’espansione dell’occupazione nella Cisgiordania e nella Valle del Giordano, la rioccupazione di Gaza. Dall’altra parte, Israele ha cambiato fondamentalmente la sua dottrina della sicurezza, che da difensiva è divenuta aggressiva, con chiare mire egemoniche in tutto il Medio Oriente (basti pensare al Libano, all’Iran, alla Siria, allo Yemen). Queste due linee d’azione sono gemelle, e hanno fatto registrare delle vittorie tattiche indubbie. Dal punto di vista strategico, invece, nel medio e lungo periodo sono scelte disastrose per la stessa sicurezza di Israele, per il suo posizionamento internazionale e per la sua reputazione. Cresce infatti l’isolamento di Tel Aviv nella comunità internazionale, a parte il sostegno di Trump e di pochi altri paesi occidentali, che comunque cominciano a porre condizioni al sostegno ad Israele. Basta leggere la dichiarazione di otto Ministri degli Esteri pubblicata il 9 agosto, dai toni insolitamente duri, anche se non corredati da misure concrete.

Le politiche dissennate e criminali di Netanyahu porteranno frutti avvelenati per decenni, altro che pace.
Alla luce di quello che sta succedendo su questi due fronti le chiedo una valutazione sui leader Trump, Putin e Netanyahu e su come è cambiata in questi pochissimi anni la diplomazia internazionale?
La diplomazia è un’arte antica, fondata sul dialogo, sulle argomentazioni, sulla difficile e tortuosa ricerca di punti di incontro. I leader che abbiamo dinanzi, oggi, rappresentano – a mio avviso – il tradimento della diplomazia, perché fondano le loro iniziative sulla politica di potenza, sulla ricerca di posizioni egemoniche, di acquisizioni unilaterali e di dominio incontrastato in molte aree, dai dazi ai territori.

Tutto questo è la negazione della diplomazia, mentre la Carta delle Nazioni unite viene fatta a pezzi, e non solo simbolicamente, da attori arroganti e senza principi.
Le parlava di un “colpo d’ala”. Diceva che in queste circostanze così drammatiche, c’è bisogno di politiche realistiche, consensuali e non violente. Ma chi lo può fare?
Io credo ancora nelle potenzialità dell’Unione Europea come progetto di pace o quantomeno come percorso integrativo. A mio avviso i leader europei hanno una responsabilità storica fondamentale in questo momento e saranno giudicati dalle risposte che saranno capaci di dare al disfacimento dell’ordine internazionale.

E’ poi fondamentale la voce della stessa Santa Sede come attore autorevole, pacifico e disinteressato rispetto alle tragiche vicende di cui siamo testimoni.
Papa Leone XIV, nel solco di Papa Francesco, non sta certo lesinando interventi, prese di posizione e appelli che mirano a scongiurare che l’umanità vada incontro a disastri ancora più gravi.