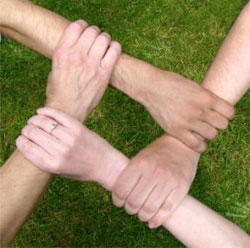
C’è una battuta paradossale, attribuita a Paul Valéry, scrittore e filosofo francese, che ho appreso ascoltando uno dei numerosi podcast con cui cerco di mantenere allenata la mia dieta mediatica di informazione: «Il futuro non è più quello di una volta». La frase, di attribuzione incerta e più volte ripresa da altri autori anche come titolo delle loro opere, è disarmante per quanto sembra ben fotografare il tempo che viviamiamo.

Se un tempo il futuro era l’orizzonte da guardare con speranza, oggi, specialmente per la nostra generazione, appare piuttosto come la prospettiva che genera l’ansia maggiore.
Sarà che questo cambiamento d’epoca sembra averci portato tempi bui, in cui il progresso ha portato ad affinare le tecniche della guerra anziché a oliare i meccanismi del dialogo e della pace. Sarà, forse, che la fiamma del successo è stata alimentata troppo spesso dal soffio dell’egoismo individuale e dalla cultura del risultato che ha finito per farci perdere il gusto del percorso di crescita personale. Sarà, infine, che la società della performance in cui siamo invitati a giocarci la vita, dietro la retorica del merito ha nascosto l’invito a pensare di poter emergere solo gli uni a discapito degli altri, finendo spesso per normalizzare la contrapposizione degli ultimi contro i penultimi, dei poveri contro i più poveri, degli scartati contro gli esclusi. Che capolavoro ha fatto la società capitalista: ha spezzato la solidarietà tra le persone e, ora, anziché allearsi i poveri, gli emarginati, gli ultimi si combattono tra loro.
L’attualità spiazzante e allo stesso tempo struggente della frase attribuita a Valéry sta proprio nel cogliere il ribaltamento che è avvenuto nel nostro sguardo: non è tanto il futuro in sé a essere cambiato, ma il modo in cui noi riusciamo a immaginarlo. Se un tempo il futuro era sinonimo di progresso e di sogni, se rappresentava l’apertura dello sguardo, l’allargamento degli orizzonti, delle possibilità di diventare chi si desiderava (o si credeva di desiderare) essere, oggi è sempre più percepito come un luogo da temere più che da costruire.
È così che il futuro lo immaginiamo chiuso, non aperto; un’esperienza da gestire, da amministrare, non un’avventura da inventare. Un’emozione, ne sono ogni giorno più convinto, che nasce dalla solitudine sempre più diffusa che sperimentiamo. Una solitudine, credo, alimentata dalla crisi dei corpi intermedi la cui sfida più grande che si trovano ad affrontare consiste nel tentativo di ricostruire una comunità sempre nuova che non ha bisogno di comunicazione. Una comunità, cioè – per dirla con le parole del filosofo tedesco Byung Chul Han – che sappia offrire un’alternativa critica a quella iper connessa del mondo moderno che, proponendo una costante comunicazione disincarnata, finisce per lasciarci orfani della vera comunità, sostituendola con surrogati digitali: le community. In questo scenario, in cui sperare sembra fuori luogo o addirittura da ingenui, abbiamo bisogno di recuperare dalla nostra tradizione cristiana la capacità di far trovare insieme le persone.
Il cristianesimo, come ogni religione, è ricco di una cultura narrativa capace di rendere riconoscibile la complessità. Le nostre festività – l’Avvento, il Natale, la Quaresima, la Pasqua, la Pentecoste – sono vertici simbolici all’interno di un grande racconto che orienta la vita personale e comunitaria. Ogni giorno del calendario liturgico è pensato per dispiegare in senso narrativo il mistero dell’incontro tra Dio e l’uomo. È intorno a quel vertice narrativo che gli uomini e le donne da duemila anni si sono ritrovati, si sono scoperti fratelli e sorelle.
In questo tempo così segnato da individualismo e disincanto, per tornare a parlare con credibilità di speranza, è necessario reimparare a camminare insieme agli altri, tornare a investire sui luoghi che permettono l’incontro delle persone che sembrano tra loro lontane. Luoghi che siano, contemporaneamente, temi di riflessione in cui ritrovare un senso comune. Perché sperare oggi significa non cedere alla solitudine come orizzonte. Significa accettare che non possiamo salvarci da soli. Sperare in questo mondo individuale significa fare resistenza quotidiana all’idea che la felicità si possa raggiungere ciascuno per conto suo. Significa, soprattutto, tornare a pensare alla politica come arte della convivenza, luogo dell’ascolto delle diversità, spazio in cui le fragilità non sono un problema da nascondere, ma la base su cui costruire comunità in cui ogni persona può trovare spazio.

In un tempo in cui l’individualismo si maschera da libertà – nella pretesa del tempo libero o nell’ossessione per il tempo personale – dovremmo ricordare che la vera felicità si trova nel servizio, nel mettersi in gioco concretamente.
Per questo la speranza oggi ha bisogno della politica: una politica che sogna e sa far sognare, che costruisce e coinvolge tutti facendo sperimentare la bellezza della responsabilità. Una politica che non si accontenta di amministrare l’esistente, ma ha il coraggio di immaginare il possibile e costruire l’impossibile.
Sperare in un mondo individuale, allora, è scegliere di non restare fermi a guardare. Perché la speranza è una forma di responsabilità, è l’arte di inventare il futuro, non l’alibi per restare fermi. C’è speranza, anche in un questo mondo individuale, se riusciamo a tornare a dire “noi”, smettendo di pensare solo “io”.
Sperare, come partecipare, è un verbo servile: è voce del verbo amare, modo invisibile e responsabile, è al tempo presente e ha la prima persona plurale.




