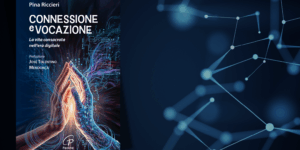Sul piano di pace (meglio dire tregua) per Gaza elaborato dal Pentagono e imposto da Trump molto si è detto. Ma serve riflettere su aspetti che, nel chiarire le posizioni degli attori in gioco, suggeriscano il surplus di incertezza che pesa su tutta la regione. Di 20 punti, solamente uno è effettivamente oggetto dell’abbrivio per fermare la carneficina nella Striscia. Hamas, per nulla annientato ma privato del sostegno in passato proveniente dall’Asse della Resistenza, accetta di scambiare i 20 prigionieri sopravvissuti in cambio di quasi 2.000 palestinesi (donne e bambini inclusi) nelle carceri israeliane, molti senza processo. Sul resto chiede approfondimenti negoziali. Forse è bene ricordare che lo scambio, già all’indomani del Diluvio di al-Aqsa, era proprio la condizione posta da Hamas. Condizione respinta da Tel Aviv, che dichiarava due obiettivi: liberare gli ostaggi con la forza e sradicare il nemico. Senza averli conseguiti, si torna al punto di partenza. Ma allora i rapiti vivi erano molti di più. Nel macinare la Striscia, il governo israeliano ha mostrato che essi non sono mai stati al centro dei suoi pensieri, al pari di quelli che vennero uccisi assieme ai rapitori sotto il fuoco degli elicotteri dell’Idf accorsi con 6 ore di ritardo, in ossequio al Protocollo Annibale, che impone di sacrificare anche i sequestrati pur di evitare le trattative.
Trump ostenta il successo estorto con la leva del terrore, ossia minacciando di autorizzare lo Stato ebraico a “terminare il lavoro”. Apparentemente ciò significa parlare per conto di Netanyahu. Ma il quadro d’insieme fa pensare che la Casa Bianca abbia parlato a suocera affinché nuora intenda. La palla è stata messa tra i piedi di Israele, che pure deve riprendere fiato, usurato com’è da uno sforzo vanamente perpetrato senza un orizzonte strategico. Il Paese è socialmente logorato, in affanno economico, gli apparati interni sono ai ferri corti tra loro. Senza parlare dell’onta internazionale attirata sulla causa sionista.
Washington vuole forzare Tel Aviv ad approfittare del salvagente. La questione va oltre il salvacondotto che serve a Netanyahu per eludere i processi istruiti prima dell’attacco di Hamas (il mandato di arresto dell’Aja non preoccupa altrettanto), da usare come contropartita per uscire dal vicolo cieco di Gaza. Il premier inoltre può usare l’argomento della frusta trumpiana per persuadere la destra religiosa, che insiste su sterminio e annessioni messianiche per il Regno biblico. Ma gli Usa fanno soprattutto i propri conti. Le mobilitazioni delle piazze in Occidente, nonostante le strumentalizzazioni e a dispetto dei detrattori di casacca, hanno scosso i governi gregari, delle cui sorti l’egemone non può disinteressarsi. In vista delle elezioni di medio termine, per Trump pesano anche le insofferenze della base Maga.
Un potente acceleratore è stato l’attacco israeliano al Qatar nel mese scorso: come previsto, un boomerang, giacché ha convinto la Casa Bianca dell’urgenza di scongiurare la defezione delle petrolmonarchie sunnite dall’orbita delle fedeltà regionali: correre ai ripari, a maggior se spera di salvare gli Accordi di Abramo come formula per il controllo da remoto sull’area.
Eppure il piano di tregua è una toppa assai precaria. Per diverse ragioni: Hamas ora è più orizzontale e difficilmente accetterebbe il disarmo in modo compatto; le sigle resistenziali laiche nella Striscia non sono coinvolte; Israele potrebbe far saltare il processo in corso, interrompendo il rilascio degli ostaggi come ha già fatto a febbraio; le garanzie sugli aiuti umanitari e il ritiro dell’Idf appaiono poco affidabili. La “scintillante” ricostruzione, che coinvolge la speculazione di imprese private, sarà a beneficio dei gazawi? Quale forza di interposizione sarà accettata da Tel Aviv, specie se include il rivale turco? Davvero si rinuncerà ai giacimenti di gas nel mare della Striscia? Inoltre, la pompa dell’incontro di Trump e re Carlo inizia a farsi decodificare, guardando a Ucraina e Palestina. Ma su Blair a guida del Board for Peace pesano il ruolo di spalla bellicosa degli Usa di Bush e gli intrecci finanziari tra la sua omonima Fondazione, la British Petroleum, Oracle e Tel Aviv.
Nel complesso si parla di transizione, ma non è chiaro verso cosa. Intanto Hamas la sua mossa tattica l’ha fatta con il rilascio. Ora sta a Israele. Un congelamento nella Striscia non gli permette di cantare vittoria, lasciando il bisogno di vantarla altrove. Forse non è causale il nuovo attacco sul Libano. Nella varietà dei fronti aperti, ad analoga funzione si presterebbe ancora il Golan, per cui aprire il fuoco contro la Siria ora in orbita turca. Senza parlare della Cisgiordania, dove le violenze dei coloni continuano a sostenersi sulla retorica di un’elezione dall’alto superiore a qualsiasi legge. Per altro verso, Hamas, il Likud e le destre religiose si sono rafforzate reciprocamente negli anni, sin dalla loro convergenza contro gli Accordi di Oslo tra Rabin e Arafat. In fondo, ogni manicheismo impone di legittimarsi grazie a un nemico esistenziale. Pertanto, in caso di tregua effettiva, il mirino potrebbe tornare sull’Iran. Ma stavolta la connivenza logistica delle petrolmonarchie potrebbe non essere scontata, tanto più alla luce del rafforzamento militare di Teheran procurato da Mosca e con Pechino che non gioirebbe nel vanificare gli investimenti fatti nella Repubblica islamica.
In conclusione, abbondano i motivi per essere scettici sulla tregua, nella prospettiva di un assetto pacificato in tutta l’area. Ma il dubbio va esercitato non per un pessimismo vanamente passivo: piuttosto si tratta di una vigilante attenzione sugli sviluppi. La mobilitazione dal basso delle coscienze, preparata da uno sguardo consapevole sulle vicende, ha dimostrato di poter fare più di quanto le omissioni e le complicità dall’alto vieterebbero di osare.