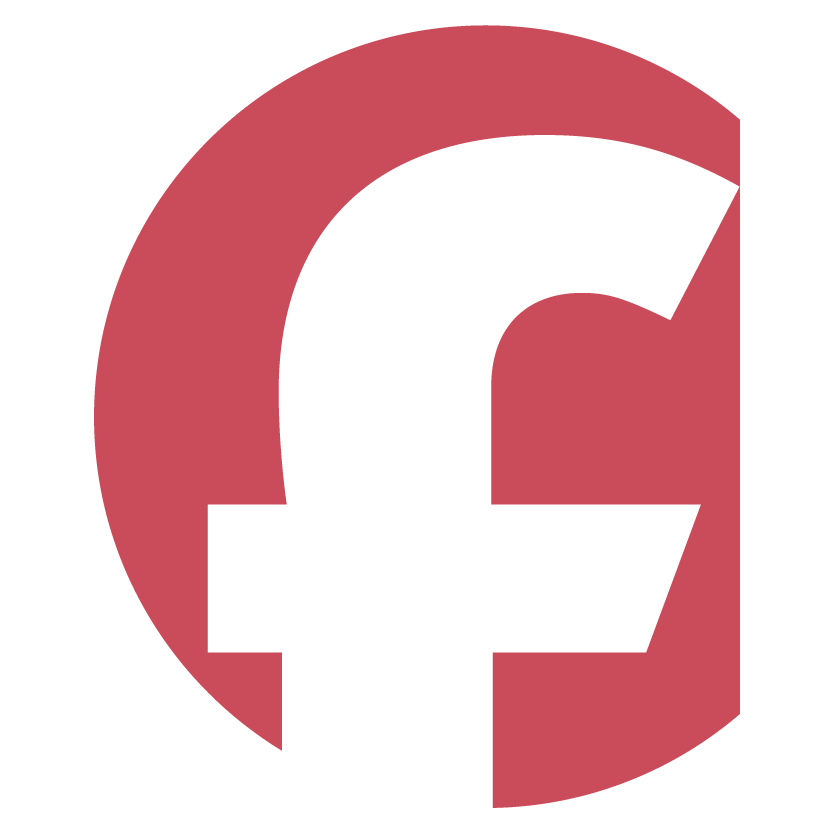La sentenza pronunciata dal giudice Antonella Crea giovedì 26 giugno è storica. «Lo è per una serie di motivi – argomenta Claudia Marcolungo, docente di diritto ambientale all’Università di Padova – Anzitutto perché è la prima pronuncia di tipo penale su un caso di inquinamento da Pfas, nel nostro Paese ma anche in Europa. In secondo luogo perché riguarda la più grande contaminazione al mondo di queste sostanze. In terzo luogo perché i lavoratori Miteni sono le persone con il maggior tasso di Pfas nel sangue che si siano mai registrati. Infine perché, riguardando la seconda falda acquifera più grande d’Europa, ha prodotto una popolazione contaminata di almeno 350 mila individui: in questa vicenda tutto ha proporzioni enormi».
A proposito dei lavoratori Miteni, sono loro i grandi esclusi dai risarcimenti previsti per le parti civili?
«Per comprendere questa esclusione occorrerà leggere le motivazioni (la corte ha 90 giorni di tempo per depisitarle, ndr). Ma occorre considerare che questo procedimento muoveva dai titoli di reato di avvelenamento delle acque e disastro ambientale, quindi per lo sversamento nelle acque sotterranee e superficiali delle sostanze a danno dei residenti nel plume della contaminazione, mentre i lavoratori hanno inalato le sostanze in fase di produzione e spesso hanno provenienze differenti. Di certo, ora si apre la via dell’Appello oltre alla possibilità di altre richieste di risarcimento, per le quali la riconosciuta responsabilità dei condannati costituisce un precedente importante».
Come interpretare la condanna delle multinazionali Mitsubishi e Icig a compartecipare in solido al pagamento dei danni?
«La giudice Crea ha chiamato le imprese a risarcire i danni comprovati: si tratta di somme già spese, per esempio dal Ministero dell’ambiente o dalla Regione, per far fronte all’emergenza, oltre ai danni documentati dalle parti civili che avranno un indennizzo. Sulle due multinazionali pende tuttavia un altro procedimento, questa volta di carattere amministrativo, aperto dalla Provincia di Vicenza dopo il fallimento di Miteni, finalizzato alla messa in sicurezza e la bonifica dell’area industriale di Trissino. Vedremo che esiti avrà».
Quali effetti avrà questa sentenza su altri procedimenti di diritto ambientale in Italia?
«Sarà certamente presa in considerazione da altri giudici perché per la prima volta viene riconosciuto il dolo nell’avvelenamento delle acque da parte del management di un’impresa chimica con il fine del profitto. In Italia l’unico precedente sta in una sentenza del 19 gennaio 2021 riguardante un caso di criminalità organizzata in Campania. Ci sono poi elementi di consistente originalità in questo processo, a partire dalla ricostruzione della vicenda aziendale, gestita dalle controllanti Mitsubishi e Icig, fatta dal pubblico ministero Hans Roderick Blattner e accolta dalla corte. Il pm ha dimostrato come Miteni eludesse i costi ambientali, nel suo bilancio non compaiono voci di spesa per evitare o ridurre l’inquinamento, traendo così benefici economici e godendo di un vantaggio sui concorrenti. Si tratta di una lettura innovativa che unisce vari ambiti del diritto, quello ambientale come quello della concorrenza, che ha dimostrato le finalità illecite e quindi il dolo nel comportamento dei condannati, tanto più in un momento storico in cui la normativa in tema di rispetto per l’ambiente e trasparenza di gestione aumentano anche in ambito comunitario».
Infine c’è il delicato tema dei controllori. Comprovata la responsabilità dei condannati, perché nessun ente preposto ha verificato e bloccato l’attività di Miteni prima che si creasse questa situazione?
«Gli avvocati difensori, nelle numerose udienze del processo, hanno più volte sottolineato come la mancanza di norme e di controlli scagionasse di fatto i loro assistiti. Questo concetto non tiene in ambito di diritto ambientale, tanto più che fin dalla fine degli anni Novanta Miteni scambiava dati e possibili effetti dell’inquinamento con i colleghi nell’ambito di Plastic Europe, un gruppo di produttori europei di sostanze perfluoroalchiliche. Rimane la domanda: chi doveva controllare lo ha fatto? Non come avrebbe dovuto. Nonostante i dati in possesso di Arpav, all’inizio della vicenda la politica regionale ha tacciato di allarmismo attivisti e ong ambientaliste che chiedevano chiarezza sul caso. Quando Mamme No Pfas e Greenpeace hanno chiesto l’accesso agli atti per avere i risultati del biomonitoraggio sulla popolazione e i dati sugli alimenti, la Regione Veneto ha fatto resistenza, diffondendoli solo dopo la condanna del Tar del Veneto che ha sanzionato la volontà di mantenerli riservati. Infine, durante il processo è emerso come non sia stato condotto un vero studio epidemiologico, seppur già protocollato dai dottori Comba e Merler e in parte finanziato presso l’Istituto superiore di sanità, perché la Regione non ha mai deliberato la spesa di 250 mila euro per realizzarlo. Tra le altre questioni che tuttora rimangono aperte, ci sono quella irrigua per le aziende agricole e gli allevamenti e la mappa, ancora non realizzata, dei luoghi inquinati».