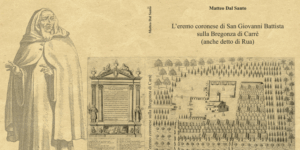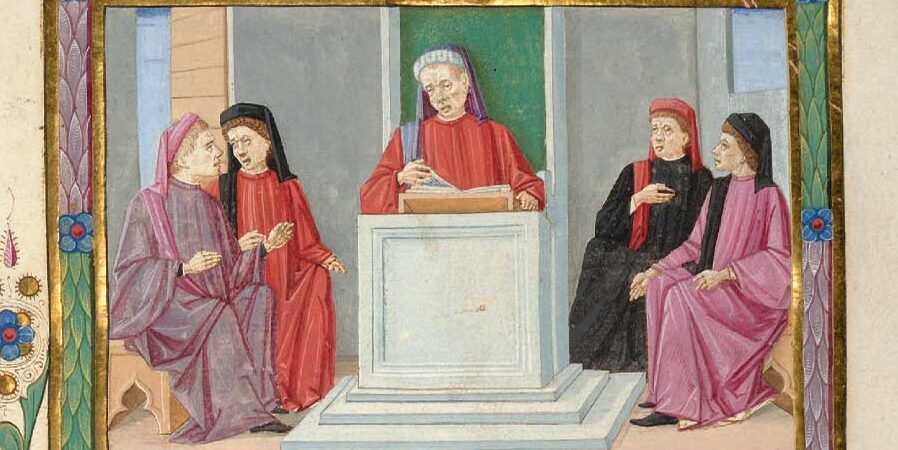
Due istituzioni fondamentali per Padova, strettamente intrecciate fin dalle origini: a raccontarne le vicende è il volume Università e Chiesa a Padova (secoli XIII-XX). Spazi, interazioni, conflitti, pubblicato dall’Istituto per la storia ecclesiastica padovana e presentato venerdì 24 settembre al Collegio Sacro del palazzo Vescovile. Un libro ricco e corale, curato da Stefano Dal Santo e Antonella Barzazi, che raccoglie gli atti del convegno svoltosi il 29 e 30 settembre 2022 per gli 800 anni dello Studium patavinum. «Più che di scoprire cose nuove – spiega mons. Stefano Dal Santo, docente di Storia della Chiesa presso la Facoltà teologica del Triveneto e direttore dell’Istituto per la storia ecclesiastica e dell’Archivio storico diocesano – si è trattato di dare unità e completezza a fatti e conoscenze spesso tramandati in modo frammentario, offrendone grazie alle competenze dei diversi autori una sintesi solida e scientificamente fondata».
Le radici del legame tra la cattedra di San Prosdocimo e università affondano nel Duecento, quando il vescovo Giordano da Modena favorisce la migratio da Bologna di studenti e professori, lasciando in eredità ai suoi successori il ruolo di cancellieri dell’ateneo, con il compito di presiedere gli esami di laurea e di conferire i gradi accademici: tradizione testimoniata da centinaia di verbali conservati da secoli nell’Archivio storico diocesano. Sarà il suo successore Giovanni Battista Forzaté a ottenere nel 1264 da papa Urbano IV la conferma dello statuto approvato da studenti e rettori, mentre nel 1363 Roma riconosce anche la facoltà di teologia, dotando Padova di tutti i saperi tipici dell’università medievale.
Dal Quattrocento in poi, con l’ingresso della città nell’orbita veneziana, la Serenissima si dedica con interesse crescente alla prosperità dell’università, senza però entrare in conflitto con la Chiesa: «Per secoli i vescovi di Terraferma saranno quasi sempre patrizi veneziani, buoni pastori e al tempo stesso amministratori efficaci, anche per quanto riguarda l’ateneo – osserva lo storico – Del resto la Serenissima sarà sempre consapevole del rapporto tra buon governo della Chiesa e bene dello Stato».
La Chiesa dunque, al di là di miti e leggende nere, ha un ruolo essenziale nella nascita e nello sviluppo della patavina libertas, in una relazione con la comunità studentesca e accademica vivace e a volte dialettica, indagata dal volume sotto diversi aspetti: da quelli artistici – in cui l’arte diventa veicolo di pensiero e dialogo tra fede e cultura – a quelli più propriamente istituzionali e teologici. Un rapporto proficuo ma a volte problematico, che entra in crisi nell’Ottocento: prima con le leggi napoleoniche del 1806, che privano il vescovo di Padova del suo ruolo storico, in seguito con l’annessione del Veneto al Regno d’Italia nel 1866. Nel 1873 arriva infine la soppressione delle facoltà di teologia dalle università statali italiane.
Non mancheranno i tentativi di recupero, come quello del 1922 documentato dal saggio di Liliana Billanovich, quando il vescovo Luigi Pellizzo (“padre” tra le altre cose della Difesa del popolo) tenta di trasformare, in un’epoca di forte anticlericalismo, il settimo centenario dell’ateneo in un’occasione d’incontro e di dialogo. «Oggi i tempi sono decisamente più sereni – sottolinea mons. Dal Santo – Dagli anni Sessanta, grazie anche alla nascita della rivista Studia Patavina e alla fondazione del nostro Istituto, si afferma ad esempio una collaborazione matura tra Ateneo e Seminario anche in ambito scientifico. Il fatto che questo volume riunisca studiosi di diversa formazione e appartenenza è la prova di un dialogo vivo, fondato sul rispetto reciproco e sul rigore».
Una storia fatta insomma di interazioni e fecondazioni reciproche. Otto secoli dimostrano come Università e Chiesa, pur percorse da tensioni e cambiamenti, abbiano a lungo camminato insieme lungo la stessa strada del sapere, parti di una stessa comunità intellettuale e civile.