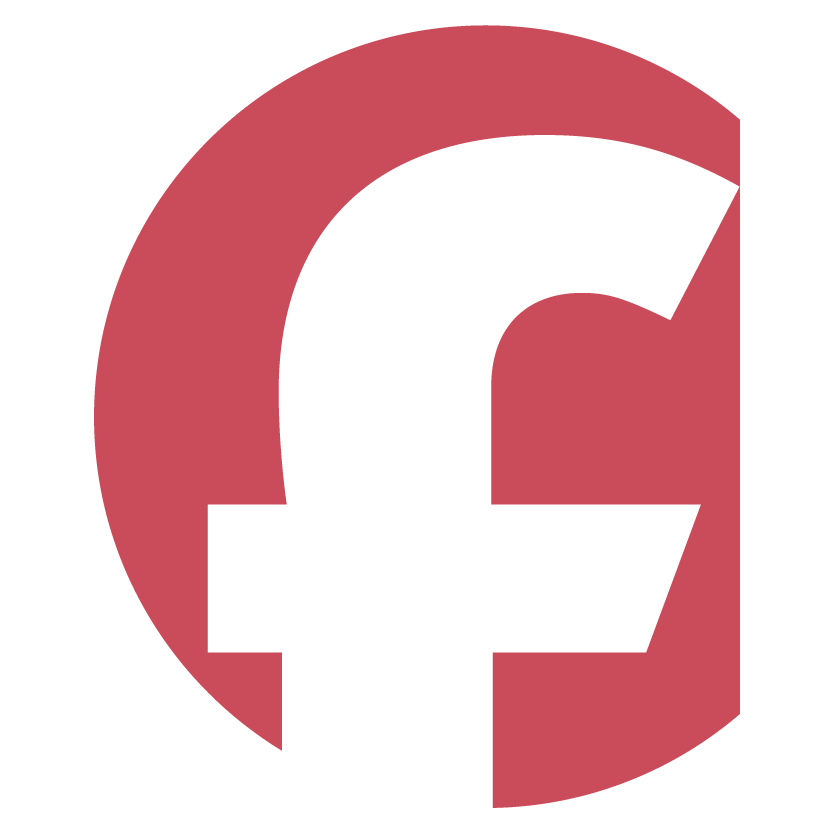I colloqui separati svolti a Miami tra le delegazioni di Ucraina e Russia e gli inviati speciali di Trump si sono conclusi con una fumata grigia. Non possiamo definirla nera, poiché emergono indizi che consentono di parlare di timidi progressi, nonostante la permanenza di nodi critici. Importanti elementi rivelatori per gli sviluppi dei negoziati sono desumibili da quanto è avvenuto non soltanto dentro le stanze del confronto diplomatico.
Ovviamente permangono gli scogli. Oltre alle questioni territoriali, resta la richiesta russa di addivenire a una soluzione soltanto con un presidente ucraino regolarmente eletto, stante il mandato abbondantemente scaduto di Zelensky, paventando che in futuro gli accordi possano essere ricusati per illegittima sottoscrizione. Inoltre Mosca continua a respingere la clausola promossa di nuovo dai Volenterosi in merito al dispiegamento di una forza multinazionale occidentale sul territorio ucraino, che secondo il Cremlino, stante la natura non neutrale, si ostina a far rientrare dalla finestra una Nato apparentemente uscita dalla porta.
Ma finalmente inizia a farsi spazio il concetto di una definizione di condizioni durature per la fine del conflitto e il dopoguerra, in luogo di una mera tregua.
Ciò è avvalorato dalle aperture degli Usa a precisare le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, superando i contorni di vaghezza in precedenza proposti. Ancor più rileva l’abbrivio di un’agenda lineare di trattative, a carattere presumibilmente progressivo, che dalla Florida dovrebbe proseguire in altri appuntamenti: cosa di non poco conto, a fronte dell’incedere episodico e sincopato – disordinato è dire poco – in cui tutte le parti si sono esibite sinora.
Lontano dai tavoli degli incontri, invece, sono emersi aspetti che certificano la volontà di sabotare i percorsi negoziali. Ancora una volta sono intervenute voci esterne, che assieme a nefaste fughe di notizie, sono occorse in questi ultimi quattro anni con puntualità, a ogni pur timida iniziativa di accordo. All’avvio dei colloqui la notizia lanciata da Reuters sulle intenzioni di Mosca di occupare tutta l’Ucraina e di invadere nel 2027 porzioni europee dell’ex territorio sovietico (presumibilmente i Paesi baltici) ha indicato, come fonti, rumors provenienti dagli apparati Usa. Dice molto la reazione veemente di Gabbard, direttrice della National Intelligence, contro coloro che, dall’interno del deep state, cospirano con quanti mirano a inibire i delicati ponti del dialogo per trascinare Washington in guerra. E i riscontri non sembrano mancare, a giudicare dai contrasti intestini al Pentagono e alle passate frizioni fra Trump e i vertici Cia.

Con simile lente si legge l’ennesima autobomba esplosa a Mosca. Stavolta, non appena conclusi gli incontri a Miami, a saltare in aria è stato il generale Sarvarov, responsabile dello stato maggiore dell’esercito per l’addestramento operativo. Anche in questo caso, il tempismo è esplicativo.
Il tempismo che invece va accolto con speranza è quello con cui Macron ha parlato dell’esigenza di riaprire alle relazioni diplomatiche tra Europa e Russia, ottenendo dal Cremlino la disponibilità ad approntare a stretto giro un vertice bilaterale con il leader francese. Macron è stato l’ultimo dei governanti europei a incontrare Putin alla vigilia della guerra. Ora l’Eliseo torna alla postura degli esordi, non celando di temere che, in caso di un ennesimo fallimento negoziale, la Casa Bianca possa sfilarsi definitivamente, lasciando l’Europa con il cerino in mano. Non a caso, nella prospettiva del più generale disancoraggio dalla Ue tratteggiato dalla strategia di Trump, Macron è recentemente volato a Pechino.
Oltretutto, essendo l’unica potenza nucleare autocefala del continente (le chiavi dell’arsenale britannico sono a Washington), Parigi avverte il bisogno di assumere una leadership più pragmatica, per non farsi trascinare verso il precipizio dai sodali più agguerriti ma di gran lunga meno armati. Questo basta a prendere le distanze dagli studi che, per esempio in Norvegia, suggeriscono di continuare a foraggiare l’Ucraina in guerra anziché farsi carico in toto dello Stato fallito, con un costo ben più esoso se il conflitto si chiudesse oggi.

Con le esternazioni degli ultimi giorni, il governo francese sembra ispirare posizioni meno allineate anche rispetto alla Germania. Mentre si apriva il tavolo di Miami, Macron, infatti, ha sottratto il sostegno alla proposta massimalista di Merz e von der Leyen, intesa a utilizzare i 210 mld di euro gli asset russi congelati per finanziare Kiev.
Lo smarcamento sembra avere determinato la deliberazione “al ribasso” nel Consiglio europeo (per giunta con voto a maggioranza, secondo una discutibile applicazione dell’art. 122 del Trattato Ue): un prestito di 90 mld senza interessi per il biennio 2026-7, sostanzialmente a fondo perduto, vista l’impossibilità per Kiev di rifonderlo, lasciando in sospeso anche la configurazione dei beni russi quale garanzia per le riparazioni di guerra che si richiedono alla Russia anche in caso di vittoria. In argomento sono certamente i danni che il sequestro già inizia a provocare all’affidabilità del mercato finanziario europeo, dati i cenni di flessione degli investimenti dalle petrolmonarchie arabe e dal sudest asiatico, resi così più inclini ai titoli denominati in dollari. Ma si tratta più realisticamente di un problema di sostenibilità, dissimulato dalla soddisfazione ostentata a denti stretti da Merz per la tenuta garantita nel prossimo biennio di guerra.


Infatti è Zelensky stesso a far notare opportunamente che la somma non basta: servirebbero almeno 140 mld annui per evitare che l’intero sistema ucraino vada in panne.
Le risorse europee scarseggiano, mentre le vite si spengono nel drammatico teatro ucraino. Così la Francia comincia forse a rimodulare l’azione, facendosi capofila di una strategia più costruttiva, dopo la lunga latitanza della diplomazia, sovente scoordinata, e ancora scardinata dai roboanti preannunci di un’inevitabile guerra esistenziale. Forse l’iniziativa di Miami ha aperto un cantiere propizio. Nel complesso, anche indirettamente, può avere infuso maggiore consapevolezza sulla necessità di ricostruire il nerbo lungimirante delle responsabilità politiche, senza il quale non v’è costruzione di pace. Per accorgersene basta guardarsi indietro, avendo appena alle spalle il ’900 con la sua guerra mondiale in due tempi.