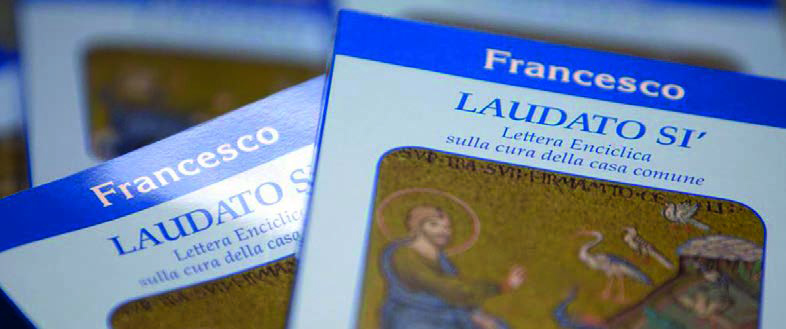
Dieci anni sono passati dall’enciclica Laudato si’, sulla cura della casa comune e ora ci troviamo a ripensarne la forza, proprio mentre Francesco, che ce l’ha donata, contempla il volto del Creatore. Dieci anni nei quali abbiamo imparato a cogliere quanto centrali siano i temi che essa ci ha consegnato: crisi socio-ambientale, teologia della creazione, ecologia integrale. Non si tratta certo di elementi completamente nuovi: la stessa Laudato si’ è ricca di richiami al magistero dei pontefici immediatamente precedenti, mentre la riflessione ecumenica su tali tematiche risale ancora agli anni Settanta del secolo scorso. E tuttavia Francesco ha saputo rilanciarli con tale forza ed efficacia da “bucare lo schermo”, riportandoli al centro dell’attenzione delle Chiese cristiane e della stessa opinione pubblica. Negli anni successivi poi ha mantenuto forte l’attenzione su di essi con numerosi altri testi e interventi: si pensi al terzo capitolo dell’esortazione apostolica post-sinodale Querida Amazonìa, a molti messaggi per la Giornata mondiale della pace e per il Tempo del Creato e, soprattutto, all’esortazione apostolica Laudate Deum sulla crisi climatica del 2023. Perché Francesco è stato acutamente conscio della drammaticità della crisi, del suo impatto sulle vite di tanti uomini e donne – i poveri in primo luogo – del grido della madre terra che patisce violenza. I suoi appelli nascevano anche dalla percezione di un’urgenza che gli anni trascorsi dalla Laudato si’ hanno solo reso più forte; dal senso di ingiustizia dinanzi a un degrado ambientale che impatta in primo luogo su persone e popoli che meno ne sono responsabili. L’invito alla responsabilità personale e alla pratica di stili di vita leggeri e a basso impatto si saldava così con l’interpellazione alla politica e all’economia, per la costruzione di società sostenibili e decarbonizzate, per il superamento della prospettiva dello scarto a favore di un’efficace circolarità.
Sbaglierebbe, però, chi cogliesse in Francesco solo una tra le tante voci che vanno lodevolmente richiamando a un orizzonte etico-ambientale. La Laudato si’ è stata potente anche dal punto di vista teologico, con la sua attenzione per la confessione di Dio in quanto creatore, fonte di vita, origine di un mondo che è bello – sette volte bello secondo Genesi 1 – anche per la ricca biodiversità che lo abita. Un mondo che può certo essere studiato come “natura”, ma che la parola “creazione” invita a cogliere come espressione di una misericordia fondante, di una tenerezza e di una cura rivolte a ogni creatura. Un mondo, ancora, che è comunità di creazione: “tutto è connesso” ripete più volte l’enciclica, a richiamare una relazionalità che esprime la realtà di un Dio che è lui stesso relazione. Questo il senso dell’ecologia integrale; qui si innesta l’invito di Francesco a vivere una densa spiritualità della creazione, innervando di essa la vita liturgica e la preghiera personale, ma avviando anche processi di conversione ecologica nell’esistenza delle comunità. Corrispondere all’amore del Dio trino significa anche amare la terra che Egli ci ha donato e abitarla in modo responsabile, custodendola e coltivandola, come amministratori chiamati a renderne conto – e non come despoti che la usano e ne abusano. È una sfida che Francesco lascia in eredità a tutte le comunità cristiane e al mondo delle religioni, ma anche a ogni persona che abita questo pianeta: che mondo vogliamo lasciare alle prossime generazioni, ai bambini e alle bambine che stanno crescendo? A noi la risposta.
L’enciclica è composta da sei capitoli e una intro
La Laudato si’ è la seconda enciclica di papa Francesco scritta nel suo terzo anno di pontificato. Porta la data del 24 maggio 2015, anche se il testo è stato reso pubblico il 18 giugno successivo. L’argomento principale è l’interconnessione tra crisi ambientale della Terra e crisi sociale dell’umanità, ossia l’ecologia integrale: «Non si tratta di un’enciclica verde ma di un’enciclica sociale», aveva infatti affermato Bergoglio.
Lo spunto. La grande sfida culturale della Chiesa sul clima
di Riccardo Benotti
«Il contributo che i cristiani potranno dare con l’ecologia integrale genererà speranza». A dirlo è Tebaldo Vinciguerra, officiale del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, in occasione del decimo anniversario dell’enciclica Laudato si’. «L’uso solidale e sostenibile della risorsa acqua è indubbiamente una questione importantissima e trasversale nell’enciclica, che concerne sia gli oceani sia l’acqua dolce, e sulla quale il Dicastero lavora spesso. Siamo ancora lontanissimi dall’accesso universale all’acqua potabile, e ciò malgrado il fatto che il riconoscimento dell’accesso all’acqua potabile quale diritto umano da parte dell’Onu risalga al 2010! Una vergogna. L’enciclica ribadisce il valore intrinseco della biodiversità e degli ecosistemi. Vanno cioè per quanto possibile rispettati “anche se a me non fa direttamente comodo”, anche se “non sono in ballo né la mia reputazione né il mio fatturato”. la Laudato si’ interpella il credente, lo esorta a rispondere alla domanda “chi me lo fa fare?” partendo dalla propria fede».




