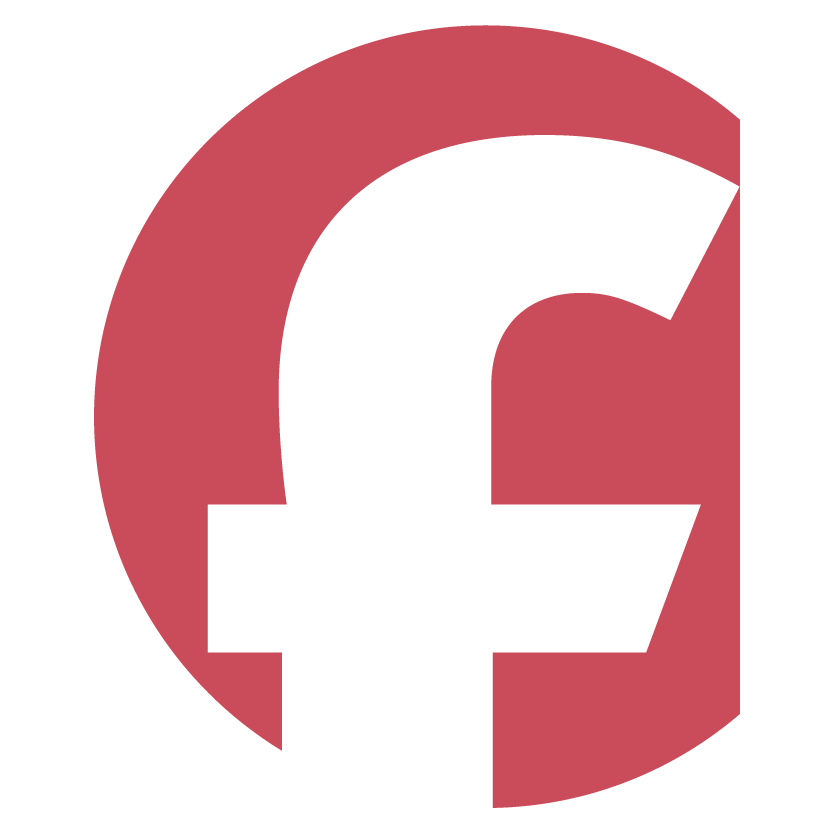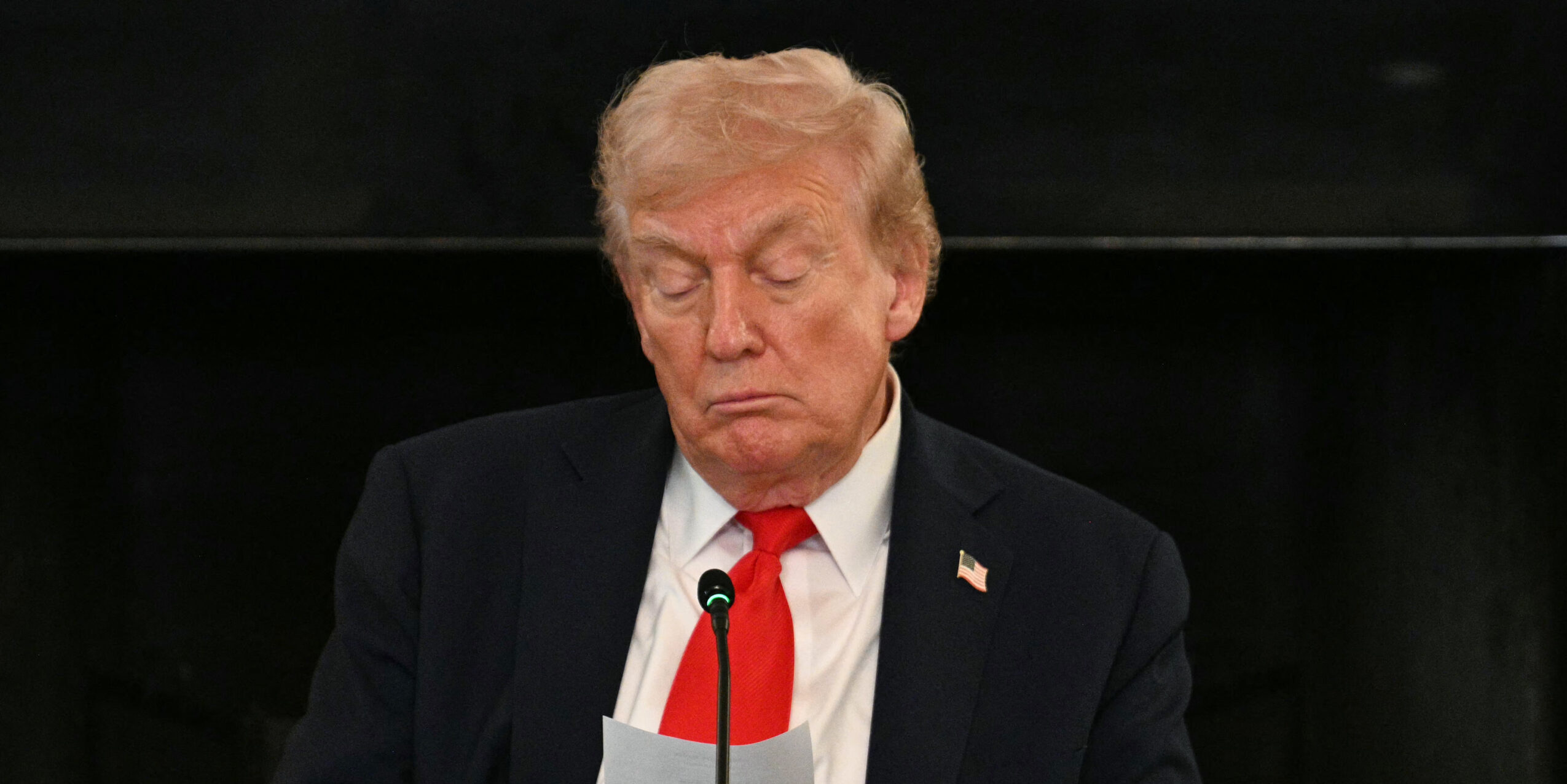
Le sanzioni di Trump ai due maggiori gruppi petroliferi russi serviranno alla tregua? Gli annunci enfatici dicono di sì, che metteranno in ginocchio l’economia di Mosca: finalmente l’asso nella manica, quello decisivo, dopo la serie di svolte proclamate in oltre tre anni di guerra. Tanto più se sono vere le notizie sulla sospensione delle importazioni cinesi e indiane.
Eppure non mancano elementi per smorzare gli entusiasmi atlantisti. Il dispositivo sanzionatorio ha effetto solo sui traffici in dollari e i relativi sistemi di pagamento. E dal 2015 la Cina, per acquistare greggio iraniano, ha sviluppato i metodi di aggiramento, per giunta volgendoli contro il sanzionatore, mediante la dedollarizzazione degli scambi che tanto preoccupa Washington. Il meccanismo si avvale di una rete di accorgimenti – coperti dalle garanzie bancarie e assicurative ad hoc – facenti perno sulle “teiere”: compagnie petrolifere private autorizzate da Pechino per eludere l’imputabilità delle sanzioni cui sono esposte quelle pubbliche. Similmente l’India, capace di aumentare l’import grazie a espedienti analoghi. Sicché la sospensione di cui si vocifera potrebbe servire a riformulare i contratti, anche per recepire l’esempio del commercio sino-iraniano, che sostituisce parte dei pagamenti con investimenti a casa del creditore. In effetti, neanche Biden ottenne granché con la leva sul greggio russo. L’effetto immediato è però il rincaro del barile sui mercati internazionali, che penalizzano più di altri gli importatori netti in Europa. A meno che l’Opec non accetti all’unanimità di aumentare la produzione, cosa che non avvenne quando i sauditi risposero picche alla richiesta così avanzata dall’ex inquilino della Casa Bianca.
Intanto Kiev, oltre agli stoccaggi russi, colpisce i gasdotti che riforniscono l’est Europa, mentre il fuoco divampa in Ungheria, Slovacchia e Romania, nelle raffinerie che lavorano il greggio del nemico.
Gli idrocarburi continuano a essere un asse portante di questa guerra, evidenziando altresì le spaccature europee. Il tribunale di Varsavia ha negato l’estradizione in Germania di uno dei sabotatori ucraini del NordStream, definendo l’attentato una giusta azione patriottica. Il premier Tusk plaude, definendo l’esistenza stessa del NordStream come “peccato originale”. Ciò è bastato a riaccendere le proteste di quanti, oltre al tweet di ringraziamento rivolto agli Usa dall’ex ministro Sikorski dopo l’esplosione, ricordano il varo concomitante del tubo tra Norvegia e Polonia. Altre voci chiedono lo scongelamento della procedura preistruita da Bruxelles per la subordinazione della magistratura polacca al governo, sospesa dal 2022 in virtù delle benemerenze belliche di Varsavia. Polemiche a parte, la motivazione del tribunale polacco rivela l’anomia in seno alla Nato, dove gli atti in danno agli alleati vengono giustificati, se funzionali ai propri interessi. Peraltro l’argomento della “punizione patriottica” si presterebbe ad avallare future ritorsioni delle frange ultranazionaliste ucraine contro i Paesi accusati di scarso impegno.
Simili allarmismi alimentano gli strali di Ungheria e Slovacchia contro la psicosi militarista agitata dai mestatori dei governi “volenterosi”, accusati di spingere sulla guerra a oltranza per speculare sul riarmo e rinviare il redde rationem politico dei loro fallimenti. D’altronde, gli esecutivi europei procedono in ordine sparso sulla spesa militare. In Italia la legge di bilancio sembra recepire il Prioritized Ukraine Requirements Lost che detta l’acquisto di armi Usa da trasferire a Kiev a fondo perduto. Ma non tutti i governi sono pronti ad aggiungere tale voce al 5% di pil per la Nato, visto il malessere per i rincari, i tagli al welfare e la crescita bloccata.
Se l’energia resta un fattore critico, quella spesa da Trump nell’atteggiarsi ostentatamente a “king of world” nascondono incertezze e impotenza. All’interno, con l’occhio al voto midterm del 2026, egli si trova stretto tra la base Maga, i neocon repubblicani e l’industria militare; all’esterno, senza perdere la presa padronale sull’Europa, cerca di usare bastone e carota per portare la Russia ad allentare l’abbraccio con la Cina propiziato da questa guerra. Ecco perché lo zig-sag sui Tomahawk, il profilo bifronte di paciere e mercante d’armi. Ecco perché commina le sanzioni sul petrolio russo dicendole “micidiali” un attimo dopo il rimbrotto a Zelensky, il quale non considera che dell’Ucraina non resterebbe nulla se la Russia imitasse il “destroy and go away” degli Usa in Iraq.
Ma la tattica di Trump, oltre a consumare credibilità, non sembra funzionare sulla postura russa, che ha ancora energia per avanzare su tutta la linea del fronte e mostrare all’Occidente il Burevestnik, prototipo di cruise a propulsione nucleare con gittata illimitata: manovrato nel test sull’Artico per 15 ore, capace di volare a tempo indefinito in attesa di puntare sull’obiettivo da qualsiasi latitudine. È uno dei progetti rispolverati da quando gli Usa si sono ritirati dal Trattato Inf, a riprova del vantaggio deterrente cui alludeva Putin anni fa. Su queste basi, l’arma spuntata del “tira e molla” trumpiano lascia intatti i nodi di una guerra non così aborrita come si vorrebbe credere.