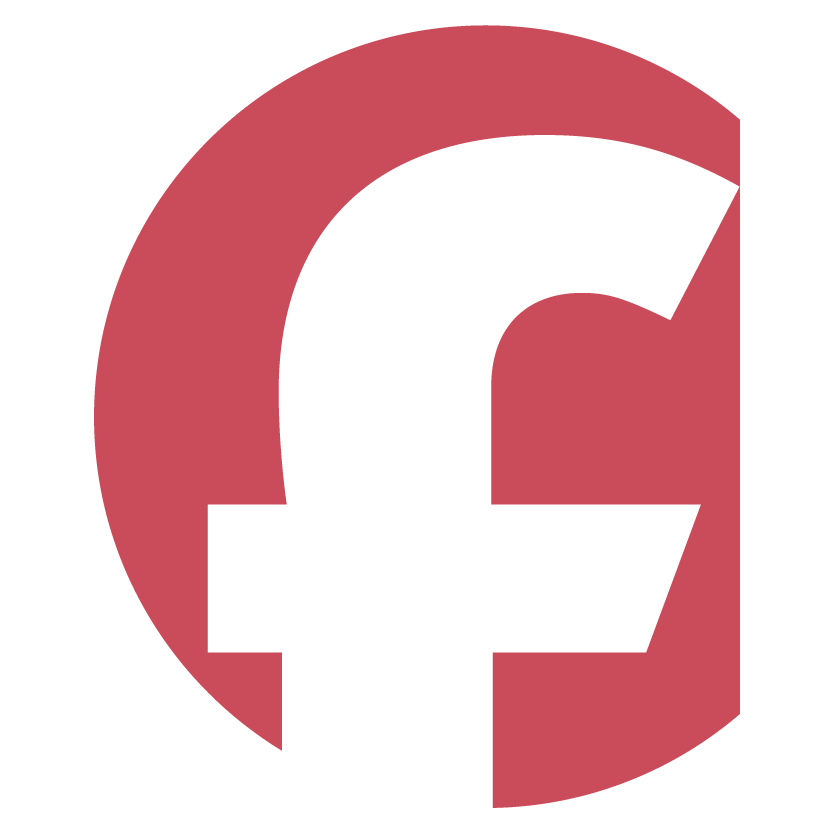È tornata la calma in Madagascar dopo giorni tumultuosi, iniziati il 25 settembre con le proteste di piazza dei giovani della Generazione Z, che chiedevano acqua, elettricità e borse di studio. Il governo del presidente Andry Rajoelina, salito al potere per la prima volta con un golpe nel 2009, ha represso con la forza le manifestazioni, causando 22 morti e un centinaio di feriti. I giovani hanno chiesto le dimissioni di Rajoelina, che è fuggito all’estero, probabilmente con l’aiuto della Francia (il Madagascar è una ex colonia francese). Il Capsat, una unità delle forze speciali dell’esercito malgascio, si è ammutinato e ha appoggiato le proteste dei giovani. Il 17 ottobre si è arrivati così alla nomina del nuovo presidente, il colonnello Michael Randrianirina (capo del Capsat), che ha prestato giuramento il 17 ottobre nella capitale Antananarivo e promesso una transizione democratica, una nuova Costituzione ed elezioni. Oggi è stato nominato il primo ministro Herintsalama Rajaonarivelo, un manager di lungo corso, che conferma la volontà della nuova dirigenza di puntare sulla ripresa economica e di rassicurare investitori e partner internazionali. Ma sui social qualcuno ha già evidenziato i suoi legami con l’ex presidente Andry Rajoelina. Della “crisi prevedibile” abbiamo parlato con monsignor Marie Fabien Raharilamboniaina, vescovo di Morondava e presidente della Conferenza episcopale del Madagascar.
Come avete vissuto questi giorni tumultuosi?
Siamo sorpresi dalla velocità con cui è evoluta la rivoluzione, ma
da tre anni stiamo allertando le autorità sul deterioramento della situazione socio-politica in Madagascar. C’è povertà, corruzione e repressione della libertà di espressione.
Si stanno realizzando progetti, ma si tratta di una facciata di sviluppo che non risolve i problemi quotidiani della maggioranza. Lo Stato ha costruito la palestra e la funivia, mentre le condizioni stradali sono pessime e le interruzioni di corrente causano sofferenze quotidiane a famiglie e studenti. Sembra che lo Stato si stia prendendo cura delle famiglie ricche e non di quelle povere. Il Presidente della Repubblica Rajoelina ha scelto acqua ed elettricità come parole chiave della sua campagna elettorale, mentre il Madagascar ora vive nell’oscurità.
Come si pone la Chiesa del Madagascar di fronte a questo grande cambiamento politico?
La Conferenza episcopale ha chiaramente evidenziato questi problemi, dichiarando il fallimento del governo. La crisi era prevedibile. La protesta è iniziata con la richiesta di acqua, elettricità e borse di studio. Ma la risposta del governo è stata violenta, provocando una ventina di morti, secondo le Nazioni Unite, e diversi feriti. L’atteggiamento del governo è stato: “soffrite e tacete”. La situazione è peggiorata e lo Stato si è trovato ad affrontare la rabbia della popolazione. Ci sono stati saccheggi nei negozi. Le richieste si sono trasformate in un grido per le dimissioni del presidente Rajoelina, che non ha mantenuto le promesse. I giovani lo hanno preso in parola e le sue dimissioni sono state l’unica soluzione. I giovani non hanno più fiducia nel Presidente. Per sette anni non ha elaborato un piano, come avrebbe potuto risolvere questi problemi? Il presidente Rajoelina ha insistito nel chiedere perdono e nel fare promesse, ma i giovani hanno continuato a chiedere a gran voce le sue dimissioni, finché è fuggito all’estero. La Conferenza episcopale ha indetto una giornata di preghiera e digiuno per la pace in Madagascar. Abbiamo condannato la violenza e invitato le autorità a rispettare la libertà di espressione. Chiediamo che i giovani siano ascoltati e che i loro diritti fondamentali, come l’accesso all’acqua e all’elettricità, siano rispettati. I militari sono intervenuti per sostenere i giovani. E l’Alta Corte Costituzionale ha nominato Randrianirina il nuovo presidente del Madagascar, che ha prestato giuramento davanti ai membri dell’Alta Corte Costituzionale, alle forze armate, ai rappresentanti dei giovani, alle Chiese e al corpo diplomatico.

Il clima è positivo. C’è un desiderio di vivere in pace condiviso dalle varie entità, ma questa pace è molto fragile.
Ci sono molte domande senza risposta. Ma i giovani non abbandonano il nuovo presidente, costringendolo a presentare le tabelle di marcia e a stabilire una scadenza, soprattutto l’attuazione di progetti vitali, come la possibilità di avere acqua ed elettricità. Il nuovo presidente collabora con i giovani in ufficio e sul campo. I giovani stanno facendo pressione sulle autorità. Questa è una buona iniziativa.
Cosa preme di più ai giovani?
La rivoluzione è iniziata con la richiesta di diritti fondamentali come acqua, elettricità e borse di studio. Ma hanno scoperto che la corruzione è la causa delle interruzioni di corrente e dei tagli idrici, e la richiesta si è trasformata in una rivoluzione contro le autorità.
Come in altri Paesi del mondo la Generazione Z ha avuto un ruolo importante nelle proteste, denunciando corruzione, povertà e ingiustizia sociale. Saranno finalmente ascoltati o rischia di essere un cambiamento solo nella gestione del potere?
I giovani e la popolazione vogliono un cambiamento profondo che eviti una crisi ciclica.

Chiedono soluzioni concrete, non promesse non mantenute.
I giovani criticano aspramente i politici che vogliono sfruttare il sistema. Vogliono uno sviluppo rapido, ma sostenibile e condiviso. Hanno intenzione di controllare lo Stato durante tutto il processo di attuazione. Insieme al presidente sono andati personalmente a verificare il sistema idrico ed elettrico per proporre una possibile soluzione.
Il fatto che i militari abbiano contribuito alla caduta del governo e ora il nuovo presidente è un colonnello è un rischio o una garanzia?
Sì, il presidente Michael Randrianirina è un militare. È sotto l’occhio vigile dei giovani perché l’evento non diventi politica politicizzata e per evitare passi falsi. Durante tutto il processo di transizione, dobbiamo definire chiaramente l’obiettivo e l’urgenza della sua attuazione.
Ci sono effettive speranze di democrazia e giustizia sociale per il Madagascar?

Credo nella saggezza del popolo malgascio. La nostra sfida è l’istruzione
e tra due anni la Conferenza episcopale presiederà il Simposio sull’Istruzione. La chiave della democrazia è un popolo istruito e la Chiesa cattolica svolge un ruolo importante nell’educazione a tutti i livelli. La nostra Conferenza episcopale dialoga con ogni entità e crea uno spazio di dialogo per trovare una via d’uscita.
Ci sono state influenze esterne verso un cambio di potere oppure si è trattato di un moto spontaneo interno alla popolazione?
Credo che il punto di partenza sia stata la richiesta di elementi vitali come acqua, elettricità e borse di studio. L’influenza esterna è la convinzione che i giovani possano cambiare la situazione, anche se sembra senza speranza.

Dobbiamo trovare una via di mezzo tra la dittatura dell’autorità e l’ingovernabile rivoluzione di piazza,
che rischia di creare confusione e di essere fonte di guerra. Preghiamo.