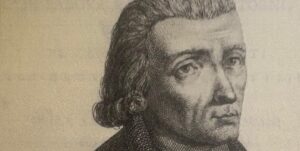Il sacro in musica, dal glorioso passato ai giorni nostri: un’ispirazione che si è fatta strada nei secoli, trovando via via il modo di raccontare in note i misteri della fede a pubblici distanti, nel tempo e nel modo di sentire. Una ricerca che l’arte compie da sé, con i propri mezzi, sovrapponendo il Verbo al linguaggio universale dei suoni, secondo una visione che unisce rigore ed estro creativo. Un volto fondamentale della spiritualità che la rassegna “In Principio”, promossa dall’Orchestra di Padova e del Veneto, in collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia della Diocesi di Padova e le parrocchie del Centro storico, indaga da nove edizioni. Quella in programma dal 5 al 26 settembre, s’intitola “Passio” e, tramite il genere omonimo, individua nuovi affascinanti confronti/nessi fra le epoche. Ne abbiamo parlato con il direttore musicale e artistico di Opv, il maestro Marco Angius.
Quale lo spazio dell’innovazione e quale quello della tradizione del linguaggio in questa rassegna?
«È stata da sempre la cifra di “In principio”. Il prossimo anno festeggeremo i 10 anni di questa rassegna, unica in Italia, che approfondisce il repertorio sacro e liturgico delle varie epoche utilizzando i mezzi di un’orchestra. L’originalità consiste, appunto, nell’intrecciare i programmi tradizionali con un linguaggio più vicino ai nostri tempi, con cui normalmente non si identifica la musica sacra: la novità, condivisa con la Diocesi, è dare un’idea di cosa potrebbe essere oggi un’ispirazione sacra per la creatività musicale».
Il genere musicale “Passio”, titolo di questa edizione, come viene interpretato nel tempo? «Ho scelto il titolo in latino perché è molto significativo e ricorrente nella musica di tutti i tempi. Quando diciamo “Passione” pensiamo soprattutto alle grandi Passioni bachiane: quello dell’oratorio è un genere parzialmente rappresentativo – in qualche modo parallelo allo sviluppo dell’opera – che si svolgeva, dal tardo Cinquecento in poi, nelle chiese e aveva un significato educativo, ovviamente, però dava l’opportunità ai compositori di giungere fino alla soglia della rappresentazione vera e propria. Il Novecento è un secolo di crisi, di decadenza, per alcuni aspetti, e per altri di rilettura del passato. Sono dunque arrivato a questa idea di “Passio” sia vocale che strumentale».
Come si articolerà il cartellone? «Si apre con le Sette Parole di Sofija Gubaidulina (5 settembre, ndr), compositrice russa recentemente scomparsa, tra le figure più importanti del Novecento musicale, la quale ha creato una sorta di stilizzazione della Passione, affidandola non a delle voci ma a degli strumenti che recitano: una fisarmonica (Gubaidulina scrive la parte per bayan, fisarmonica russa) e un violoncello solisti, qui suonati rispettivamente dai giovani talenti Samuele Telari e Michele Marco Rossi, mentre a dirigere sarà Caterina Centofante. Al lavoro della Gubaidulina ho accostato il tardo Settecento viennese con la Sinfonia n. 49, La Passione, di Haydn. Dall’altra polarità c’è il doppio concerto conclusivo (25 e 26 settembre, ndr) con “La Passione” di Malipiero, in prima esecuzione nella città del Santo, un lavoro del 1935 che fa parte della Trilogia Mistica (ossia La Cena, La Passione e il San Francesco d’Assisi) e di un percorso che stiamo realizzando sulla figura di Gian Francesco Malipiero, grande compositore e intellettuale ma, soprattutto, quasi un umanista del Novecento. Vorrei che a Padova vi fosse un laboratorio dedicato permanente, come per Rossini a Pesaro e Verdi a Parma. Il concerto sarà diretto da Mimma Campanale e vedrà la presenza del coro Iris Ensemble di Marina Malavasi. Il 12 settembre con l’organista Alessandro Perin e Nima Keshavarzi, direttore di origini persiane: saranno eseguiti il quarto concerto per organo di Händel, quello di Poulenc e la Sinfonia n. 6 “degli archi” di Malipiero. Con questi appuntamenti si può tracciare un percorso dal tardo Seicento strumentale fino, praticamente, al nostro tempo».