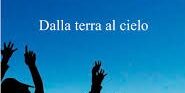C’è una parola presente in tutte le lingue del mondo: è pane, cibo ma soprattutto scrigno di saperi e tradizioni. Ad aprire questo forziere ci pensa il panificatore e volto televisivo Fulvio Marino in libreria con Tutto il mondo del pane (Slow Food, 256 pagine), in cui ripercorre con i lettori quindici anni di viaggi lavorativi tra tecniche di panificazione e centinaia di pagnotte. Alcune di queste Marino le ha rese replicabili a casa, in risposta a quel piacere di impastare che la sua partecipazione a È sempre mezzogiorno! – trasmissione quotidiana di Rai1 condotta da Antonella Clerici – ha fatto riscoprire a molte persone.
Con lo stesso entusiasmo e semplicità con cui spiega l’arte bianca, Fulvio Marino ha condiviso – a margine del festival “L’impresa della bellezza” a Vigonza – alcune riflessioni per i lettori della Difesa.
Nelle prime pagine lei scrive che panificare richiede pazienza, ascolto, umiltà e la bellezza di una pagnotta risiede nella sua imperfezione. Cosa può insegnare ancora il pane oggi?
«In una società caratterizzata da intelligenza artificiale e digitale, penso che impastare il pane sia un atto rivoluzionario. Usiamo, infatti, i sensi e le mani tornando a essere produttori e non solo consumatori. Il pane ha la capacità di veicolare messaggi forti – come la pace, essendo un simbolo di unione non solo nelle religioni ma proprio nell’umanità – oltre a essere maestro di lentezza e attesa. Ci sono molti significati che si capiscono solo impastando».
Nel libro, segnala come negli ultimi anni vi sia stata un’erosione della biodiversità agricola e una presenza dominante nel mercato di poche varietà di cereali selezionate e brevettate. Quale può essere il ruolo del produttore per favorire una maggiore biodiversità?
«Il mugnaio e l’agricoltore possiedono un ruolo importante, ma ancora più lo hanno il panificatore – professionista o casalingo – e il consumatore. Andare a comprare il pane è un atto politico perché l’agricoltore seminerà ciò che vedrà essere maggiormente richiesto. Il grano è una pianta che ha favorito la creazione delle comunità: l’agricoltore da solo non se ne sarebbe fatto nulla, ma ha avuto bisogno del mugnaio e del panificatore. Tutte sono, quindi, figure importanti».
La sua storia personale parte da un mulino in Piemonte per orientarsi poi prima alla panificazione e successivamente alla comunicazione. Cosa ha significato per lei questo cambiamento?
«Già da ragazzo ho capito di avere la passione non tanto per le farine quanto per mischiarle; è stato un passaggio non forzato e abbastanza singolare in famiglia, essendo stato l’unico ad averlo compiuto. Ho poi capito che il pane non è l’arrivo, ma il punto di partenza per comunicare. Nel mio ultimo libro determinate pagnotte raccontano le civiltà, come la segale coltivata e utilizzata negli impasti nei Paesi del Nord oppure i flatbreads del Medio Oriente cotti nei forni dei nomadi».
Protagonisti nello scenario attuale sono i social. Che ruolo hanno nella divulgazione del pane?
«Sicuramente importantissimo. Possono arrivare in maniera capillare a tutti e personalmente li utilizzo non come fine, ma come mezzo per comunicare queste tematiche che stiamo affrontando».
C’è oggi un ritorno dei giovani verso l’agricoltura e il mestiere del mugnaio e, se sì, come si spiega?
«Vedo in questi anni una sorta di lento Rinascimento del pane attraverso il cambio di vita di molti ragazzi, e non solo, che iniziano a panificare. Qui vi trovano una sorta di mindfulness, una meditazione che fa stare bene. Molti hanno iniziato a capirlo durante la pandemia quando era evidente la sicurezza data dal pane in un momento di incertezza».