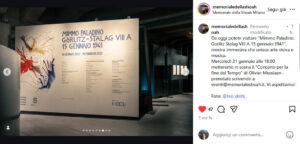Guido Alberto Fano Per ricordare i 150 anni dalla nascita del pianista e compositore padovano un calendario di eventi fino ad autunno inoltrato.
Si celebra quest’anno il 150° della nascita di Guido Alberto Fano (Padova, 1875 – Tauriano di Spilimbergo, 1961), pianista e compositore la cui originalità è continuo oggetto di riscoperta. Due sue importanti composizioni saranno eseguite all’interno della rassegna padovana “Musica sotto gli archi” a palazzo Sambonifacio (il 29 maggio e il 12 giugno ore 20.15) e fino all’autunno inoltrato saranno diversi i cartelloni e le istituzioni musicali del territorio a ricordarlo con concerti e conferenze. Abbiamo intervistato in esclusiva il nipote, Vitale Fano, musicologo, socio fondatore, presidente e direttore artistico dell’Archivio Musicale Guido Alberto Fano di Venezia, oltre che direttore artistico della Fondazione Omizzolo Peruzzi.
Qual è l’importanza di Guido Alberto Fano per la musica?
«È stato un musicista padovano che ha svolto tutta la propria attività con grande passione e un grande amore per la musica, con la convinzione che si dovesse nobilitare il genere musicale, in particolare italiano, attraverso lo sviluppo della musica strumentale (sinfonica, cameristica e pianistica), in un’Italia che era dominata dall’opera lirica. La sua formazione avvenne con Cesare Pollini, nonostante il suo primo maestro fosse stato Vittorio Orefice, direttore di coro e maestro di canto che lo prese sotto la sua guida fino al 1891. Dopo studiò anche con il grande Giuseppe Martucci a Bologna. Il talento di Guido Alberto è stato riconosciuto molto presto da musicisti come Riccardo Drigo e Antonio Bazzini, amici e colleghi della cerchia di Pollini, che hanno scritto delle bellissime parole per testimoniare il suo giovane talento».
C’era interesse all’estero per musica italiana che non fosse lirica?
«Per il mondo l’Italia era la patria dell’opera, tutti venivano qui a studiarla, anche Mozart, e, ovviamente, ovunque cercavano di “imitarla”. Quello che è un po’ mancato, e che invece nel Settecento c’era, era l’interesse per la musica strumentale, una cosa che viene ripresa con l’unità d’Italia dalla cosiddetta “generazione del ponte”, con Martucci e Sgambati, proseguita nel secondo Ottocento con la “generazione dell’Ottanta”, musicisti nati attorno al 1880, quindi Casella, Pizzetti, Malipiero e Respighi, che cercano di differenziarsi dalla tradizione tedesca per ritrovare un linguaggio italiano, e lo cercano guardando al passato, Pizzetti al canto gregoriano, Malipiero alla musica del Rinascimento. Fano si trova esattamente su questa linea. Le composizioni del periodo 1910-1913 sono molto avanzate come linguaggio rispetto alla produzione italiana contemporanea».
Per una conoscenza del compositore da quali pagine suggerirebbe di cominciare?
«Ci sono composizioni pianistiche assai apprezzate anche da un musicista come Pietro De Maria, il quale ha inciso la Sonata e le Quattro fantasie, mentre Rimembranze è stata eseguita da Leonardo Armellini. Per la musica da camera senz’altro la Sonata per violoncello e pianoforte, che ho fatto suonare a tanti noti violoncellisti, Brunello, Dindo e Silvia Chiesa con il pianista Maurizio Baglini. C’è poi la Fantasia Sonata per violino e pianoforte, una pagina giovanile piuttosto interessante, e il Quintetto, che è una composizione molto importante. Una curiosità: non è che Fano escludesse l’opera, l’importante è che si allineasse con l’idea di celebrare l’Italia e le origini italiche, ne scrisse quindi due, fra cui Juturna, tratta dall’Eneide di Virgilio, mai stata messa in scena». In autunno il pianista Massimiliano Ferrati suonerà il Quintetto a Padova in collaborazione con il Pollini.
Un calendario di appuntamenti non solo a Padova
Gli omaggi a Fano sono iniziati a febbraio alla Casa italiana Zerilli-Marimò della New York University. In autunno il pianista Massimiliano Ferrati suonerà il Quintetto con l’Ensemble Mark Rothko alla Fenice di Venezia e a Bologna. Nella stagione di Musikàmera Venezia, a settembre Anna Tifu e Giuseppe Andaloro eseguiranno la Fantasia Sonata. Info: www.archiviofano.it