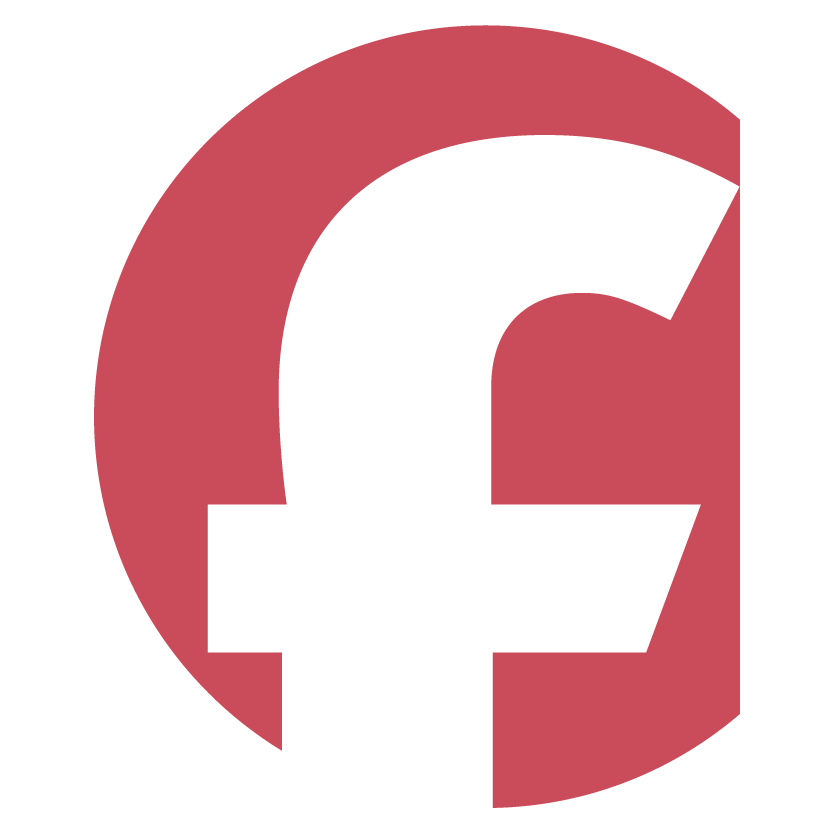 Fatti
Fatti
Le ragioni del no della Corte Costituzionale al terzo mandato
Due riflessioni: una sul merito e una più ampia sulla democrazia
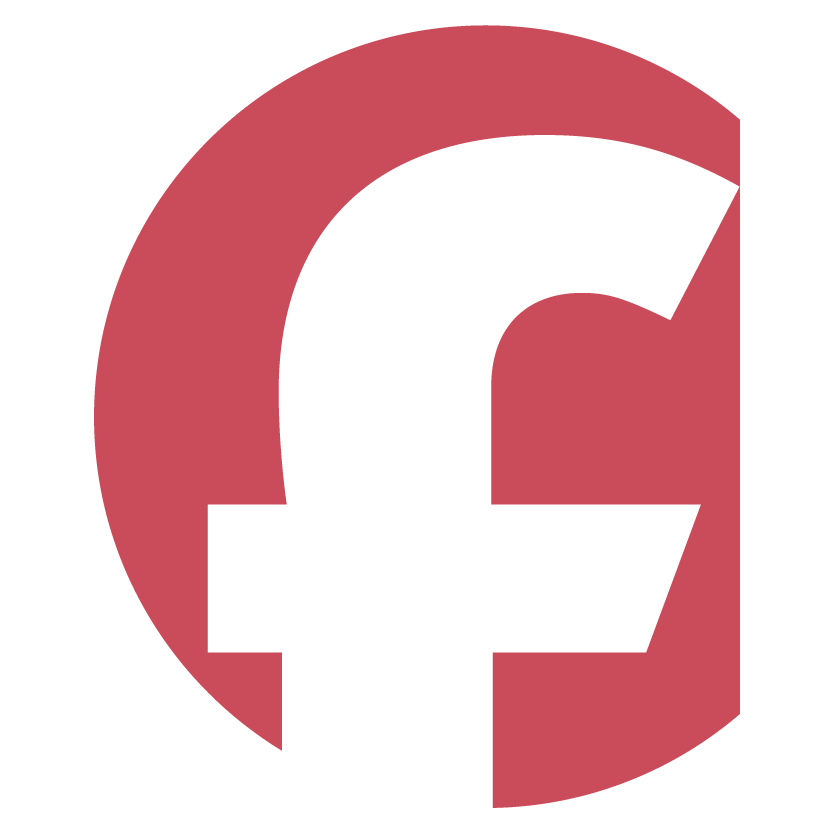 Fatti
FattiDue riflessioni: una sul merito e una più ampia sulla democrazia

La sentenza con cui la Corte costituzionale ha respinto la possibilità di un terzo mandato per i presidenti delle Regioni si presta a due livelli di lettura. Uno riguarda il merito della questione in senso stretto e le sue importanti ripercussioni nei rapporti tra i partiti di entrambi gli schieramenti; l’altro induce a una riflessione più ampia sui rischi che la tendenza dominante alla concentrazione dei poteri rappresenta per la democrazia, soprattutto in questa stagione di leaderismi aggressivi a livello globale.Sotto il primo profilo, i riflettori sono direttamente puntati sulla vicenda di due “governatori” di grande popolarità, Vincenzo De Luca in Campania e Luca Zaia nel Veneto. La legge regionale con cui De Luca ha cercato di aprirsi una strada per il terzo mandato è stata l’oggetto esplicito del ricorso dell’esecutivo nazionale che ha attivato il pronunciamento della Consulta. Pronunciamento che però ha investito tutti i presidenti delle Regioni a statuto ordinario. E qui vale aggiungere una postilla: a questo giro i presidenti delle Regioni a statuto speciale non sono stati coinvolti perché il ricorso del governo non li chiamava in causa. Ma non è affatto detto che in futuro la Corte non possa essere chiamata a occuparsi anche di loro: forse qualche lume – livello di argomentazioni – potrebbe arrivare dalle motivazioni della sentenza che saranno pubblicate prossimamente.Tornando a De Luca e Zaia, la loro posizione rispetto agli schieramenti e ai partiti che li compongono presenta simmetrie e singolarità. Il fatto che i due personaggi restino fuori dai prossimi appuntamenti elettorali – con l’incognita della sorte dei loro massicci consensi personali – determina una specie di effetto-domino anche sulle candidature nelle altre Regioni. Sul versante della maggioranza, c’è da registrare la forte spinta di FdI che è diventata di gran lunga il primo partito al Nord ed è oggettivamente sottorappresentata negli incarichi di vertice. In questi giorni si parla spesso di un possibile scambio con la Lega che continuerebbe a indicare il candidato presidente in Veneto ma lascerebbe a FdI la Lombardia.Sul versante delle opposizioni, la situazione della Campania è emblematica della complessità dei rapporti tra Pd e M5S. Anche in questo caso c’è un partito che i risultati noti e i sondaggi danno largamente in vantaggio, il Pd, ma il suo alleato-competitore, il M5S, sembra sempre più condizionare la collaborazione all’espressione del candidato “governatore”, tanto più al Sud dove esso conserva i suoi maggiori consensi. E’ una dinamica a cui si assiste anche a livello nazionale, e in questo consiste la principale differenza con lo schieramento opposto in cui – alla fine – l’obiettivo di vincere nelle urne e quindi di governare prevale sulla volontà di primeggiare nel proprio campo.Il secondo profilo del ragionamento innescato dalla sentenza è di carattere istituzionale. In attesa delle motivazioni, il comunicato della Corte, pur nella sua stringatezza, collega esplicitamente il limite dei due mandati con il meccanismo dell’elezione diretta del presidente della Regione. E’ un nesso che era stato messo in luce già nella sentenza 60 del 2023, che costituisce il precedente più ravvicinato. Citando per giunta una decisione del Consiglio di Stato, due anni fa la Consulta aveva affermato che “la previsione di un tale limite si presenta quale ‘punto di equilibrio tra il modello dell’elezione diretta dell’esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona che ne deriva’: sistema che può produrre ‘effetti negativi sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione’”. Quali danni possano derivare dalla concentrazione di potere “in capo a una sola persona” lo vediamo, purtroppo, anche nelle cronache internazionali di questi mesi.
