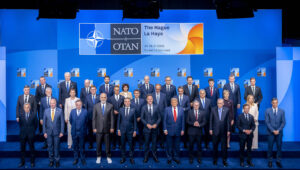Dopo giorni di ambiguità da parte del presidente statunitense Donald Trump, alla fine l’intervento americano nel conflitto tra Israele e Iran è arrivato. Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno l’esercito Usa ha bombardato i tre principali siti nucleari iraniani. Aerei B-2 statunitensi hanno sganciato quattordici bombe Gbu-57, i più pesanti ordigni convenzionali mai utilizzati, sui centri di arricchimento dell’uranio di Fordow e Natantz. Nel frattempo, un sottomarino Usa colpiva il terzo sito nucleare iraniano, quello di Isfahan. «Quando si tratta della politica estera di Donald Trump, parlare di ragioni strategiche è molto difficile». Ad ammetterlo è Francesco Saverio Leopardi, professore di Storia internazionale del Medio Oriente all’Università di Padova: «Questa amministrazione sembra agire dando prove di forza e risposte muscolari. A Trump probabilmente non sarebbe dispiaciuto prendersi il merito di un nuovo accordo sul nucleare con l’Iran, poi però Israele ha attaccato e gli Stati Uniti sono dovuti andare al traino per mostrare che hanno un ruolo, ma l’intervento militare non era la loro prima scelta». Nove giorni prima, nella notte tra il 12 e il 13 giugno, Israele aveva sferrato un attacco contro l’Iran bombardando siti nucleari, uccidendo buona parte dei vertici militari del regime e colpendo zone residenziali. L’offensiva dello Stato ebraico e l’immediata reazione della Repubblica islamica, che ha risposto con il lancio di centinaia di missili, hanno provocato l’uccisione di oltre 600 persone in Iran e almeno 24 in Israele. «Una caratteristica della presidenza Trump è l’assenza di una visione organica in politica estera, questo fa sì che attori più piccoli, come Israele, ne possano influenzare la posizione. Come? Mettendo gli Usa davanti a una situazione dalla quale non si possono tirare indietro, se non a costo di impegnarsi in una virata storica. Netanyahu ha attaccato l’Iran in un momento in cui aveva bisogno di far riavvicinare i propri partner, perché i crimini di guerra a Gaza cominciavano a generare malumore anche in Europa e negli stessi Stati Uniti».
Come casus belli per attaccare la Repubblica islamica, Netanyahu e Trump hanno sostenuto che l’Iran fosse a un passo dal dotarsi di una bomba nucleare, pur senza fornire prove e contraddicendo le valutazioni dell’intelligence statunitense e dell’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Immediatamente dopo l’attacco americano, Trump ha frettolosamente annunciato il successo dell’operazione e l’annientamento del programma nucleare iraniano. Successivamente, però, esperti nucleari statunitensi e ufficiali del dipartimento della difesa hanno specificato che al momento non si possono stimare le quantità di uranio arricchito che rimangono all’Iran per proseguire con il programma. Ma c’è di più: gli analisti ora valutano come probabile l’uscita dell’Iran dal Trattato di non proliferazione di armi nucleari, di cui era membro e sulla base del quale la avvenivano i controlli dell’Aiea. Per quanto riguarda gli altri obiettivi, ministri e ufficiali sia statunitensi che israeliani hanno specificato che il regime change (sostituzione forzata dall’esterno di un cambio al vertice del governo, ndr) non era nei piani. Nel frattempo però Benjamin Netanyahu e Donald Trump auguravano la caduta del regime degli ayatollah come conseguenza più o meno diretta del conflitto. «Il regime degli ayatollah non è popolare in Iran, l’abbiamo visto con le varie ondate di manifestazioni di questi anni – rimarca il prof. Leopardi – Eppure, anche figure popolari e intellettuali dell’opposizione si sono espressi ribadendo la loro condanna al regime e allo stesso tempo condannando l’aggressione israelo-statunitense. Il tema è che non si tratta solo di un attacco al regime, ma di un attacco al Paese in cui Israele ha provocato la morte di civili». All’indomani dell’attacco di Trump, la preoccupazione per un’ulteriore escalation e un coinvolgimento statunitense permanente è dilagata. La scelta della guida suprema Khamenei di rispondere attaccando la base Usa di Al Udeid, in Qatar, dando però un preavviso in modo da evitare che ci fossero vittime tra i soldati americani, ha creato un margine perché gli Stati Uniti si sfilassero dai combattimenti. Eppure, la regione continua a trovarsi nel pieno del caos. Qualche ora dopo la risposta iraniana, infatti, nella mattinata di martedì 24 giugno, gli Stati Uniti hanno annunciato il raggiungimento di un cessate il fuoco, poi confermato da Repubblica islamica e Israele. Tuttavia, a nemmeno tre ore dall’annuncio, il ministro della difesa dello Stato ebraico Israel Katz ha minacciato pesanti bombardamenti contro Teheran come rappresaglia di fronte a una presunta violazione del cessate il fuoco da parte dell’Iran. Israele sostiene di aver intercettato un missile balistico della Repubblica islamica diretto verso il suo territorio, gli ayatollah negano, Trump si dice deluso dalle ripetute violazioni della tregua di entrambe le parti in conflitto.
Nel frattempo, a Gaza i massacri non si fermano: nella sola mattinata del 24 giugno, mentre gli occhi del mondo erano puntati altrove, a Gaza venivano uccise 37 persone, secondo Al Jazeera. In questo senso, il prof. Leopardi puntualizza: «A oggi c’è una possibilità concreta di realizzazione del progetto egemonico israelo-statunitense in Medio Oriente, ma ciò non toglie che forme più disorganizzate di resistenza, ugualmente minacciose, potranno emergere. La popolazione israeliana non è più al sicuro di prima, e non potrà esserlo fino a che non si risolverà il nodo politico-culturale della questione palestinese».
Una mossa utile per la campagna elettorale
Nima Baheli, analista geopolitico ed esperto di Medio Oriente, sul Sir: «Sul nucleare non sappiamo quanto sia stato effettivamente distrutto o rallentato il sito di Fordow. Sappiamo che in qualche modo Trump ha “messo il cappello” su questa guerra nata dal nulla, per chiuderla. In questo modo può rivendicare una vittoria, peraltro utile a fronte di una sua base elettorale fortemente critica. Secondo recenti sondaggi fatti negli Stati Uniti, il suo tasso di approvazione era sceso al 41 per cento, il minimo durante il suo mandato».
Il card. di Teheran: «Non si ottiene la pace con la guerra»
Il card. Dominique Joseph Mathieu, arcivescovo di Teheran-Ispahan dei latini, ha condiviso su AsiaNews alcune sue riflessioni in questi giorni di sgomento e preoccupazioni: «All’undicesimo giorno di guerra, prima dell’alba, si è svegliati dal rumore assordante degli aerei da combattimento e dei droni che sganciano le loro bombe, e dalle raffiche sbalorditive della difesa aerea che ingaggia l’intercettamento. Ci si abitua a riprendere sonno, senza riuscire davvero a riposare… La surreale escalation di attacchi e contrattacchi fa temere il peggio, portando a credere che non ci siano più limiti, che tutto sia possibile e giustificabile, come “ottenere la pace con la guerra”. La pace, però, non significa ridurre al silenzio per paura. La pace si ottiene attraverso la risoluzione pacifica dei conflitti, lavorando per la giustizia, la riconciliazione e la dignità umana».