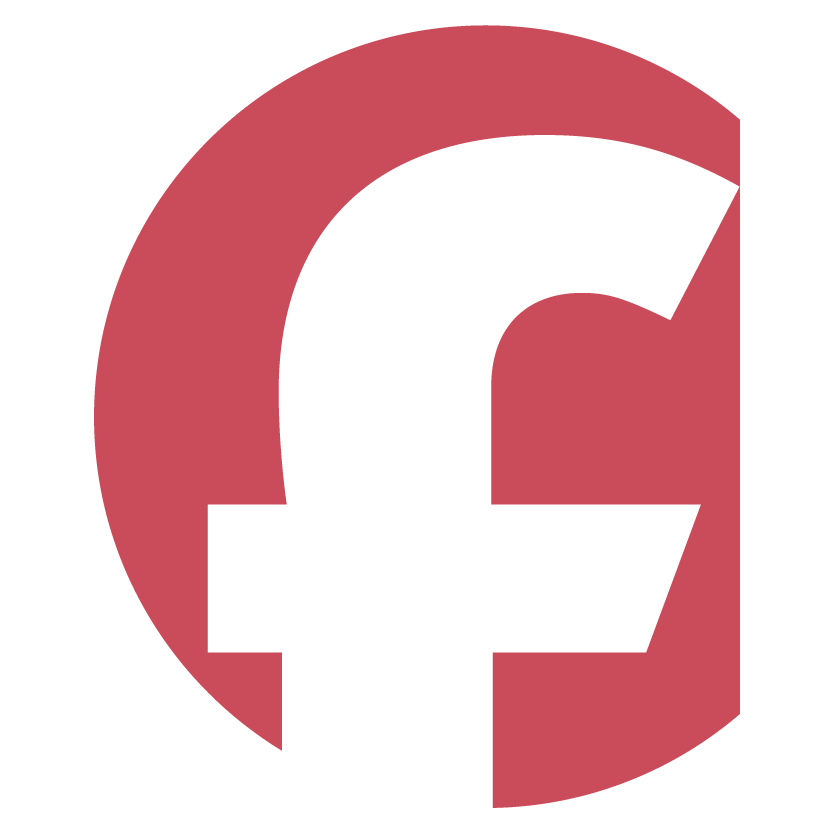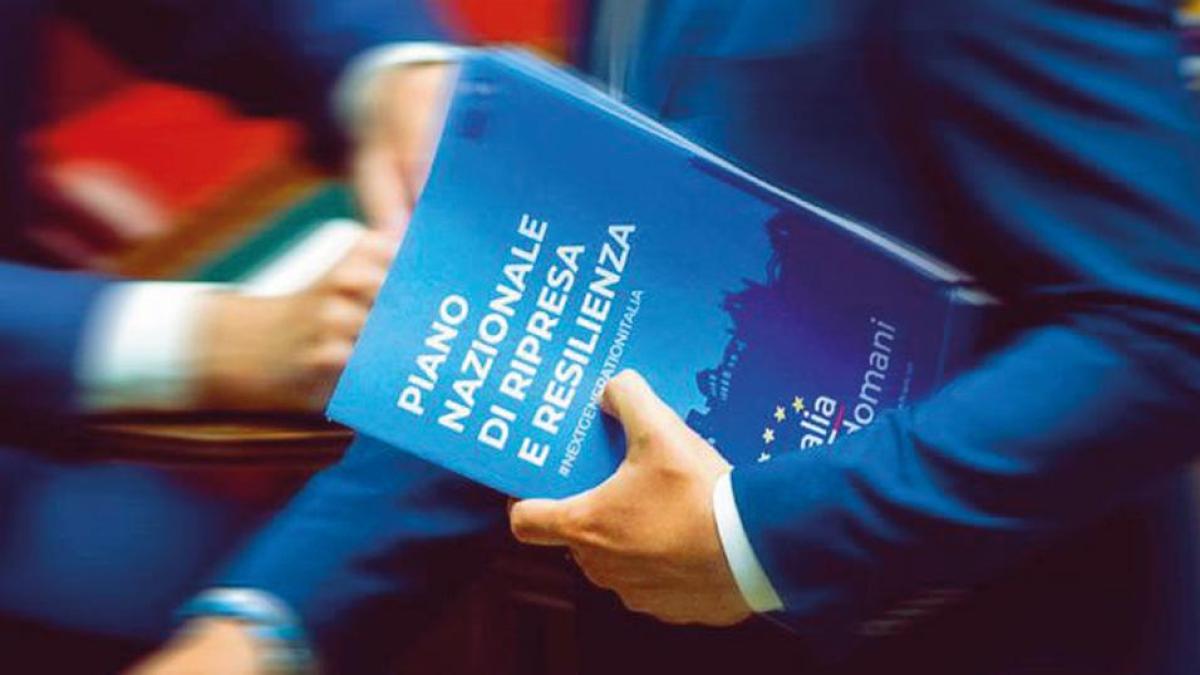
L’andamento dei conti pubblici continua a dare soddisfazioni al governo. Anche l’assestamento di bilancio, una sorta di verifica di metà anno che si fa in Parlamento prima della pausa estiva, ha dato esito positivo. Le entrate statali tengono il passo e, anzi, quasi corrono, al punto che sottovoce qualcuno comincia a ipotizzare che l’Italia possa uscire dalla procedura europea per disavanzo eccessivo già il prossimo anno.
Buone notizie, fermo restando che in questa stagione il contesto internazionale rende ogni previsione un azzardo. Il nostro Paese, inoltre, deve confrontarsi anche con un debito pubblico imponente. Qui la politica farebbe bene a essere trasparente verso l’opinione pubblica e a non alimentare illusioni. Senza catastrofismi, ma anche senza trionfalismi fuori luogo. A maggio, per esempio, il debito pubblico (detto alla buona è il disavanzo che si è accumula anno dopo anno) è effettivamente diminuito di dieci miliardi, ma si tratta di una variazione proporzionalmente minimale e in rapporto al maggio dell’anno scorso si è registrato invece un aumento di circa 100 miliardi di euro.
Dall’insediamento dell’attuale governo l’incremento è stato di quasi 300 miliardi, ha calcolato il sito di fact-checking “Pagellapolitica”, e nei prossimi anni il debito tenderà ad aumentare anche in rapporto al Prodotto interno lordo, che è il modo più appropriato di valutare il fenomeno. Ovviamente siamo davanti a grandezze che sarebbe disonesto oltre che insensato imputare al governo in carica, il quale ha certamente la sua parte di responsabilità, ma insieme a quelle degli esecutivi che lo hanno preceduto soprattutto nella fase di maggior espansione del debito.
Si tratta infatti di uno di quei fenomeni che si è soliti definire “strutturali” e che il nostro Paese fatica ad aggredire anche nei periodi di più duratura stabilità politica interna. Il più macroscopico di tali fenomeni è quello del calo demografico. Ogni bollettino dell’Istat segnala inesorabilmente l’ennesimo record negativo.
Sotto il profilo lavorativo il recentissimo Employment outlook dell’Ocse (l’organizzazione che raggruppa le economie più sviluppate), ha stimato che in Italia la popolazione in età lavorativa diminuirà del 34% entro il 2060 contro una media dell’8% degli altri Paesi dell’area: un ritmo oltre quattro volte superiore. Non è un caso che i risultati molto positivi che l’Istat comunica a ogni rilevazione sugli occupati siano in larghissima misura concentrati nella fascia dei lavoratori over 50. Il medesimo rapporto dell’Ocse segnala un altro problema cronico del nostro Paese, quello dei salari, che nonostante la ripresa di questa prima fase dell’anno (grazie in primo luogo a importanti rinnovi contrattuali) all’inizio del 2025 erano ancora inferiori del 7,5% rispetto all’inizio del 2021. Come non ricordare, poi, che nello scorso anno il numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale è aumentato di 133mila unità?
L’Italia – non questa o quella maggioranza – ha avuto un’occasione epocale per intervenire su alcuni deficit strutturali del suo sistema economico-sociale ed è stata quella offerta dai fondi europei confluiti nel Pnrr. Occasione colta oppure persa? Un bilancio realistico lo si potrà fare soltanto al termine del percorso a metà del 2026. Dall’inizio di quest’anno c’è stata un’accelerazione nella spesa per i progetti del Piano. Un segnale confortante che però va preso con le pinze se la stessa premier Meloni, in uno degli ultimi Consigli dei ministri di luglio, ha vigorosamente strigliato i suoi colleghi di governo avvertendo che non ci saranno proroghe e ognuno risponderà del lavoro effettivamente completato.