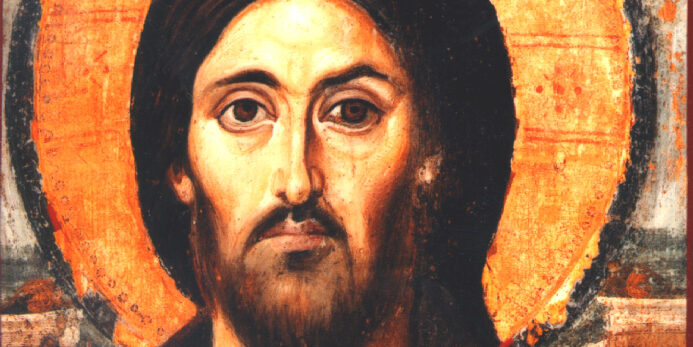
Ci sono persone che Dio prende e mette da parte. Ce ne sono altre che lascia nella massa, che non “toglie dal mondo”. Sono persone che fanno un lavoro comune… che hanno una casa comune, vestiti comuni… persone dalla vita comune… che si incontrano per strada, qualunque strada» (Noi delle strade, 1938). È con queste parole che Madeleine Delbrêl presenta coloro che sono chiamati a seguire Cristo non dentro spazi ben definiti, circoscritti e protetti, ma abitando la città, la società e la storia, per portare “dal di dentro” il contributo significativo dei valori del Vangelo.
Sono donne e uomini che partecipano e collaborano, come tutti i laici, alla vita e alla crescita del loro territorio e della loro comunità ecclesiale. Ma è soprattutto sul loro essere consacrati in mezzo al mondo che ci soffermiamo. Sono laici e laiche che svolgono con responsabilità un lavoro, immersi negli ambiti della quotidianità, senza sentirsi o farsi estranei, e restando in contatto anche con quelle realtà che apparentemente sono lontane dalla fede, ma che esprimono una domanda di senso e di autenticità che il Vangelo può colmare.
Questa forma di vita consacrata, propria degli istituti secolari, forse non molto conosciuta neppure nella Chiesa stessa, è una vocazione singolare, che esprime il mandato di una Chiesa che non vuole richiudersi, recintarsi, né escludere, ma vuole essere “in uscita”, vuole lasciarsi chiamare in causa e interpellare dalle istanze dell’umanità, e testimoniare un Dio che si prende cura di tutti.
Il loro luogo di missione, come confermava papa Benedetto XVI, è «tutto l’umano, non solo dentro la comunità cristiana…, ma in modo particolare nella comunità civile… Cercando di testimoniare con la propria vita il modo unico di Cristo di amare, incontrare, guarire la vita, confortarla» (papa Benedetto, 3 febbraio 2007). È la strada dell’incarnazione, che pone sulle orme di Colui che si è fatto povero per raggiungere tutti e ciascuno. È una missione che non si riduce a un semplice esempio di onestà, rettitudine, lealtà, competenza e fedeltà al dovere, perché ogni laico e laica consacrata, che cerca di rivestirsi ogni giorno dei «sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5-ss), è chiamato a essere “segno” dell’amore di Dio e a vivere il radicalismo delle beatitudini nel mondo.
È questa dunque la caratteristica del laico consacrato: stare dentro-accanto – stare nella storia cercando e «facendo la verità nella carità» (Ef 4,15) – essere nel mondo e per il mondo, senza distintivi o divise, con la consapevolezza che il mondo è luogo di responsabilità cristiana, ed essere segno di una Chiesa che è chiamata a essere sale, fermento, lievito. E in questo suo “stare dentro”, ogni laico e laica consacrato/a accetta il rischio di sperimentare la solitudine e l’incomprensione di essere “minoranza”.
«Il lievito non mostra la sua forza se non quando lo si mette nella pasta, e non basta metterlo vicino, lo si deve mescolare e lo si deve confondere» (san Giovanni Crisostomo). In una società come l’attuale, nella quale siamo tutti condizionati dalla mentalità che esalta la visibilità, l’apparire e il clamore, nella logica secondo la quale ciò che non si vede o piccolo e ai margini non esiste, il concetto del lievito può sembrare insignificante, ma è questo il cardine dell’identità degli istituti secolari.
Ogni uomo e donna, chiamato/a a consacrare la propria vita al Signore in questi istituti, esprime non irrilevanza, mediocrità o “neutralità” culturale, ma, come qualcuno l’ha definita, la «visibilità della piccolezza», la vitalità di una presenza che diventa testimonianza discreta, silenziosa, che sa però esprimere «la vita nascosta con Cristo in Dio» (Col 3,3): il lievito non si vede, ma c’è e fa lievitare la massa!
L’immagine del lievito che si lascia mescolare ed entra nella pasta, esprime la presenza di chi è inserito nella realtà concreta della società, con il cuore immerso in Dio: attento alla realtà che lo circonda, con le sue contraddizioni, problematiche e cambiamenti, non si ferma a ciò che può apparire in superficie, ma sa interrogarsi per andare più a fondo e riconoscere dove Dio si sta manifestando (papa Francesco, 2017).
Oggi è più che mai necessaria la presenza di cristiani maturi e creativi che, formati alla scuola del Vangelo, sono capaci di porsi in dialogo con le diverse realtà del mondo e di portare “dal di dentro” un contributo significativo in ogni ambito, compresi il campo della ricerca, dell’etica, della cultura, della politica e, più in generale, nella qualità delle relazioni.
Tutte le vocazioni che trovano la loro sorgente nel battesimo sono interpellate da questi aspetti e in questo impegno, ma sono soprattutto i laici, e a maggior ragione i laici consacrati, che si lasciano coinvolgere dalla responsabilità e cercano di discernere quali sono i luoghi più “scoperti” rispetto alla presenza cristiana, consapevoli della necessità di essere disponibili a frequentarli senza sottrarsi, per contribuire a costruire una nuova civiltà dell’amore.




