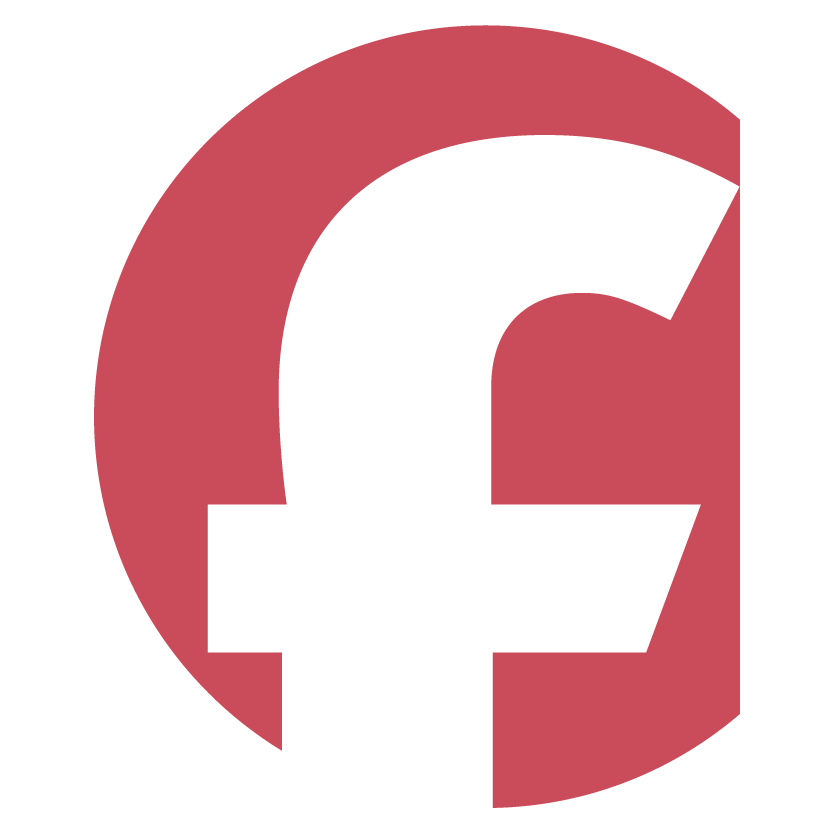Con l’intervento delle forze dell’ordine, accompagnate dall’ufficiale giudiziario, è stato eseguito, nelle prime ore della giornata, lo sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano. Un’azione che giunge dopo numerosi provvedimenti di “sfratto”, anni di contese tra proprietà (una società della famiglia Cabassi) e occupanti, con manifestazioni a sostegno del Leoncavallo e prese di posizione – alternativamente pro o contro, a seconda degli schieramenti – da parte della politica ambrosiana e nazionale.
Il Leoncavallo (nome legato alla via milanese della prima collocazione del centro autogestito), sorto 50 anni fa nel 1975, ha nel tempo cambiato sede – prima via Salomone, per approdare in quella attuale, in via Watteau nel 1994 – e rappresenta, al di là di tutto, una parte della storia cittadina, tra occupazioni abusive, rivitalizzazione delle periferie urbane, cultura giovanile, lotte operaie, confronto con la realtà del terrorismo e della droga, pacifismo, battaglie per i diritti sociali, il lavoro e l’eguaglianza, ma anche teatro, musica, nuove tendenze artistiche che ne hanno attraversato i decenni di vita (tanto da divenire un punto di riferimento per i centri sociali italiani ed europei), assieme alle rivendicazioni delle proprietà circa la disponibilità degli immobili. Decine e decine, nel tempo, i decreti di sgombero; altrettanto numerosi gli episodi di resistenza, talvolta violenta altre volte passiva, degli stessi occupanti. Fino alla notizia di oggi.
Cosa dice alla città di Milano l’intervento in via Watteau, in zona Greco? Al Sir risponde Fabio Pizzul, volto noto in città, presidente della Fondazione Ambrosiaeum, agorà culturale della diocesi ambrosiana. “Lo sgombero del Leoncavallo è una notizia che invita alla riflessione. Se dopo 31 anni di occupazione dello stabile di via Watteau si è giunti a un intervento di sgombero da parte delle forze dell’ordine, qualcosa non ha funzionato”. In che senso? “Il Leonka è diventato una presenza sociale e culturale significativa per la città. Passati gli anni dell’antagonismo violento e degli scontri con le amministrazioni di centrodestra, che hanno scritto pagine tristi, anche all’insegna della guerriglia urbana,
si è giunti a un dialogo costruttivo che ha consolidato il ruolo sociale e culturale di un centro sociale che ha fatto la storia della Milano degli ultimi decenni, seppure tra luci e ombre.
Il percorso non si è però compiuto fino in fondo e il tentativo di trovare una nuova sede per il Leoncavallo, anche attraverso la partecipazione a bandi aperti dal Comune si è prolungato in maniera indefinita”. Pizzul aggiunge: “Fa anche sorridere – amaramente – il fatto che a un bando del Comune per un’area in via San Dionigi, al Corvetto, abbiano partecipato le ‘mamme del Leoncavallo’, testimonianza, forse, del fatto che gli attuali gestori del centro non avessero poi così grande intenzione di cambiare sede”.
“Rimane aperta la vera questione…”. Il presidente dell’Ambrosianeum aggiunge: “Non sta a me entrare nel merito della questione immobiliare, ma non si può certo addossare la responsabilità solo addosso ai Cabassi, che, dopo aver messo a disposizione un’area oltre 30 anni fa, risolvendo l’annosa e spinosa questione della storica sede di via Leoncavallo, legittimamente chiedono di poter tornare a disporre di quanto è di loro proprietà”. Dunque “rimane la vera questione politica che accompagna la vicenda del Leonka: quali spazi Milano riesce a garantire a chi promuove forme di aggregazione giovanile che non siano solo affidate alle logiche del mercato e del profitto immobiliare?
L’identità di una città si fonda anche sui luoghi che è capace di offrire alla socialità e all’aggregazione.
L’amministrazione comunale in questi anni si è mossa attraverso bandi e accordi con realtà del privato sociale che offrono occasioni di incontro, ma l’impressione è che Milano sia diventata una piazza complicata per chi si muove su questi fronti nel tentativo di offrire luoghi ai giovani che vadano oltre il consumo stile happy hour”. Quindi una ulteriore annotazione: “I diversi rappresentanti politici, nelle loro dichiarazioni, si dividono secondo schemi che mi pare già risentano dell’ormai imminente, se non già iniziata, campagna elettorale per le comunali del 2027. È un automatismo forse inevitabile, ma certamente molto fastidioso, anche perché non fa altro che blandire le rispettive tifoserie e non consente di affrontare la questione dei luoghi che una città riesce a mettere a disposizione di chi intende promuovere occasioni di confronto, di cultura e di protagonismo sociale. Per i giovani e non solo”.
“Quali luoghi per ritrovarsi?”. “La notizia di stamattina, dopo un ennesimo decreto di sgombero, non dovrebbe meravigliare. Non è una decisione di oggi e più volte reiterata. Ma quanto accaduto al Leoncavallo apre una più ampia riflessione sul rapporto tra città e giovani e, più ampiamente, tra società e nuove generazioni”. L’analisi viene da Paola Bignardi, pedagogista e pubblicista, già coordinatrice dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Milano. Bignardi studia da anni la realtà giovanile; ha fra l’altro curato, assieme a Rita Bichi, la recente ricerca “Cerco, dunque credo? I giovani e la nuova spiritualità” (Vita e pensiero). È dei giorni scorsi un suo articolo per “Avvenire” significativamente intitolato “I giovani non se ne vanno se la Chiesa è accogliente. Come a Tor Vergata”. Bignardi osserva al Sir:
“Oggi i giovani non hanno luoghi dove ritrovarsi, discutere, porre le loro domande, eppure ne hanno tante! Ma, generalmente, le vivono in solitudine”.
“Mancano punti di riferimento sia in termini di luoghi, così pure di istituzioni e di persone”. Bignardi sottolinea, in particolare, come i giovani abbiano “abbandonato, nella gran parte, i luoghi ecclesiali, i quali hanno in passato costruito relazioni sociali, offrendo veri e propri tirocini di socialità. Purtroppo, oggi questi luoghi sono disertati dal mondo giovanile anche in relazione ai cambiamenti avvenuti sul piano spirituale e religioso all’interno delle nuove generazioni”. Questione che interroga la stessa realtà ecclesiale.
Un nuovo approccio. “Venendo più precisamente alla vicenda del Leoncavallo – prosegue la studiosa –, occorre osservare come sia stato chiuso uno dei pochi luoghi autogestiti a disposizione dei giovani di Milano”. Qui si apre un capitolo relativo alla “ghettizzazione che la nostra società nel suo insieme sta facendo del mondo giovanile. Esso è considerato un mondo a parte, quando viene considerato…”. Mentre “nella maggior parte dei casi si assiste a una ‘distrazione’ nei confronti delle giovani generazioni. Tutto vorrebbe essere delegato alla scuola o alla famiglia, quando c’è.
Invece occorrono altre occasioni per accompagnare la socialità e far crescere la coscienza giovanile. Questo è un grave danno non solo per i giovani ma per la società intera.
Ebbene, questo episodio pone nuovamente a tema il rapporto tra giovani e città, che andrebbe affrontato in termini nuovi”.
Riflessioni che generino proposte. Da subito si sono rincorse le dichiarazioni di politici locali e nazionali: cosa ne pensa? “Ho letto le dichiarazioni dei politici – risponde Paola Bignardi –. Dicono, a seconda degli schieramenti, ciascuna il contrario dell’altra. Ma l’approccio è identico: dalle forze politiche arrivano dichiarazioni da campagna elettorale, anziché valutazioni approfondite che generino proposte e progetti. Così sarebbero davvero credibili”.