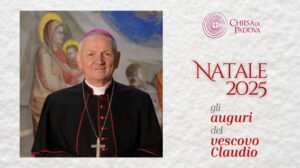In un’epoca che esalta la forza, la velocità e l’efficienza, è più facile pensare all’essere umano come a un soggetto produttivo, performante e indipendente. In una tale cornice, l’individuo può illudersi di essere invulnerabile e autosufficiente fino a dire «basto a me stesso e non devo nulla a nessuno». Ebbene, la realtà smentisce questa illusione perché, malgrado le differenze di carattere soggettivo e quelle dovute allo specifico contesto di vita, siamo tutti vulnerabili e bisognosi di cura in ogni stagione della vita. Per di più, abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere benefici dagli altri e dall’ambiente in cui viviamo.
Vulnerabilità e cura sono quindi delle strutture fondamentali dell’essere umano che attestano la nostra costitutiva apertura all’altro e aprono lo spazio per una risposta grata a partire dal riconoscimento di aver ricevuto più di quanto possiamo dare.
Si è qui dinnanzi alla triangolazione etica vulnerabilità-cura-gratitudine: le tre nozioni descrivono la trama ordinaria della nostra esistenza perché palesano il carattere relazionale di ognuno di noi. Nello specifico, la vulnerabilità ricorda che siamo esseri finiti, esposti e bisognosi di attenzione; la cura rende possibile l’elargizione di benefici come risposta al nostro essere vulnerabili, mentre la gratitudine conferisce valore e significato alla vulnerabilità e alle conseguenti relazioni di cura.
Ora, affinché l’intreccio etico appena proposto possa orientare il nostro modo di vivere insieme, è necessario superare alcune letture distorte e fuorvianti. Innanzitutto, la vulnerabilità non può essere intesa solo in termini negativi: essa implica un’esposizione e questo essere esposti comporta l’eventualità di subire danno (come evoca lo stesso termine “vulnerabilità”, che deriva da vulnus, cioè ferita). Ciononostante, l’evenienza di essere feriti, offesi o danneggiati presuppone la condizione del ricevere e quindi l’apertura ontologica dell’essere umano all’altro e all’ambiente circostante. Tale apertura può comportare delle ferite, ma può altresì suscitare attenzione e cura.
Da qui la valenza positiva, e quindi non esclusivamente negativa, della vulnerabilità. A sua volta, la stessa cura può assumere un significato negativo, quando si traduce impropriamente in modalità assistenzialistiche e paternalistiche o dà luogo a forme di subordinazione e persino di controllo e sfruttamento nei confronti di chi presta assistenza. Emerge così la necessità di integrare la cura con la giustizia: quest’ultima è chiamata a garantire la salvaguardia dei diritti e la promozione dei valori di uguaglianza ed equa distribuzione delle risorse.
Anche in tema di gratitudine è necessario sgombrare il campo da fraintendimenti: la condizione di dipendenza determinata dalla nostra vulnerabilità e dal conseguente bisogno di cura crea inevitabilmente un debito di gratitudine, ma tale debito non corrisponde a un peso come invece si pensa a livello di senso comune. In genere, il debitore brama di restituire al più presto quanto dovuto in modo da svincolarsi dal creditore e tornare a essere indipendente. In quest’ottica, il debito è un fardello e rientra nella logica del contraccambio, ma una tale immagine non si addice affatto al debito di gratitudine.
La persona grata è situata all’interno del movimento dare-ricevere-ricambiare e vive questa sua condizione di dipendenza come un’opportunità per rafforzare i rapporti interpersonali.
In altre parole, chi mostra gratitudine non intende fuoriuscire dalla relazione, bensì consolidarla attraverso la risposta grata e tutto ciò in base al seguente argomento: essendo costitutivamente vulnerabile e bisognoso di cura, il mio essere non è solo il risultato di meriti o sforzi personali, ma anche di una lunga serie di benefici che ho già ricevuto e che continuerò a ricevere.
Vulnerabilità, cura e gratitudine si richiamano allora a vicenda, e tale intreccio trova un’emblematica raffigurazione nell’opera Le tre Grazie di Antonio Canova. Le protagoniste della scultura sono raffigurate in punta di piedi, postura che richiama l’aspirazione al bene di chi partecipa al circolo dare-ricevere-ricambiare. Dietro di loro, è collocata una colonna che sorregge l’intera scultura: fuor di metafora, l’elemento strutturale del nesso vulnerabilità-cura-gratitudine è la giustizia, che, sostenendo l’intreccio etico qui discusso, fa sì che le tre Grazie dell’etica possano alimentare sollecitudine, benefici e riconoscenza verso ciò che contribuisce al nostro esistere, e quindi nei confronti della vita nelle sue molteplici espressioni.