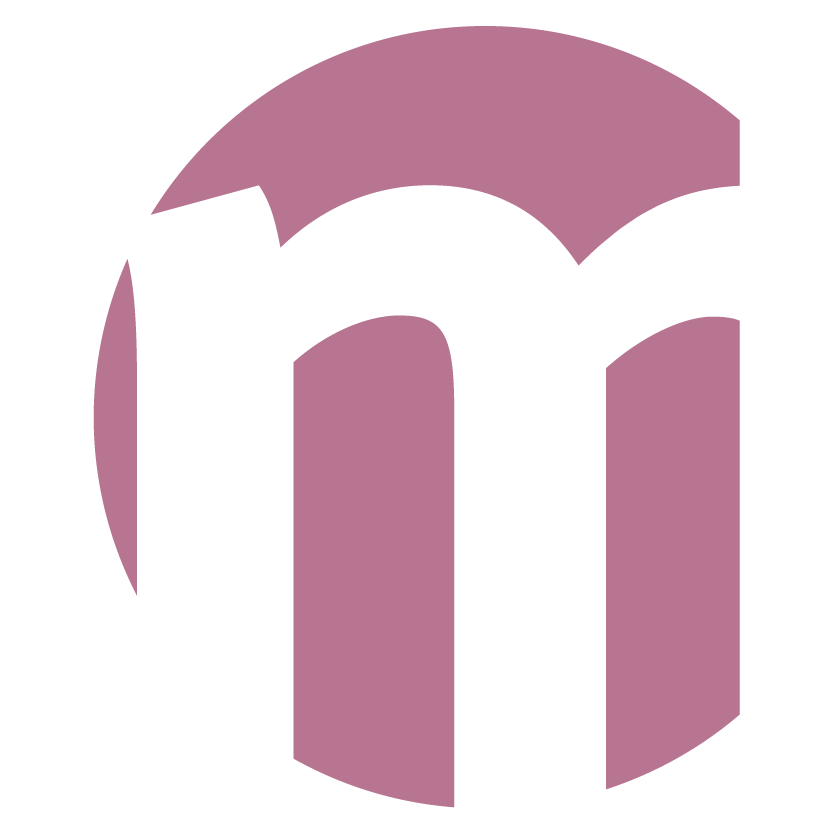“Fratello ateo, nobilmente pensoso/ alla ricerca di un Dio che io non so darti,/ attraversiamo insieme il deserto”.
La condivisione del vuoto, del non-senso e della ricerca di quel senso è uno dei punti fermi del lavoro di Mauro Manzoni, insegnante di Religione cattolica e autore di altri studi turoldiani, “Il volto di Dio nella poesia di David Maria Turoldo” (Ancora, 2025, 279 pagine, 19 euro). Ed è una cifra assai importante, perché contribuisce ad affrontare la poesia e il pensiero del frate servita (entrò a diciotto anni come novizio nel convento dei Servi di Santa Maria a Monte Berico) da un punto di vista più vasto, fin dall’inizio del suo cammino intriso di letture bibliche, soprattutto Qoélet e il Cantico dei Cantici, e il misticismo con Giovanni della Croce, e Teresa d’Avila, ma anche Dostoevskij, solo per fare alcuni nomi. Ed è fondamentale il confronto che Manzoni fa con il pensiero di autori che sembrerebbero, ad una lettura parziale, distanti dal misticismo e che invece ne sfiorano, quando non vi si inabissano, le profondità. Ed è il caso di un Leopardi che nel Cantico del gallo silvestre, ma non solo, si interroga sul silenzio del dopo umano e sul mistero, e il fascino, dell’immensità dell’universo. Gli inquietanti interrogativi di autori apparentemente non credenti, come Gottfried Benn, o attirati da altre visioni della divinità, è il caso di Hermann Hesse, vengono messi a confronto in questo lavoro con l’onesta confessione da parte di Turoldo delle difficoltà a penetrare nel grande mistero di Dio.
E da qui nasce la vicinanza del frate Servita a tutti coloro che cercano il senso delle cose anche attraverso le negazioni. È quell’aspetto della mistica che rasenta il silenzio come onesta ammissione di indicibilità di Dio, e fa bene l’autore a rimarcare come una parte di quella ricerca sia sfociata nella visione apofatica, cioè impossibile a dirsi con parole umane.
La poesia di Turoldo fa conti profondi con questa ammissione dei limiti umani, il che non vuol dire però sprofondamento nel silenzio, come invece scelse di fare un altro grande poeta qui citato, Clemente Rebora, dopo la sua decisione di entrare in convento. La scelta della parola poetica come tentativo -anche se imperfetto- di dire l’altrimenti inesprimibile (capacità comune anche all’arte figurativa e alla musica) si concretizza in versi brevi, in cui il silenzio è costantemente in agguato, perché essi si avvicinano terribilmente al nucleo rovente dell’origine e della fine.
Per questo fa bene Manzoni ad avvicinarsi, nelle pagine finali del suo lavoro, al grande motivo dell’icona, che significa anche avvicinamento al senso ultimo del mondo abolendo i “limiti” percettivi della prospettiva. E non è un caso che l’opera terminale di Botticelli, la Natività mistica, rappresenti proprio una sorta di ritorno all’icona, in cui la piattezza apparente suggerisce l’abolizione della “finzione” dello sguardo umano.
Il ritorno ad una poesia che abbandoni i trucchi retorici è davvero prossimo alla considerazione di un Manzoni commosso da questa kenosis, abbassamento, di un’arte un tempo fine a se stessa e con Turoldo ritorno ad un “Cristo autentico volto di Dio, l’icona perfetta del volto del Padre” , fino a quel terribile, per le umane retoriche, ma essenziale e commovente “dove la Parola muore/abbia fine il nostro cammino” delle ultime poesie di un uomo che aveva scelto il divino come inizio di una strada da percorrere insieme, tra le insidie e le gioie dell’incontro.