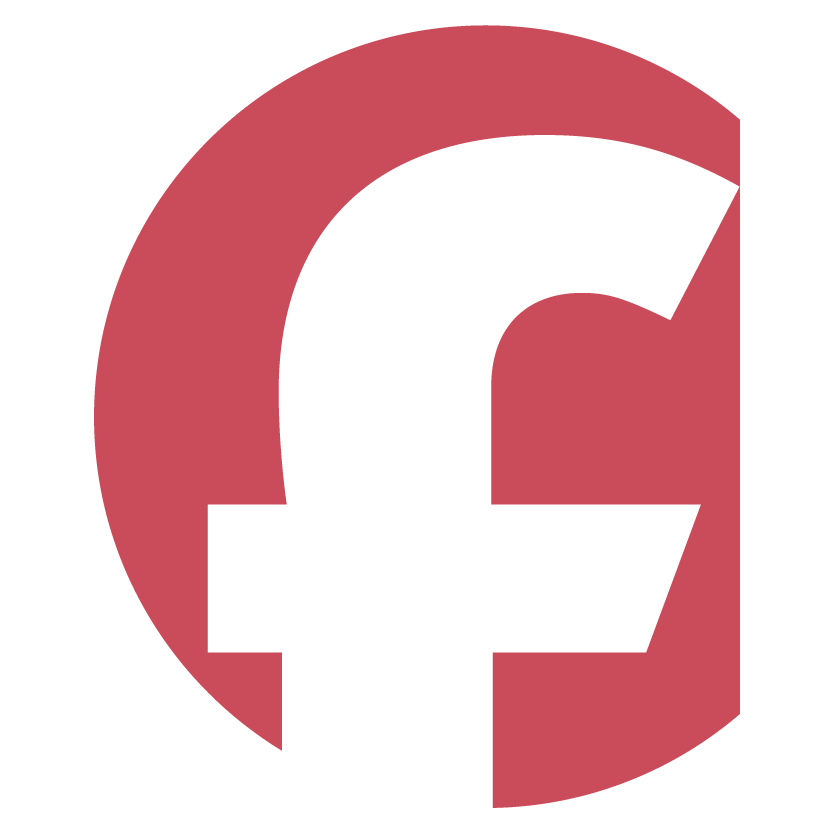Il teatro iraniano ha assunto il profilo di una guerra psicologica. Lo è per l’Iran, su cui incombe quella che Trump – evocando, forse dimenticandone le sorti, dell’Invincible Armada spagnola – ha definito la sua “Beautiful Armada”. Ma vale anche per la Casa Bianca, che deve decidere come e per cosa usare la leva bellica. I consiglieri in divisa del Tycoon tracciano uno scenario fallimentare, nel caso si perseguisse il rovesciamento del regime. Occorrerebbe un’occupazione terrestre logorante (forse decennale), insostenibile in questo frangente per gli Usa. In alternativa, si potrebbe pensare a una serie escalativa di raid, a partire da azioni simboliche e dimostrative, fino a piegare Teheran ai diktat americani.
Per capire l’indecisione serve prima chiarire cosa Trump pretende dall’Iran. L’arresto del programma nucleare è il rivestimento di un’altra finalità: colpire gli interessi della Cina, primo importatore del greggio iraniano. Il filo rosso porta al Venezuela: la stessa portaerei Lincoln, ora dislocata nel Golfo Persico, proviene dall’operazione conclusa al largo di Caracas, assoggettata alla pressione aeronavale prima del rapimento di Maduro. Lo schema venezuelano può illustrare l’ipotesi di applicare all’Iran un’azione analoga. Ecco le costanti: pretesto securitario giustapposto all’obiettivo anticinese, pressione militare per fomentare un golpe interno, riscontro di un improbabile cambio di regime guidato da remoto stante l’assenza di una idonea leadership locale, impossibilità di un’azione “stivali a terra” e conseguente scelta di decapitare il vertice per estorcere concessioni. Nel caso iraniano, si tratterebbe di assestare colpi che inducano l’establishment a deporre Khamenei, accogliere le compagnie statunitensi e cessare – o almeno ridurre – gli scambi preferenziali con Pechino. In cambio l’allentamento del cappio di un annoso embargo unilaterale.
Ma c’è un “ma”. Qualche giorno fa, il capo della stampa iraniana ha chiarito il motivo per cui il governo ha affermato che, in caso di qualsivoglia attacco, la risposta sarebbe una guerra totale contro le basi Usa nella regione e Israele. Teheran avrebbe ricevuto, tramite un Paese terzo, la richiesta della Casa Bianca di replicare la dinamica con cui si era chiusa la Guerra dei 12 Giorni dello scorso giugno, innescata da Israele mentre erano in corso i negoziati sul nucleare: attacco Usa e risposta “telefonata” dell’Iran contro una base in Qatar (con tanto di ringraziamento di Trump per la cortesia). Stavolta, la Repubblica islamica non si presterebbe al minuetto, vista l’inaffidabilità delle garanzie di Washington. A bruciare la carta negoziale anche il sussiego non richiesto con cui l’Ue, preservando l’Idf, ha incluso i pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche.
D’altronde, il saggio offerto a giugno dalla missilistica iraniana aveva indotto Israele – a corto di munizioni per la sua smitizzata antiaerea – a chiedere alla Casa Bianca di escogitare una via di uscita. Da allora, l’Iran si è viepiù rafforzato in vista di una guerra esistenziale, con un surplus di sistemi d’arma e assistenza tecnica da Mosca e Pechino. Queste ultime non entrerebbero certo in scontro aperto con gli Usa, ma si profilerebbe per l’Iran un sostegno che replicherebbe, a parti invertite, la vicenda ucraina. Inoltre si affiancherebbero gli attacchi a raggiera di tutti i sodali dell’Asse della Resistenza, dagli Huthi yemeniti a Hezbollah alle milizie sciite in Iraq. Inoltre, Arabia Saudita, Turchia, Qatar, Pakistan ed Egitto negherebbero a negare agli Usa il proprio spazio aereo: gli atteggiamenti eversivi di Israele nella regione hanno unito un fronte di stabilizzatori che, vincendo le reiproche rivalità, non vogliono che divampi un incendio incontrollabile. Con ragioni che vanno anche oltre le pur gravissime ripercussioni commerciali e finanziarie di una guerra che chiuderebbe il transito del greggio nello Stretto di Hormuz.
Servirebbe un colpo rapido e letale, che Tel Aviv stessa chiede da tempo. In assenza di esso, con un territorio privo di profondità e pertanto esposto alla pioggia missilistica di Teheran, Israele potrebbe chiedere alla Casa Bianca di desistere. E anche quest’ultima necessita di una vittoria-lampo, in mancanza della quale – come avvenne con Obama per la Libia – dovrebbe chiedere alla Nato di completare il lavoro. Infatti, l’iniziativa militare ordinata dalla Casa Bianca dovrebbe chiudersi entro un mese, per non sottoporsi all’approvazione del Congresso. Ma le fibrillazioni sociali negli Usa e le spaccature anche in seno ai repubblicani (indicativo il silenzio di Vance a petto della baldanza del neocon Rubio), anche in vista delle elezioni di medio termine, non promettono bene.
Del resto, tentare il cambio di regime – impossibile senza una spallata interna – aprirebbe un vaso di Pandora di proporzione ingente, attivando anche oltre confine le organizzazioni secessionistiche e jihadiste e le sigle terroristiche con cui Teheran è da anni alle prese: dai sunniti del Jaish al-Adl del Baluchistan all’Isis-K, ai curdi del Pdki e Komala agli arabi dell’Asmla in Khuzestan ai mujaheddin del Mek. Alla polveriera si aggiungerebbe la difesa a mosaico predisposta da anni dalle Guardie della rivoluzione. D’altra parte, gli stessi pasdaran potrebbero allargare il caos infiltrandosi nei Paesi limitrofi per vendere cara la pelle e trascinare altri nella voragine addebitabile a Washington, erodendone la presa egemonica in una regione che include l’arsenale nucleare del Pakistan assieme a quello non dichiarato di Israele. Per altro verso, sin dalla guerra contro l’Iraq (1980-1988) alimentata dagli Usa, l’Iran ha investito sulla capacità laica delle Guardie di gestire gli apparati (pure economici) della Repubblica, facendone anche il nerbo coeso del sostegno patriottico – che certo non manca –al sistema, in chiave trasversalmente inclusiva anche sul piano etnico: tanto da configurare uno strumento di promozione sociale non solo per i persiani, ma anche per ampi settori integrati di arabi, curdi e azeri.
E proprio tale elemento strutturale, complica la possibilità per Washington di accantonare il regime change per estorcere concessioni in stile venezuelano, laddove Khamenei venisse meno. Torniamo dunque al punto di partenza, disegnando il circolo vizioso in cui si colloca la china piratesca della strategia trumpiana, complicata dalla difficoltà di fare marcia indietro senza almeno un coup de théâtre, comunque rischioso in una politica ridotta a gioco d’azzardo. Nel poker il bluff non sempre riesce. E l’asso può non scivolare dalla manica.