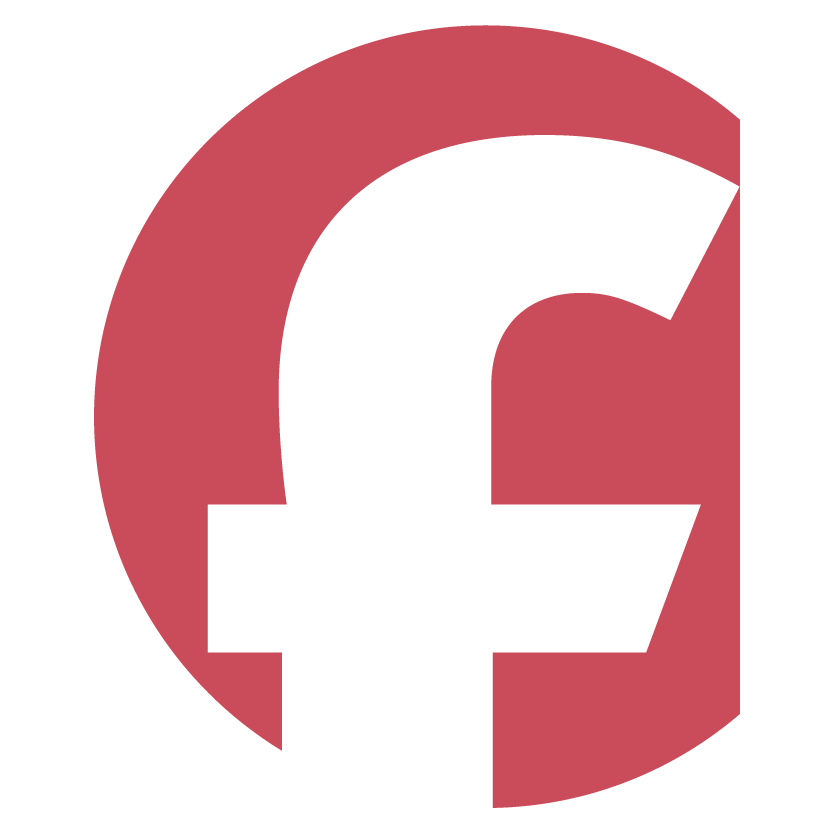 Fatti
Fatti
Guerre per l’acqua, anzi guerre contro l’acqua
Simbolo di vita Emanuele Fantini: «Nei conflitti le risorse idriche diventano strumento di pressione»
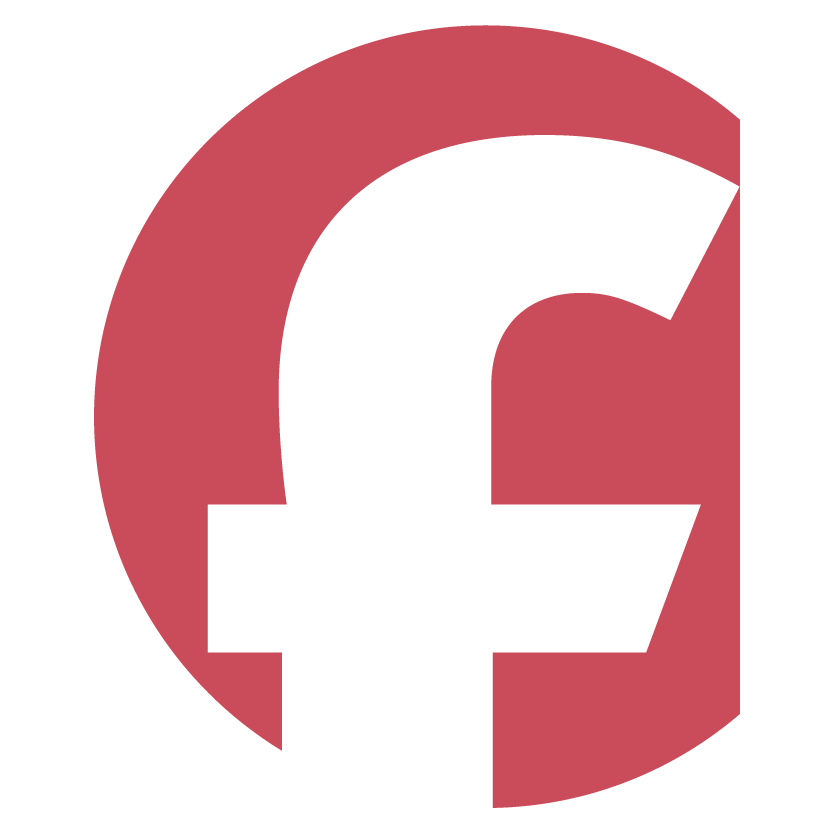 Fatti
FattiSimbolo di vita Emanuele Fantini: «Nei conflitti le risorse idriche diventano strumento di pressione»

“Acqua per la pace”. Quando l’acqua scarseggia o è inquinata, o quando le persone hanno un accesso scarso a questo bene, possono aumentare le tensioni ed è per questo che l’Onu quest’anno ha scelto il legame con la pace, per celebrare la Giornata mondiale dell’acqua il prossimo venerdì 22 marzo. «È dagli anni Novanta del secolo scorso che si parla di guerre per l’acqua, ma lavorando sul Nilo ho imparato che l’acqua non è mai la causa principale delle guerre. Diventa spesso uno strumento di pressione nei conflitti armati come sta accadendo a Gaza: le guerre non si combattono mai per l’acqua ma contro l’acqua, perché questa è simbolo di vita» spiega Emanuele Fantini, ricercatore e insegnante all’Institute for Water Education di Delft, nei Paesi Bassi, e autore del podcast “Si dice acqua”, che si occupa di conflitti internazionali legati all’acqua, del diritto all’acqua e di acqua e sviluppo in Africa. «Lungo il Nilo, l’Etiopia ha completato la costruzione della “Grande diga del rinascimento etiope” che fin dall’inizio ha generato tensioni con l’Egitto e il Sudan, Paesi a valle del Nilo azzurro. Da dieci anni, i tre governi si incontrano per trovare una soluzione, un accordo prima su come costruire e adesso come gestire la diga, ma non lo stanno trovando: però non si sono fatti la guerra per la diga e per il fiume. In Sudan c’è una guerra che non è combattuta per l’acqua ma contro, perché distrugge le infrastrutture e anche i processi di cooperazione che erano in corso per gestire in maniera coordinata le dighe in Etiopia e a valle in Sudan. Processi interrotti, perché anche in Etiopia c’è una guerra – che vede il coinvolgimento dell’Eritrea – nelle regioni in cui si è costruita la diga, e qui l’acqua certamente viene strumentalizzata». Acqua e pace quindi, e come possiamo utilizzare l’acqua quale strumento di pace: «Su questo tema ho partecipato alla realizzazione di una mostra fotografica nella sede Unesco di Parigi, in occasione della presentazione del rapporto annuale sullo stato delle risorse idriche nel mondo: sono arrivate fotografie molto belle ma che non parlano tanto della pace, perché è difficile visualizzare la pace e il legame tra acqua e pace – continua Fantini – Con il progetto “ Everyday Nile” abbiamo coinvolto fotografi dei vari Paesi del bacino del Nilo, perché ci interessava capire e vedere quali sono le storie “a margine”, che le persone hanno col fiume. Nonostante i diversi fotografi abbiamo visto immagini ricorrenti e molto simili: per Etiopia, Kenya e Uganda i fotografi hanno presentato la stessa inquadratura, dimostrando che le persone hanno più cose da condividere con i loro pari che non con le élite del Paese che condividono l’interesse nazionale per l’acqua. Riflettere sul nostro rapporto, sulla nostra connessione col fiume è qualcosa che ci può accomunare e far coltivare un’appartenenza che va al di là delle identità nazionali e in questo senso promuovere una cultura di pace». È il tema giusto? «Sì, è un tema importante, ma dipende da come lo trattiamo – analizza Fantini – L’acqua può essere uno strumento di pace e nella storia dell’uomo condividere un corso d’acqua ha portato i Paesi a cooperare, a siglare accordi e trattati molto più che a farsi la guerra e insisto: le guerre non scoppiano mai per l’acqua, ma poi questa si trova al centro del conflitto perché il suo valore va oltre il consumo e comporta identità e cultura».
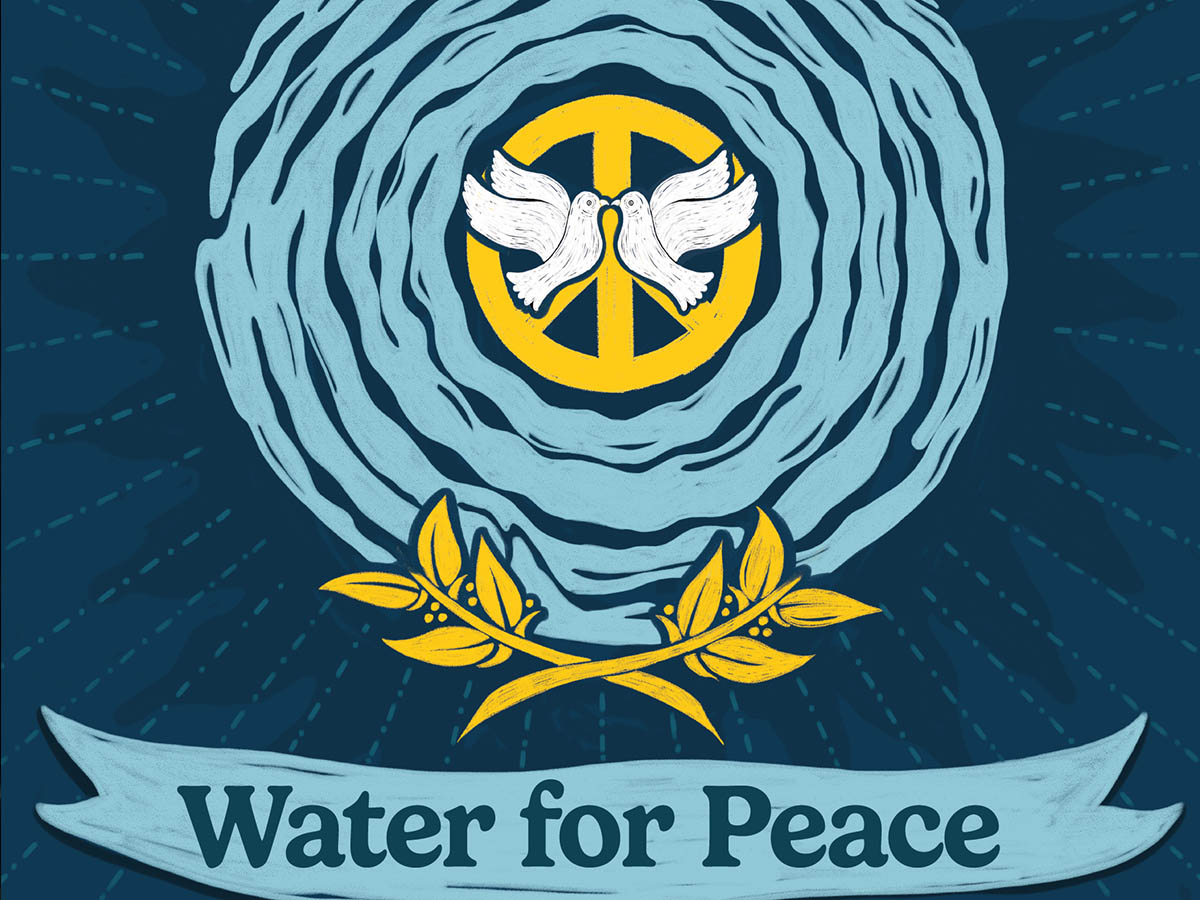
“Creare increspature per un futuro migliore” (il ripple effect è l’effetto a catena) è lo slogan dell’edizione 2024 della Giornata mondiale dell’acqua (che si celebra venerdì 22 marzo) promossa dalle Nazioni Unite e che ha come tema l’acqua per la pace. Più di tre miliardi di persone dipendono dall’acqua che attraversa confini nazionali, ma solo 24 Paesi hanno accordi di cooperazione.
In Italia mediamente il 48 per cento della risorsa idrica utilizzata è destinato al settore agricolo, il 19 per cento ai comparti civile e industriale, il 14 per cento al settore energetico, il resto viene disperso per carenze delle infrastrutture. Nella media europea, invece, il 46 per cento è destinato alla produzione di elettricità, il 30 per cento all’agricoltura, il 14 per cento a scopi civili e il 10 per cento all’industria.
