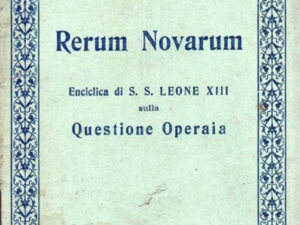Uno dei tanti argomenti su cui si è discusso dopo l’elezione al soglio pontificio di Leone XIV è stato la scelta del nome. Questa trae ispirazione da Vincenzo Gioacchino Pecci (1810-1903), come ha spiegato lo stesso pontefice: «Papa Leone XIII, con la storica enciclica Rerum novarum affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande Rivoluzione industriale. Oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro».
Il discorso sociale della Chiesa
La Rerum novarum (1891) è una delle 86 encicliche scritte da Leone XIII nel suo lungo pontificato (1878-1903). È la più conosciuta perché viene ad aprire ufficialmente il discorso sociale della Chiesa. Lo sfondo è quello del conflitto tra Chiesa e mondo moderno. È un mondo laico, nato fuori e contro la Chiesa, che non solo le toglie gli antichi privilegi, ma s’impegna a ridurne diritti e libertà, sforzandosi di escluderla dalla vita pubblica. La Chiesa reagisce chiudendosi in sé e scomunicando la cultura moderna. Negli ambienti cattolici si respira un clima da cittadella assediata. L’occasione per rompere l’accerchiamento e questa incomunicabilità fu la questione sociale, esplosa con la Rivoluzione industriale. L’industrializzazione, introducendo le macchine nel ciclo produttivo, genera il dramma disumano dei proletari, abbandonati a se stessi e alla voracità del capitale. Moltitudine di operai e di manovali (uomini, donne e bambini) che, per sopravvivere, sono costretti a vendere il loro lavoro come una merce, a salari di fame, a prezzo di umiliazioni e di sfruttamento. La questione operaia diventa così il banco di prova su cui si confrontano le due grandi ideologie dell’Ottocento: il liberismo e il marxismo. Sono due visioni globali e totalizzanti della vita umana, della società e della storia, tra loro opposte e inconciliabili. Sono due filosofie che si fronteggiano si combattono, entrambe figlie della medesima cultura materialistica del mondo moderno. Di fronte al pericolo che la nuova società industriale nasca dominata da un materialismo ideologico di massa, la Chiesa avverte il dovere di ripensare in modo nuovo la sua stessa presenza. Tutta la Rerum novarum, però, non giunge all’improvviso. Nella sua enciclica Leone XIII raccoglie il frutto più maturo di una nuova coscienza sociale, che già da tempo era venuta affermandosi un po’ dappertutto nella Chiesa.
La questione operaia
La prima elaborazione dottrinale dell’insegnamento sociale della Chiesa, contenuta nella Rerum novarum, nasce quindi dal confronto-scontro con le ideologie del socialismo e del liberismo. Leone XIII non si limita alla semplice condanna, ma ne spiega le ragioni dottrinali, contestando all’ideologia del socialismo la pretesa di abolire la proprietà privata e di trasformarla in proprietà collettiva. Non è questa la via per risolvere la questione operaia. Così facendo si otterrà solo il risultato di rendere la situazione degli operai più precaria: «Togliendo all’operaio la libertà di investire le proprie mercedi, gli rapiscono il diritto e la speranza di trarre vantaggio dal patrimonio domestico e di migliorare il proprio stato, e ne rendono perciò più infelice la condizione» (n. 4). Oggi, dopo la caduta del muro di Berlino (1989), nessuno può negare la tragica verità di questo giudizio dell’enciclica. L’abolizione della proprietà privata non ha risolto i problemi della questione operaia, ma ha fatto nascere un vero e proprio capitalismo di Stato, riproponendo in forma ancor più grave i drammi della povertà, della schiavitù e dell’alienazione delle masse proletarie, che Marx voleva scientificamente evitare. La ragione – spiega l’enciclica – è di natura etica e di principio. Infatti, poiché la proprietà privata è un diritto naturale, la sua abolizione è una ingiustizia e, come tale, porterà ineluttabilmente a sconvolgere l’intero ordine sociale. Dopo aver confutato il socialismo sul piano stesso dei principi generali della filosofia sociale cristiana, l’enciclica passa a confutare l’ideologia liberale sul medesimo piano. Non la nomina esplicitamente, ma ne indebolisce i presupposti filosofici ed etici, attraverso l’esposizione di alcuni dei grandi principi della Dottrina sociale della Chiesa.
Dignità dell’uomo e del lavoro
Il primo principio è la dignità della persona umana e quindi del lavoro dell’uomo. I ricchi e i padroni – dice Leone XIII – «non devono trattare l’operaio da schiavo; devono rispettare in lui la dignità della persona umana… Agli occhi della ragione e della fede, il lavoro non degrada l’uomo, anzi lo nobilita… Quello che veramente è indegno dell’uomo è di usarlo come vile strumento di guadagno, e di stimarlo solo per quel che valgono le sue energie fisiche» (n. 16). Il secondo principio è che l’economia ha una sua dimensione etica, proprio in quanto essa è essenzialmente orientata al servizio dell’uomo. Anche questo principio è in aperta antitesi all’ideologia liberale, che ha sempre sostenuto l’estraneità del concetto di moralità al processo economico, il quale invece seguirebbe le regole del mercato. Il terzo principio è la necessità che lo Stato intervenga nella questione sociale ed economica, aiutando i più bisognosi: «È compito proprio dello Stato provvedere al bene comune» (n. 26). L’enciclica chiarisce che «la classe dei ricchi, forte per se stessa, ha meno bisogno della difesa pubblica. La classe proletaria invece, che manca di sostegno proprio, conta soprattutto sulla protezione dello Stato. Lo Stato si faccia, dunque, particolarmente difensore dei lavoratori, che appartengono alla classe povera» (n. 29).
Premesse feconde e rivoluzionarie
Nonostante i limiti e i condizionamenti storici di natura culturale e teologica, il discorso sociale aperto da Leone XIII poneva alcune premesse, che si sarebbero rivelate feconde e rivoluzionarie. Dopo la rottura tra Vangelo e cultura, questa enciclica è il primo passo in aperta controtendenza. È l’ammissione della necessità di mediare tra fede e storia, tra principi etici e prassi sociale.