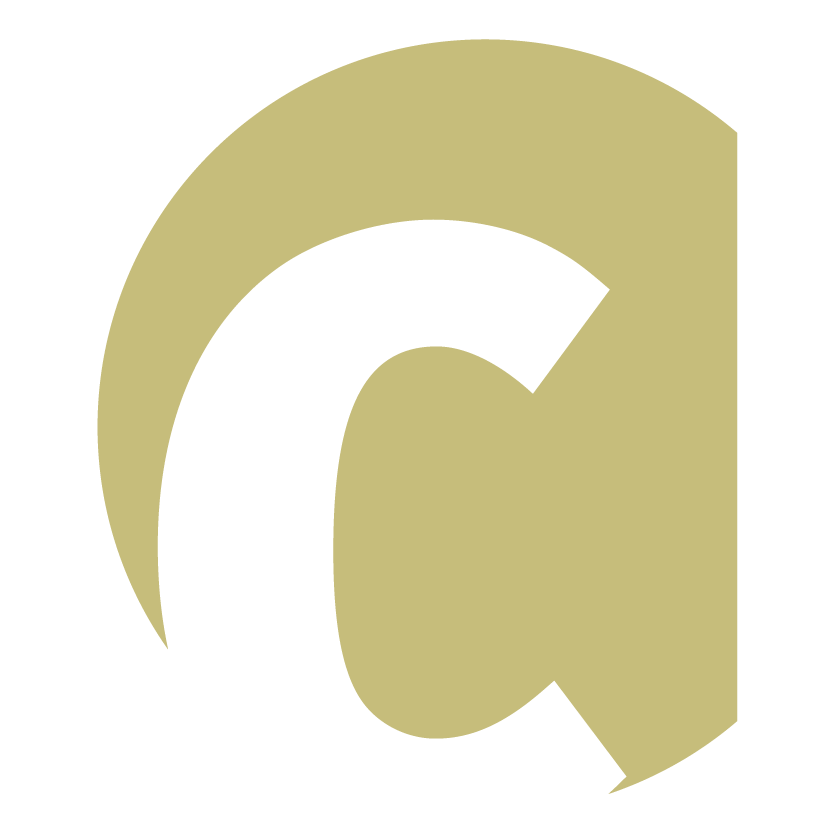Ogni volta che viaggiando si arriva in una località nuova, il primo passo è quello di cercare l’albergo dove si dovrà alloggiare, quando si arriva per la prima volta ad Hiroshima invece non si può fare a meno di cercare istintivamente con lo sguardo, già dall’oblò dell’aereo mentre si sta atterrando, la Cupola della bomba atomica, immediata memoria di quanto accaduto il 6 agosto 1945. Alle ore 8,15 di quel giorno di 80 anni fa, al termine della Seconda guerra mondiale, un aereo dell’Aeronautica militare statunitense sganciò sulla città giapponese “Little Boy”, una bomba atomica di 3 metri di lunghezza e 4073 chilogrammi di peso, con 64,13 chilogrammi di uranio arricchito all’80%, che causò la distruzione completa del 90% degli edifici e la morte sul colpo di 70/80mila persone. In un attimo veniva spazzata via una città popolosa come Verona, bruciata da una potenza 100 milioni di gradi celsius, cioè più caldo del sole, con conseguenze che causarono altri 70mila morti circa entro la fine dell’anno e ricadute, in termini sia di salute umana sia ambientali che, come denunciato dalla Croce rossa, si sono protratti fino ai giorni nostri, con migliaia di persone curate a causa delle malattie legate alle radiazioni.
Tre giorni dopo, il 9 agosto 1945 alle ore 11,02, l’aeronautica militare statunitense sganciò su Nagasaky, un’altra città del Giappone, “Fat Man”, una bomba atomica di oltre 3 metri di lunghezza e del peso di 4545 chilogrammi. La stima totale delle vittime dei 2 bombardamenti si aggira sulle 200mila persone, quasi tutte civili.
Il ricordo di così tanta violenza e distruzione è proprio la “Genbaku Domu”, cioè Cupola della bomba atomica, uno scheletro di cemento e ferro di quella che è stata la sala della prefettura per la promozione industriale progettata e realizzata dall’architetto ceco Jan Letzel, in seguito rinominata “Memoriale della pace di Hiroshima”, divenute nel 1996 sito Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, seppur con l’opposizione di Cina e Stati Uniti d’America. I primi alludendo che i giapponesi, descritti come “queste poche persone” al confronto con gli altri popoli asiatici che avevano registrato maggiori perdite durante la Seconda guerra mondiale, avrebbero potuto usare questa per scopi dannosi alla salvaguardia della pace e della sicurezza mondiale; gli altri perché questa scelta li avrebbe “preoccupati per la mancanza di prospettiva storica” non facendo comprendere gli eventi antecedenti l’uso delle armi atomiche.
Oggi questo monumento commemorativo si trova al termine di una grande strada che attraversa tutto un parco di oltre 12mila mq completamente dedicato alla riflessione sulle conseguenze della guerra, dove al centro si trova la Fiamma della pace che arde giorno e notte, la Campana della pace ed il Monumento dei bambini per la pace, e dalla parte opposta è stato realizzato il Museo memoriale della pace di Hiroshima, aperto nel 1955 con l’intento di promuovere la pace nella speranza che la storia non si ripeta. Dettagli indispensabili questi per riuscire a capire e giustificare i sentimenti che ti assalgono mentre, percorrendo la strada che costeggia il fiume Ōta, inizi a vedere da lontano quella cupola e ti vengono i brividi mentre ti tornano alla memoria le scene delle esplosioni nel film “The day after” del 1983 diretto da Nicholas Meyer,
ricordi i racconti dei nonni e le lezioni di storia, e ti vergogni di essere l’ipotetico nipote di gente che avrebbe potuto evitare questo.
Ti assale un senso di angoscia, ti diventano gli occhi lucidi e ti sembra di sentire tutta la sofferenza di chi ha vissuto quei momenti terribili nel 1945, soprattutto quando proprio difronte a quel monumento, dall’altra sponda del fiume, una signora giapponese molto anziana seduta su una carrozzina, accompagnata da una persona giovane che potrebbe essere suo nipote, guarda verso la Cupola della bomba atomica e, senza parlare, protrae le mani in quella direzione, sembra meditare e ricordare. Ha gli occhi umidi che brillano alla luce del lampione, la bocca serrata, le mani provate dal tempo. Qualche minuto dopo abbassa il capo, gira la testa da una parte. Il ragazzo che l’ha accompagnata capisce che è il momento di sbloccare le ruote della carrozzina e spingerla verso casa. La coscienza di quel luogo è quella donna, una persona come tante altre che si possono ritrovare nel Museo memoriale della pace di Hiroshima, dove sono raccolti i racconti dei pochissimi sopravvissuti, le foto di chi è stato ferito, gli oggetti di chi ha perso la vita, come ad esempio il triciclo di un bambino di 3 anni.
Fanno male agli occhi quelle immagini che raccontano la sofferenza patita da chi è stato acciecato da quella luce potentissima, di chi ha visto la sua pelle venire via come carta velina bagnata, le unghie liquefatte, i capelli cadergli dalla testa, il corpo trasformato dagli effetti del “fall-out”, la ricaduta radioattiva dell’esplosione nucleare.
Vedere cosa è successo non è importante, è fondamentale, perché quella coscienza maturi in ognuno di noi. Come nell’animo di quei giovani che, una volta attraversato il ponte della National Route 183 e girato l’angolo per arrivare proprio sotto quel masso dove in giapponese è scritto “consolazione”, si animano con musica, cartelli e volantini da distribuire ai passanti per manifestare la loro obiezione ai bombardamenti su Gaza, in Palestina.
Un sentimento che conoscono bene tutti coloro che, pur non avendo scelto di entrare in guerra, hanno dovuto viverne le conseguenze e che, il 6 agosto di ogni anno, organizzano una cerimonia per commemorare le vittime del 1945 e pregare per una pace duratura, radunandosi dalla mattina presto davanti al cenotafio delle vittime della bomba A per attendere il suono della campana alle ore 8,15, assieme a chiunque voglia partecipare, da qualsiasi parte del mondo provenga. La sera dello stesso giorno anche il rito suggestivo delle lanterne fatte galleggiare sul fiume Ōta, usanza che sembrerebbe essere iniziata poco dopo la fine della Seconda guerra mondiale, per mano degli stessi sopravvissuti.