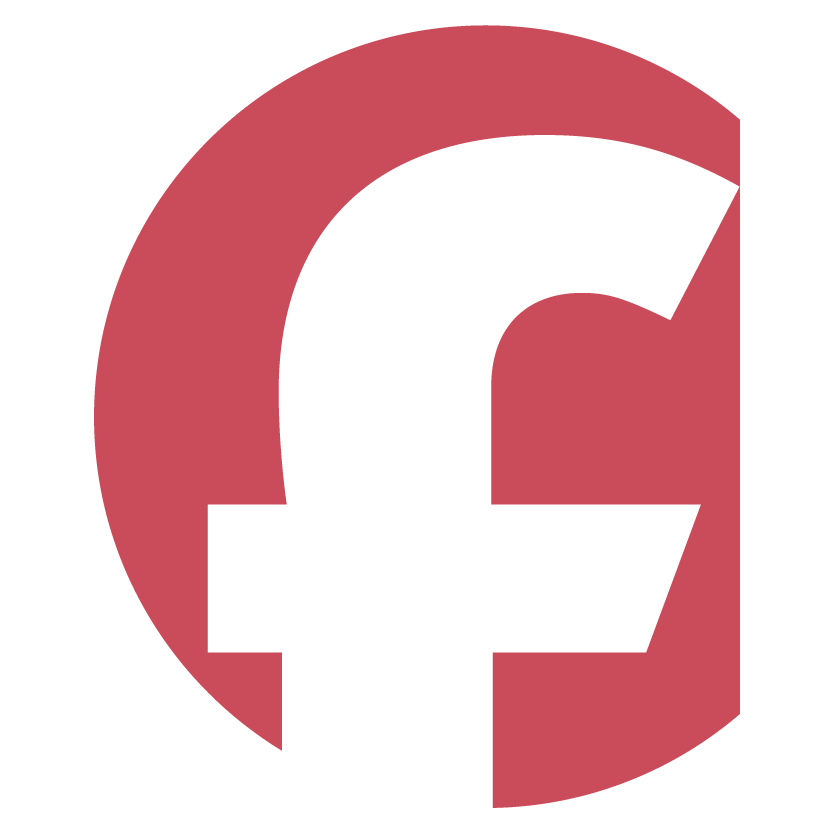«Abbiamo troppo sottovalutato il dolore della mente ed oggi ne stiamo pagando le conseguenze». Non usa giri di parole Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento. Il 23 settembre la docente è intervenuta al XXIII Convegno internazionale di suicidologia e salute pubblica, promosso alla Sapienza Università di Roma e presieduto da Maurizio Pompili, professore ordinario di psichiatria, direttore della Scuola di specializzazione in Psichiatria presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Ateneo. Mentre è ancora viva l’eco del tragico gesto del quattordicenne Paolo Mendico, e l’Oms certifica che in Italia il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani, in occasione del convegno abbiamo raggiunto la professoressa (nella foto) che ha proposto una special lecture dal titolo potente: “Il dolore: dalla cellula all’Io”.
Professoressa Lucangeli, lei invita a superare il dualismo corpo-mente. Che significa?
«Significa riconoscere che il dolore non è solo fisico o solo mentale, ma è un segnale che coinvolge l’intero organismo vivente. La coscienza, che ci rende capaci di sentire, riconosce e risponde ai segnali di dolore secondo leggi filogenetiche, ossia di specie. Non possiamo più ignorare il dolore della mente come se fosse secondario: è parte integrante della nostra sopravvivenza».
Lei afferma che il suicidio non è un gesto improvviso ma un processo graduale. Come si sviluppa?
«Togliersi la vita non è un atto improvviso dovuto a un effetto traumatico, bensì l’esito di una lunga condizione di non tolleranza del segnale di dolore che si accumula, goccia dopo goccia, fino a rendere la vita insostenibile. Non è un gesto contro la vita, ma contro un dolore che non trova vie d’uscita. Per questo è fondamentale intervenire prima, riconoscendo i segnali e agendo per cambiare il sistema educante».
Che cosa intende per “sistema educante” e qual è il suo ruolo in questa dinamica?
«Il sistema educante non è solo la scuola, ma anche la famiglia e la società. È un sistema partecipato di “nuclei sociali” che devono “imparare” a riconoscere e decodificare i segnali del dolore, perché agiscono come “mirror di riferimento”, essenziali per i giovani, ma anche per ogni individuo. Senza questo “specchio”, il senso di sé si frantuma».
Lei parla spesso dell’importanza dello sguardo. Perché?
«Perché l’essere umano, come specie sociale, si definisce attraverso lo sguardo dell’altro. Se un ragazzo riceve dalle figure per lui significative un rimando costantemente negativo, si sente invisibile, non degno di sguardo. E quando ci si sente non visti o non riconosciuti nella propria interezza, si perde il senso del proprio valore. L’autolesionismo e il suicidio possono nascere anche da questa invisibilità».
Al convegno lei ha presentato i dati di una ricerca sul “Parental Phubbing”. Di che cosa si tratta?
«È un comportamento genitoriale che implica l’ignorare i figli. Una negazione dello sguardo, del riconoscimento. Come abbiamo appena detto, i bambini e gli adolescenti hanno bisogno di sentirsi visti per sentirsi amati. Non si tratta di un meccanismo mentale ma di un meccanismo di sopravvivenza di specie. Quando questo manca, si attiva un meccanismo neurofisiologico che genera dolore.
Il suicidio di un adolescente, oltre ad essere dolorosissimo, viene considerato un atto “contro natura”…
Sì, contro natura e “contro tempo evolutivo” perché l’adolescenza rappresenta la fase della massima pulsione vitale, il momento in cui si desidera vivere, autoaffermarsi, esplorare. Sebbene nella cultura classica – da Goethe a Le ultime lettere di Jacopo Ortis – si trovi sempre un’ambivalenza tra il massimo di pulsione di vita e il massimo di pulsione di morte, quello che oggi stupisce è l’età in cui si verificano i suicidi. Quando la tensione alla vita di un adolescente non trova valore nel riflesso dello sguardo altrui, può emergere la pulsione di morte. Un cortocircuito evolutivo che dobbiamo imparare a prevenire».
Quale messaggio vorrebbe lasciare a educatori, genitori e società?
«Che il dolore mentale va riconosciuto, ascoltato e accolto. Abbiamo troppo sottovalutato il dolore della mente, come se la mente fosse la “schiuma delle onde della vita”, un rischio che si sta pagando a diversi livelli perché la mente non è la schiuma, bensì la forza vettore dell’onda, e il processo senziente, ossia quello per cui si prova qualcosa, è il processo decisionale: se si sente costantemente dolore, ad un certo punto si può arrivare a “togliersi”. E poi che lo sguardo deve essere autentico, non giudicante. Che ogni ragazzo ha bisogno di sentirsi visto così com’è, non secondo un prototipo. Solo in questo modo è possibile costruire un sistema educante in grado di aiutare a salvare vite.