 Idee
Idee
Dopo l’aggressione di una docente ad Abbiategrasso la scuola è sotto esame
Il dibattito tra pedagogisti e insegnati pochi giorni dopo che un sedicenne ha accoltellato in classe un’insegnante ad Abbiategrasso
 Idee
IdeeIl dibattito tra pedagogisti e insegnati pochi giorni dopo che un sedicenne ha accoltellato in classe un’insegnante ad Abbiategrasso
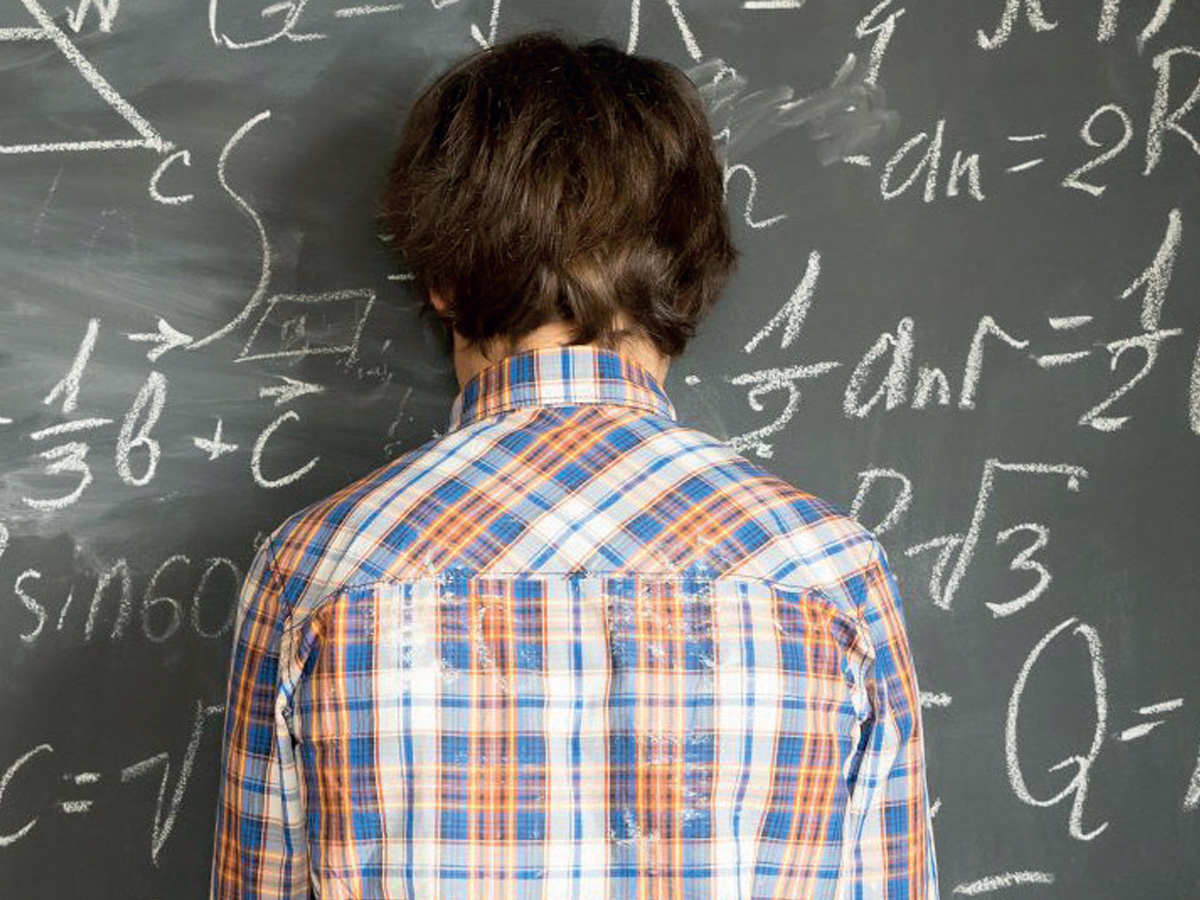
Secondo i dati del ministero dell’Istruzione e del Merito in Italia avvengono cinque episodi di violenza sui docenti ogni mese, e molti vengono filmati e postati sui social. Il più recente, l’aggressione a un’insegnante presso il liceo scientifico dell’istituto Alessandrini di Abbiategrasso, è solo l’ultimo di una lunga serie. Il fatto accaduto il 29 maggio è subìto balzato alle cronache di tutto il Paese, sia per la gravità, dato che la professoressa è stata colpita più volte al braccio con un coltello da caccia e ha subito un intervento di ricostruzione durato sei ore, sia per un considerevole aumento degli episodi nell’ultimo anno. Nella maggior parte dei casi si tratta di aggressioni verbali, come insulti o risposte fuori luogo, ma in un 18 per cento si arriva anche alle violenze fisiche. Viene spontaneo interrogarsi sul perché di tutto questo: da una parte si capisce come sia minata la figura del docente e quanto sia necessario restituirle autorevolezza e credibilità, ma dall’altra bisogna anche colmare lo scollamento che la scuola sta vivendo con la società attuale. Per il ministro Giuseppe Valditara bisogna lavorare molto sul rapporto con le famiglie: «Ho chiesto alle associazioni di genitori di sederci attorno a un tavolo per discutere di questi problemi» ha dichiarato, riconoscendo che c’è stato un cambiamento che ha provocato «un allontanamento delle famiglie dalla scuola, una tensione che dobbiamo cercare di ricomporre».Ma allora, quale preparazione deve avere oggi un docente e che ruolo deve assumere quando è in classe?Per la pedagogista Daniela Fassina, che si occupa dei problemi dell’apprendimento in età evolutiva anche attraverso la formazione dei docenti, «l’evoluzione che la società sta vivendo richiede alla scuola adeguamenti veloci e non sempre facili, per cui gli insegnanti si trovano a dover mettere in campo competenze nuove e ad aver bisogno di figure esperte. Chi si trova davanti a comportamenti non adeguati, come è successo nel caso del sedicenne di Abbiategrasso, deve farsi la domanda “che cosa mi sta chiedendo?”, perché quelli che vengono visti come semplici dispetti, o atteggiamenti di disturbo, sono in realtà dei segnali di palese richiesta di aiuto. Accanirsi in ammonimenti continui non serve a nulla in questo caso; se i provvedimenti disciplinari vengono ignorati bisogna coinvolgere la famiglia, ma soprattutto affidarsi a degli specialisti che sappiano interpretare questi segnali».Questo aumento di disagi nei giovani può essere una conseguenza del Covid-19?«Il Covid possiamo leggerlo come una lente d’ingrandimento che ha magnificato ciò che già c’era, ma non può diventare una scusa. Sicuramente ha fatto dei danni, ma in questo caso ha soltanto messo in luce delle fragilità precedenti. Se vogliamo, ha accelerato un processo di cambiamento in atto nel delegare il rapporto con le famiglie a sistemi come le piattaforme. Lo strumento principale di comunicazione tra scuola e famiglia è per esempio il registro elettronico, ma mentre una volta si chiedeva al genitore di firmare, ora per riscontro di visione basta un flag (il segno di spunta, ndg); purtroppo qualche volta è il ragazzo stesso a farlo, poiché ci sono genitori che, per pigrizia o mancata dimestichezza, lasciano le proprie password ai figli per farsi le giustificazioni da soli».
Anche il rapporto personale con il genitore si è molto sminuito, si continuano a fare i colloqui a distanza, c’è poca comunicazione. E riguardo al rapporto con gli alunni?«Spesso un ragazzo del 2023 quando entra a scuola fa un salto indietro, approcciandosi con metodi che sono ancora quelli degli anni Ottanta: dimentichiamo che i bambini imparano a usare prima il telefonino che la penna. Pochi docenti sanno creare una lezione interattiva che sia ancorata alla realtà. Si continua a fare lezioni frontali basate esclusivamente sui testi, dove il verbale prevale sull’immagine e le valutazioni sono spesso prove scritte, perciò il colloquio con l’insegnante viene meno. Molti docenti mi dicono che hanno troppi alunni per riuscire a fare colloqui individuali, ma questo sacrifica la relazione personale che si crea con i propri studenti».E il ruolo del genitore andrebbe rivisto?«Il genitore oggi tende a lasciare ai figli molta libertà e a essere sempre meno presente fisicamente nelle relazioni, cioè non c’è un contenimento mentale del figlio e anche la genitorialità spesso diventa virtuale perciò quando ci sono dei bisogni arriva a capirli solo quando la situazione esplode, senza saper leggere i campanelli d’allarme. Si tende a delegare altri a occuparsene, gli stessi insegnanti per esempio, che però non hanno strumenti adeguati, e in sostanza i ragazzi rimangono abbandonati a se stessi, non trovando nella scuola un ambiente dove si possono riconoscere, che li obbliga a stare seduti molte ore e senza cellulare. Da qui all’abbandono il passo è breve; cercano realizzazione altrove aumentando la dispersione scolastica».Cosa si può fare per migliorare l’ambiente scolastico?«La scuola ha perso autorevolezza perché la società non è più gerarchica; prima c’era una scala ben definita dove la disciplina aveva un valore morale riconosciuto; in sostanza si viveva in un sistema semplice di valori, mentre nella fluidità di oggi è tutto più complesso, per cui il docente si trova ad applicare un comportamento disciplinare in una società dove la disciplina ha un senso relativo. Piuttosto di dare una nota è più efficace allora alzare la qualità del rapporto educativo e la relazione personale. Fare l’insegnante oggigiorno richiede uno spessore non indifferente; non basta più solo conoscere la materia, ci sono esigenze più profonde. Ora si sta introducendo la figura del tutor ma non basta, bisogna affiancare agli insegnanti degli specialisti, come gli psicologi dell’età evolutiva o i pedagogisti, che sappiano creare una rete sinergica e di fiducia tra gli alunni, le famiglie e la scuola. Solo così il rapporto educativo può migliorare e prendersi cura dell’alunno come individuo, non solo come un nome sul registro».
La riflessione di Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell’Ordine delle psicologhe e psicologi del Veneto: «La psicologia a scuola è innanzitutto prevenzione, collaborazione con il tessuto scolastico e progettazione di interventi, affinché la comunità scolastica possa vivere, crescere ed educare alla vita adulta in un ambiente sano. Potrebbe essere fuorviante creare l’aspettativa di un intervento “spegni-incendio” e anche stigmatizzante passare il messaggio che lo psicologo è a scuola per studenti con disagio. I 40 milioni di euro stanziati nel 2020 per finanziare il progetto in periodo emergenziale non hanno trovato continuità, nonostante il bisogno enorme espresso e i feedback positivi da parte di dirigenti e famiglie. È importante ribadire che l’Italia è tra le pochissime Nazioni europee dove non è prevista strutturalmente la figura dello psicologo scolastico».
Negli anni scolastici 2020-21 e 2021-22, durante la pandemia, era stato siglato un protocollo tra l’Ordine degli psicologi e il ministero dell’Istruzione per l’attivazione di consulenze psicologiche nelle scuole italiane e il 70 per cento degli istituti lo ha fatto, con risultati positivi. Nel 2022 il protocollo non è stato rinnovato.
