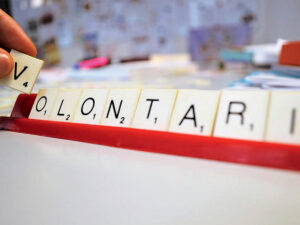C’è chi vira sull’immagine funesta, un intero Paese “a catafascio”, a rotoli, come di un ingranaggio che si inceppa bloccando tutto il sistema. Altri, invece, usano la metafora, ugualmente impattante, di un bosco che gradualmente si desertifica. Questo sarebbe lo scenario distopico e al collasso se il terzo settore, così innervato e presente nel tessuto vitale, dovesse venir meno. Sì perché il volontariato da una parte forma le radici di una comunità, che sa darsi risposte esistenziali e tiene assieme una rete di inclusione; dall’altro fa crescere foglie fiorenti, ha la grande capacità di anticipare le esigenze sociali, le porta all’attenzione della politica e delle istituzioni che poi le mettono a sistema, producendo le norme. Il terzo settore è un sistema sociale ed economico che si affianca alle istituzioni pubbliche e al mercato e che interagisce con entrambi per l’interesse delle comunità. Anzi non solo si affianca, ma ne completa l’esistenza, è anello di congiunzione. Solidarietà, relazioni, resilienza, capacità di sviluppare un vero welfare di comunità e generativo: «Il volontariato colma aspetti che l’istituzione non riesce a prendere in mano – spiega Luca Marcon, presidente del Csv di Padova – Del resto, riflettiamo: se andassimo indietro nel tempo, il gesto della gratuità, del dono è sempre presente nelle fasi storiche dell’uomo, prim’ancora della nascita delle istituzioni. Ecco: la sola parte istituzionale riuscirebbe a sopravvivere? No. Certo, ora l’istituzione vuole normare, regolare, senza accorgersi che determinate attitudini seguono una sorta di solidarietà sociale, quasi un diritto naturale dell’uomo. La sanità, quella che abbiamo noi oggi, universale, fiore all’occhiello anche a livello europeo, è partita dalle mutue, senza il sistema nazionale». Conta il terzo settore, eccome se conta, non solo per i numeri, ma anche per quello che concretamente fa. In Italia sono più di cinque milioni di volontari, che donano sé stessi, il loro tempo, professionalità e disponibilità nonostante scartoffie e cavilli burocratici, norme e altri procedimenti che rallentano, ingolfano la macchina.
Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia si contano nel 2019 365.634 organizzazioni non profit, un incremento del 52,8 per cento rispetto a inizio secolo, per un totale di 861.919 dipendenti. «Il terzo settore della Regione Veneto – illustra Maria Carla Midena, direttrice dei servizi sociali regionali e componente del consiglio nazionale del terzo settore – è composto da un mosaico eterogeneo di enti impegnati in diversi ambiti, dall’assistenza alle persone vulnerabili e con disabilità, alla tutela dell’ambiente, ai servizi sanitari e socio-assistenziali, all’animazione, alla promozione culturale e sportiva, alla tutela del bene comune e alla salvaguardia dei diritti negati. Questa varietà di enti è unita da un comune denominatore: la vocazione per l’interesse generale della comunità. Per comprendere l’impatto sociale del terzo settore in Veneto è importante darne una dimensione numerica: nella nostra regione risultano attive complessivamente 31.035 associazioni per 80.025 dipendenti. Un supporto preziosissimo». Un ruolo essenziale che, in qualche modo, il legislatore ha voluto riconoscere, riorganizzando tutta la disciplina attraverso l’adozione del D.lgs. 117/2017, il cosiddetto Codice del terzo settore: in particolare il Runts, il Registro unico nazionale del terzo settore, rappresenta uno strumento innovativo di trasparenza, accessibilità e conoscenza delle realtà. Più in generale, la riforma mira ad assicurare a livello nazionale omogeneità e uniformità nelle procedure, consentendo agli enti stessi di fare rete tra loro per condividere le competenze al fine di implementare e migliorare il sistema del welfare. Ma. Esiste, ovviamente un enorme e preoccupante “ma”: «Non si può non sottolineare che questa riforma richiede importanti adempimenti burocratici e procedurali a carico delle associazioni – riflette Maria Carla Midena – Aspetto che ha creato difficoltà nel terzo settore veneto, che si articola in realtà associative prevalentemente di piccole dimensioni, strettamente collegate alle proprie comunità, parrocchie e territori. Questa dimensione va tenuta in considerazione come elemento di possibile criticità, alla luce degli importanti adempimenti». Come se non bastassero le difficoltà causate dalla pandemia e dall’emergenza ucraina. Prendiamo per esempio l’obbligo di partita iva per tutte le associazioni – anche per le realtà che hanno bilanci inferiori a cinquemila euro – a fine 2021 era stato introdotto nella Finanziaria, salvo poi congelarlo per due anni. Procede, invece, la proposta di legge, (approvata in aprile in Senato e ora è all’esame della Camera) il cui primo firmatario è il leghista Gianfranco Rufa, che prevede che il 5 per mille vada ad alimentare, tra le altre cose, il fondo per l’assistenza del personale di tutti i corpi dello Stato, polizia, carabinieri, finanza, guardie carcerarie, esercito, marina e aeronautica. Eppure la stessa legge ha un altro spirito e cioè sostenere le attività sociali o della ricerca scientifica che diversamente non si potrebbero realizzare.
«La riforma apre opportunità importanti di co-progettazione e co-programmazione con gli enti pubblici – ammette Niccolò Gennaro, direttore generale Csv di Padova – Nella sua impostazione generale, però, mettendo sullo stesso piano una serie di soggetti giuridici e richiedendo standard e adempimenti uguali per tutti, l’effetto che produce è uno schiacciamento per una serie di procedure e oneri amministrativi che i soggetti strutturati hanno modo di gestire abbastanza facilmente, mentre diventano montagne insormontabili per le organizzazioni di piccole dimensioni. Il terzo settore percepisce questa riforma come un atto che ha messo da parte i valori, il senso e l’approccio all’azione volontaria, collocando al centro aspetti formali, burocratici e amministrativi: sembra mettere ostacoli al prendersi cura del bene comune». E questo è molto frustrante e genera una serie di conseguenze tra cui ricomprendere normativamente le forme più spontanee: gruppi di giovani, organizzazioni di volontariato informali a cui basta avere una chat su WhatsApp, davanti al quadro complesso su cosa è necessario per ottenere l’iscrizione e il timbro di riconoscimento Ats (Associazione temporanea di scopo), preferiscono rimanere nell’informalità. Nel 2021, prima dell’avvio della trasmigrazione al Runts si contavano nel Padovano 493 organizzazioni di volontariato (Odv) e 627 associazioni di promozione sociale (Aps), in Polesine 288 Odv e 140 Aps. A oggi, le associazioni in fase di trasmigrazione risultano in totale 1.369 con una “perdita” del 10 per cento delle Aps e del 15 per cento delle Odv. Pertanto, nel passaggio “burocratico” di anagrafica tra i registri regionali e il Runts le associazioni che hanno deciso di non procedere sono 180 e probabilmente altre bloccheranno la procedura di trasmigrazione per le incombenze richieste prima di arrivare all’esito finale. Ciò significa che queste associazioni non potranno più accedere al 5 per mille, a fondi nazionali e regionali dedicati ai soli enti iscritti al Runts, e incontreranno maggiori difficoltà a relazionarsi con la pubblica amministrazione. «Il rischio è l’esclusione di questi gruppi da percorsi di dialogo con la pubblica amministrazione, quasi che prendersi cura del bene comune possa uscire dall’ambito della “legalità”– è il pensiero finale di Niccolò Gennaro – In alcuni casi abbiamo visto che i Comuni richiedono il riconoscimento di Ats per concedere spazi e contributi e queste associazioni, anche storiche, rischiano di non avere più i requisiti per poter agire con serenità».
Adempimenti ostili per chi vuole operare
Luca Marcon: «Questa riforma, significa togliere energie al volontariato, in termini di tempo e di risorse economiche, per oneri burocratici che non hanno scopo migliorativo, ma sono frutto di una brutta interpretazione normativa. L’idea è nobile, dare parametri e trasparenza, ma richiede adempimenti ostili, soprattutto per quelli che per mentalità sono proiettati a operare, al fare».
Nella cultura, due volontari su tre
Osservando il panorama italiano, sono in crescita le istituzioni attive nei settori della tutela dei diritti e attività politica (più 9,9 per cento), dell’assistenza sociale e protezione civile (più 4,1 per cento), della filantropia e promozione del volontariato (più 3,9 per cento) e delle relazioni sindacali (più 3,7 per cento). Ma è il settore della cultura, sport e ricreazione a raccogliere quasi due terzi complessivi (64,4 per cento), seguito da quelli dell’assistenza sociale e protezione civile (9,3 per cento). Un divario notevole.