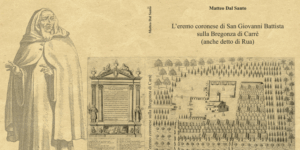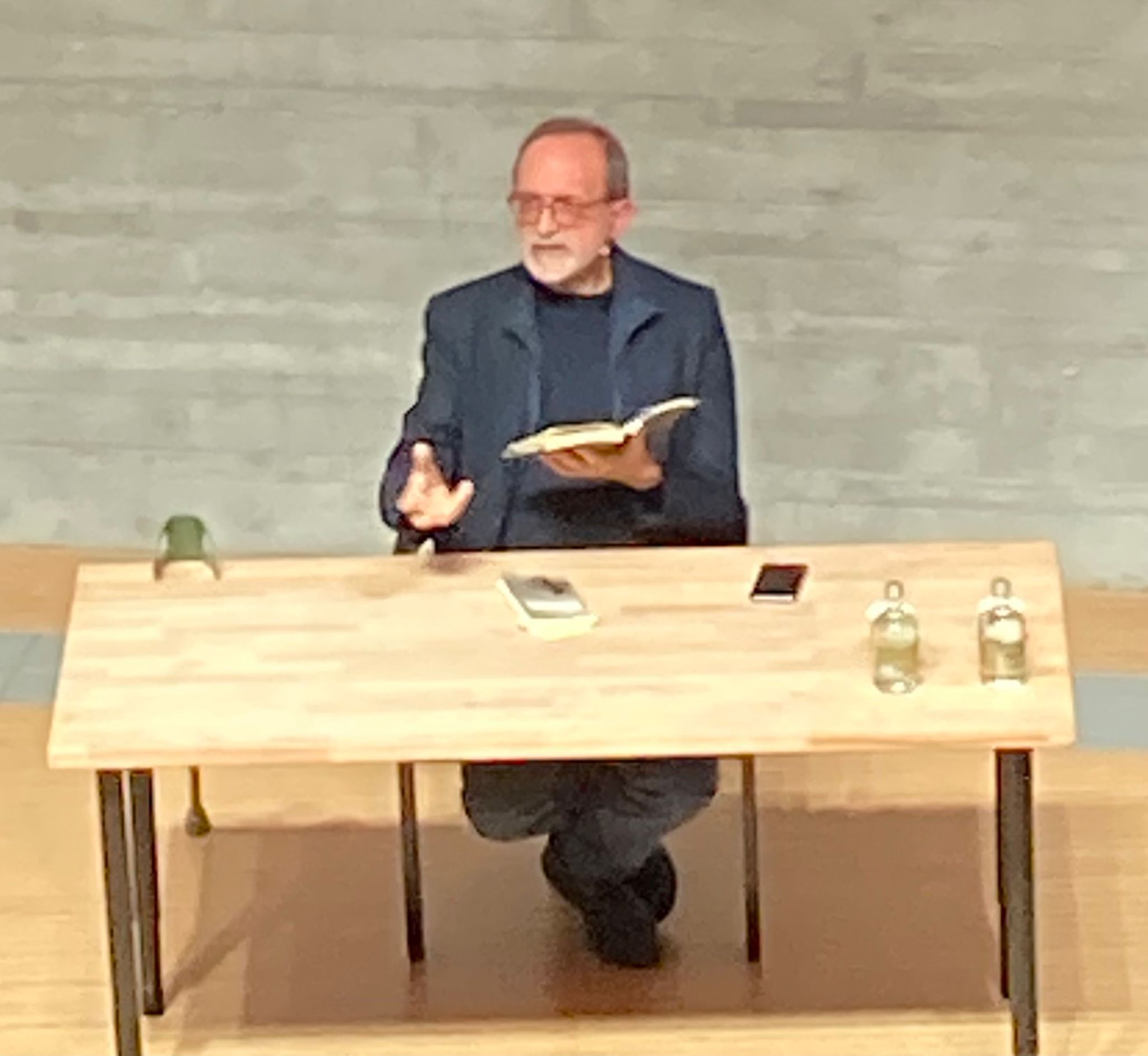
Una vera e propria lectio teatrale nell’auditorium Cesare De Michelis, durante le “tappe” del Festival delle idee 2025 all’interno del museo multimediale M9 di Mestre. Gabriele Vacis, sulla soglia dei 70 anni, si cimenta di nuovo con Luigi Meneghello con piglio piemontese insieme all’eco genetica di un Veneto che non c’è più…
E racconta di Libera nos a Malo che ignorava: «Il libro me l’ha regalato uno spettatore, dicendo “Se lo legge, ci fa uno spettacolo”. Io l’ho letto. E con Marco Paolini e Antonia Spaliviero nel 1990 lo abbiamo messo in scena. Lo abbiamo ripreso, nel 2005, con Natalino Balasso. Con Meneghello, poi, diventammo anche amici».
Sfoglia il volume e rilegge i ricordi. «Tradurre un romanzo sul palcoscenico impone necessariamente scelte in funzione dell’ora e un quarto che dura lo spettacolo. E alla fine arrivavano sempre sciami di meneghelliani che abbiamo capito essere… una setta. Ci dicevano che manca quell’episodio o come avevamo potuto dimenticare quel personaggio e che la signora Viola non si può liquidare in tre minuti. Da parte mia, resto legato alla scena dei bromboli che salgono a gara nella lapide dei caduti nella Grande Guerra…» sorride il drammaturgo con una laurea in Architettura prima di fondare il Laboratorio teatro settimo, senza dimenticare che dal 2018 fino al 2021 ha diretto la Scuola per attori del Teatro stabile di Torino.
Qual è lo stato di salute del teatro, dopo il silenzio imposto dal Covid?
«Il Covid ha evidenziato un carattere del teatro: la presenza. Cioè il teatro avviene in presenza. E facciamo il teatro ai tempi di Netflix, neanche più ai tempi del cinema eh, perché sono altri tempi questi, tempi dei social, dello streaming. E ciò significa che la caratteristica fondamentale del teatro, la ragione per cui vale la pena che continuiamo a farlo, è che avviene una comunicazione in presenza. Ed è importante perché il pubblico, chi ascolta, non è indifferente a chi parla. Nel cinema, quando guardo qualunque cosa, oppure anche sui social, dappertutto, a chi sta agendo in quel momento io gli sono indifferente. Quello che mi dice diventa impersonale. Al contrario, nel teatro è personale e diretto. E proprio il Covid ha evidenziato questa caratteristica peculiare. Allora c’erano manifestazioni di insegnanti: pretendevano di tornare alla scuola in presenza. E prima della pandemia, quando si era veramente in presenza? Quando si era in grado di riconoscere questo gruppo di anime? Le creature che avevano di fronte gli insegnanti erano davvero in presenza? Lì si sarebbe potuto cominciare una riflessione seria. Io ci ho provato, però è cominciata ed è finita lì. Cioè siamo tornati esattamente come prima e abbiamo cercato di dimenticare. Voglio dire che il Covid – con tutto che è stata una tragedia e che sarebbe stato meglio non averlo vissuto – dal momento che lo abbiamo vissuto, ecco farne esperienza sarebbe stato saggio. Invece non siamo saggi…».
Come si può recitare a soggetto nell’epoca dei dispositivi spettacolari e della narrazione artificiale?
«Ma si recita solo a soggetto, nel senso che se recitare vuol dire essere in presenza e ascoltare mentre si parla, che è quello che avviene a teatro, è abbastanza d’obbligo. Con Lorenzo Tombesi stiamo preparando uno spettacolo e non riesco a convincerlo a imparare la parte a memoria, perché il rapporto con il pubblico quando vai memoria è un altro. Gli attori lo fanno da sempre, però adesso sta cambiando tutto: abbiamo bisogno di interagire. Cioè per secoli siamo stati ostaggio della forma, e il futuro dell’arte, della bellezza del teatro è nell’interazione. E quindi è un po’ d’obbligo recitare a soggetto, cioè dire quello che devi dire ascoltando chi ti ascolta, e questo lo può fare solo il teatro».
Da dicembre 2021 si sperimenta con PoEM, Potenziali Evocati Multimediali: un’esperienza non solo “classica” con i giovani?
«Sì. Con loro abbiamo fatto un lavoro scomparso nelle Scuole di teatro. Non riguarda la tecnica, perché hanno una preparazione perfettamente equiparabile a quella di qualunque altra scuola (e devo dire che è anche abbastanza tradizionale). Occorre che siano bravi attori: devono sapersi far sentire, far vedere, sapersi muovere, eccetera. Ma quello che mi importava molto è che dal corso uscisse un gruppo, persone che dopo non sarebbero diventati dei provinomani. Adesso è anche questo che ti insegnano: fai la scuola e quando esci devi pestare più piedi possibile e sgomitare più costole che puoi…
Ma non è così, perché esiste la possibilità di mettere insieme gruppi sulla solidarietà. Mio nonno era padovano e diceva Non ‘sta ndare a lavorar soto paròn. È quello che ho cercato di insegnare: mettetevi in proprio, abbiate fiducia in voi stessi. E gli attori di PoEM stanno costruendo questa realtà teatrale che viene apprezzata».