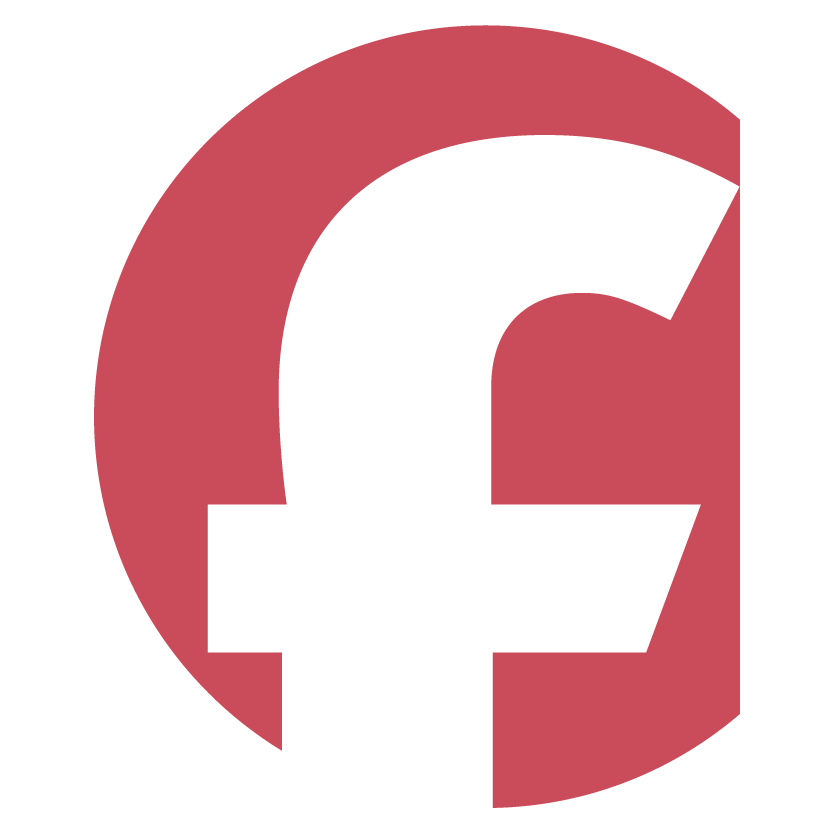 Fatti
Fatti
I 1.425 giorni di Sarajevo
L’assedio nel cuore dell’Europa: 1.425 giorni, il più lungo del Ventesimo secolo. Sarajevo rimane isolata dal 5 aprile 1992 fino al 29 febbraio 1996.
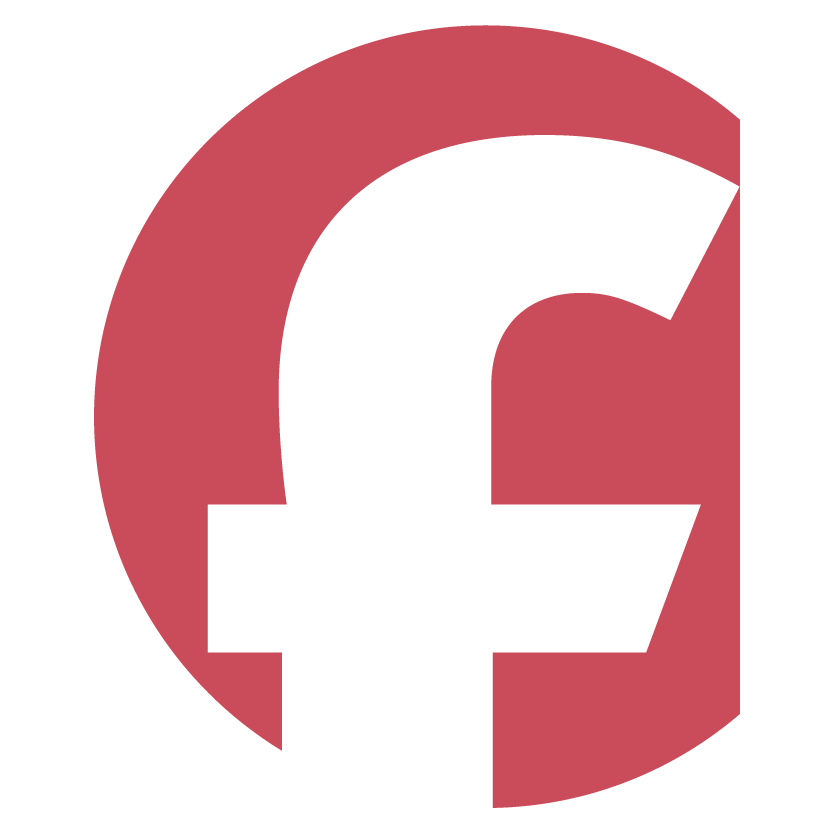 Fatti
FattiL’assedio nel cuore dell’Europa: 1.425 giorni, il più lungo del Ventesimo secolo. Sarajevo rimane isolata dal 5 aprile 1992 fino al 29 febbraio 1996.

Dalle colline i serbi tempestano la capitale della Bosnia ogni giorno con una media di oltre 300 esplosioni. Più di 11 mila le vittime e 50 mila i feriti, l’85 per cento sono civili. La popolazione è più che dimezzata: nel 1995 sono rimasti in 334.664. Prima, era la “Gerusalemme d’Europa”, luogo di convivenza pacifica fra i fedeli di quattro religioni (islamica, cristiana cattolica, cristiana ortodossa ed ebraica). Poi, Sarajevo diventa il simulacro della guerra civile, etnica, religiosa. Una capitale dei Balcani isolata dal resto del mondo, una città martirizzata, l’emblema dell’impotenza internazionale. Tutto comincia con le barricate dei militari serbi sul ponte di Vrbanja, mentre il corteo che invoca la pace si conclude con la morte di Suada Dilberović e Olga Sučić, una studentessa e una pacifista. Il giorno dopo la Comunità europea riconosce la Bosnia indipendente: comincia l’assedio. Simbolicamente, Sarajevo si traduce in immagini indelebili. I cadaveri di Admira Ismic, ragazza musulmana, e Bosko Brkic, il suo fidanzato serbo: colpiti dai cecchini restano a terra per giorni. I 700 metri di tunnel completato nel 1993, via di fuga e salvezza, e insieme il solo modo per rifornire, anche di armi, la città. Le fiamme nella Vijecnica, la biblioteca nazionale: nella notte del 25 agosto 1992 i cannoni serbi mandano in fumo un milione di volumi, 155 mila rari e 478 manoscritti unici. Si salva solo l’Haggadah, il più antico documento ebraico d’Europa. La strage nel mercato di Markale, il 5 febbraio 1994: intorno a mezzogiorno un proiettile di mortaio calibro 120 millimetri provoca 68 morti e 140 feriti. L’incubo di Sarajevo dura quasi quattro anni, finché la polizia bosniaca riprende il controllo di Ilijaš, municipalità del cantone di Sarajevo e crocevia di collegamento della capitale con il resto della Bosnia. Poi il 14 dicembre 1995 a Dayton in Ohio, negli Stati Uniti, si firma il trattato che mette fine ai conflitti nell’ormai ex Jugoslavia: con il presidente Usa Bill Clinton, il cancelliere tedesco Helmut Kohl e il primo ministro inglese John Major sono schierati il serbo Slobodan Milošević, il croato Franjo Tudman e il bosniaco Alija Izetbegović. Dieci anni fa, la commemorazione dell’assedio con 11.541 sedie rosse sulla via Maršala Tita. Il concerto in memoria delle vittime di un assedio senza precedenti: Sarajevo non dimentica i 1.500 bambini morti e per loro le sedie rosse sono appositamente più piccole. Oggi, forse, due immagini in bianco e nero del fotoreporter Mario Boccia incorniciano la storiaì dell’assedio infinito. La donna davanti al suo banco nel mercato nel 1992 che risponde “fioraia” alla domanda sull’identità anagrafica ed etnica. E “la ragazza che corre” il 30 settembre 1993 in una strada del centro mentre sibilano le bombe e i proiettili dei cecchini.

Creato il 25 maggio 1993 dall’Onu e situato all’Aia, nei Paesi Bassi, il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia ha giudicato i crimini di guerra in Bosnia. In 154 processi, le sentenze di condanna definitiva sono state 83, con 19 assoluzioni, mentre 37 imputati hanno visto le accuse ritirate o sono morti. Nel tribunale anche i giudici italiani Fausto Pocar e Flavia Lattanzi.
Un genocidio. La zona era affidata ai caschi blu olandesi dell’Onu. Ragazzi, uomini e anziani massacrati dall’esercito di Ratko Mladic e dai paramilitari Skorpion. Il giornalista e sceneggiatore croato Ivica Đikić ha ricostruito nel libro Metodo Srebrenica (traduzione di Silvio Ferrari, Bottega Errante edizioni) i tre giorni del luglio 1995con la pianificazione del colonnello Ljubiša Beara.
