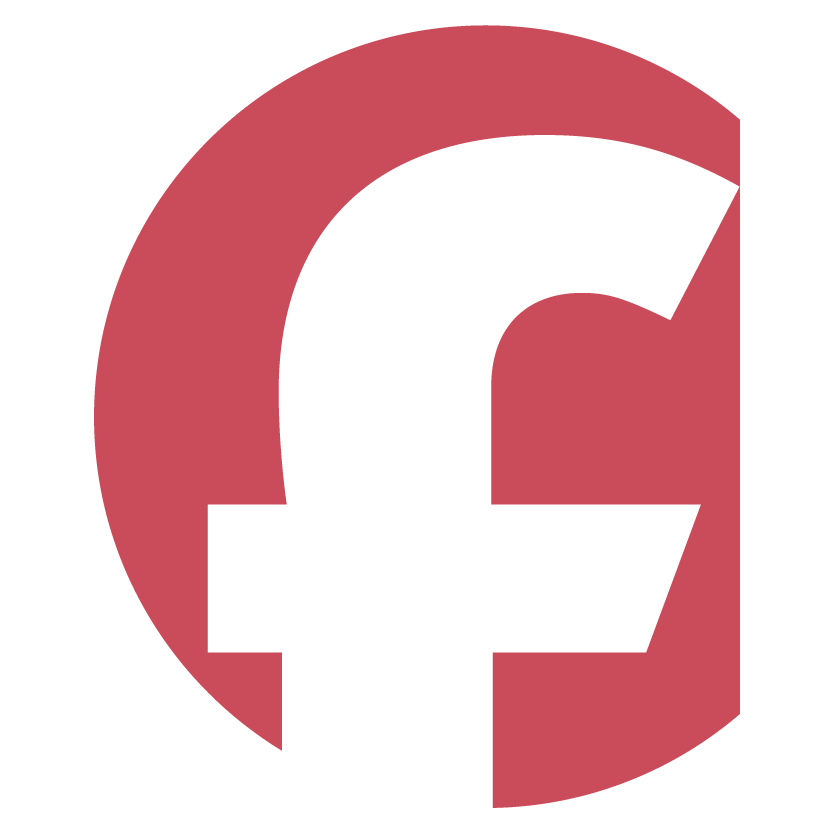Già la materia non è in sé particolarmente accessibile, ma il modo in cui ci si sta avvicinando al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati (chiamiamolo così per semplificare) sembra fatto apposta per confondere ancora di più le idee dei cittadini. Non è ancora del tutto certa neanche la data: il 27 gennaio il Tar del Lazio si pronuncerà sul ricorso presentato contro la decisione del governo di fissare la consultazione per il 22 e 23 marzo. E potrebbe non essere l’ultima parola. Ma chi ha presentato questo ricorso? In buona sostanza i sostenitori di un referendum quasi identico che in questi stessi giorni festeggiano il superamento del tetto di 500 mila firme richiesto dalla Costituzione. Obiettivo che di questi tempi non è da considerarsi per nulla scontato.
Per cercare di mettere ordine bisogna fare un passo indietro e tornare alle radici della questione. La Costituzione prevede due tipi di referendum: quello abrogativo di leggi ordinarie e quello che correntemente e impropriamente si è soliti definire “confermativo” di leggi costituzionali. Perché impropriamente? Perché tutto considerato – anche se in dottrina si discute – la sua natura appare prevalentemente oppositiva. Questo istituto è infatti lo strumento con cui 500 mila elettori oppure cinque consigli regionali oppure ancora un quinto dei membri di una Camera possono chiedere entro tre mesi che una legge costituzionale approvata dal Parlamento senza la maggioranza dei due terzi venga sottoposta a referendum popolare. Il senso di questa previsione è rafforzato dalla norma che non prescrive alcun quorum per la validità della consultazione. E’ proprio questo elemento che mette oggi in fibrillazione il mondo politico, perché raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti, complici i livelli elevati di astensionismo elettorale, è diventato ormai un ostacolo estremamente ostico, ai limiti dell’impossibile, come dimostra l’esperienza dei referendum abrogativi in cui tale quorum è invece previsto.
La natura oppositiva del referendum costituzionale si scontra ormai da molto tempo con l’iniziativa delle (varie) maggioranze parlamentari di promuovere direttamente la consultazione come mezzo di conferma – plebiscitaria, verrebbe da dire – delle riforme che queste stesse maggioranze hanno contribuito ad approvare in Parlamento. E’ accaduto così anche stavolta, mentre la logica di consentire tale iniziativa a un quinto dei membri di una Camera era in origine quella di valorizzare le minoranze critiche. Sta di fatto che le richieste dei parlamentari del Sì – i favorevoli alla riforma – sono state validate dalla Cassazione il 18 novembre. Il Consiglio dei ministri aveva sessanta giorni per prendere la decisione sulla data (vedi legge del 1970 sull’organizzazione dei referendum) e così ha provveduto a fare nella riunione del 12 gennaio scorso. Soltanto che nel frattempo i fautori del No avevano avviato una raccolta di firme che, come si diceva, ha rapidamente superato la soglia richiesta. Di qui la polemica e la contesa giuridica perché il governo ha sì rispettato i termini della legge del 1970, ma non la prassi che nei quattro casi precedenti aveva visto l’esecutivo attendere comunque il compiersi dei tre mesi stabiliti dalla Costituzione per poter attivare la procedura referendaria. Secondo questa interpretazione il governo non avrebbe dovuto decidere prima della fine di gennaio.
Che fretta c’era? ci si potrebbe domandare citando una nota canzone sanremese. Il governo accelera perché vuole tesaurizzare il netto vantaggio che i sondaggi attribuiscono al Sì e per portare a casa un risultato compatibile con la tabella di marcia delle altre riforme. I sostenitori del No (le opposizioni ma non tutte) ovviamente spingono in senso contrario e hanno buon gioco a chiedere qualche margine in più per consentire agli elettori di approfondire la materia. Sarebbe nell’interesse della stessa maggioranza che teme un voto tutto “politico” sull’esecutivo. L’importante è che i cittadini siano messi nelle condizioni di andare a votare e di votare con consapevolezza. La Repubblica è nata ottant’anni fa da un referendum e gli italiani, anche con i livelli d’istruzione di allora, sapevano bene quello che facevano.