 Idee
Idee
Intelligenza artificiale, grazie per la mano, ma teniamoci il sapere. Parla Luca Grion
Luca Grion: «Criticità per chi si avvia a una professione e utilizza le macchine»
 Idee
IdeeLuca Grion: «Criticità per chi si avvia a una professione e utilizza le macchine»
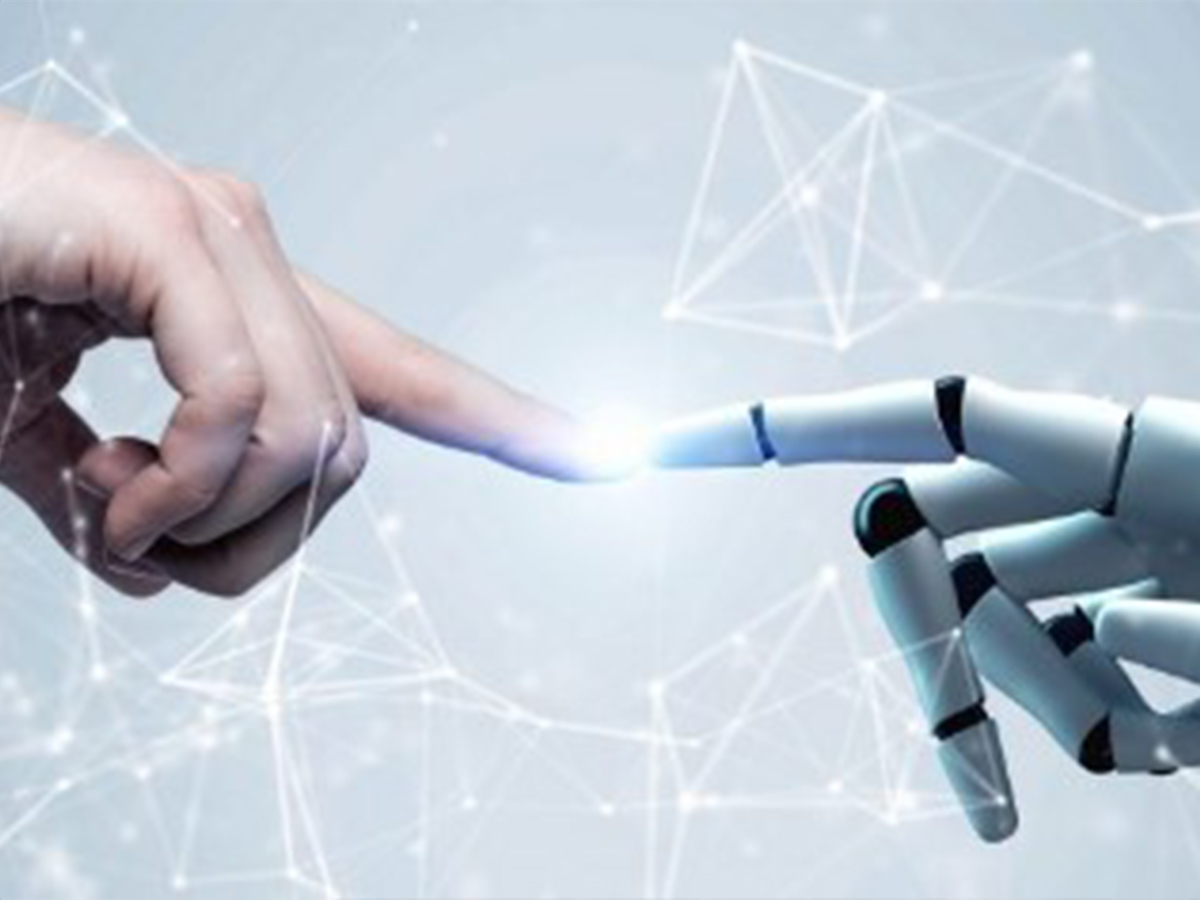
«Sono ottimista, se si hanno figli si è in qualche modo costretti a esserlo». Scherza Luca Grion, docente di Filosofia morale presso l’Università di Udine e ospite lo scorso 30 gennaio del Centro universitario di Padova nell’ambito del ciclo dei martedì culturali. Questo non toglie che l’intelligenza artificiale ponga interrogativi formidabili sull’uomo e sul suo futuro. Le macchine sapienti un giorno ci sostituiranno, oppure potremo affidare loro il nostro futuro in tutta tranquillità? «Non c’è un solo problema ma un grappolo, frammisti però a tanti frutti di bene: l’intelligenza artificiale ci sta già dando molto – ha continuato Grion – Oggi facciamo svolgere alle macchine compiti che un tempo erano ritenuti propri di soggetti intelligenti, in campi diversi ma essenziali che vanno dalla ricerca scientifica e medica alla sicurezza stradale. L’intelligenza artificiale promette inoltre di aumentare la produttività industriale e agricola, essenziali per sostenere una popolazione mondiale in crescita. L’apporto delle nuove tecnologie può essere infine determinante nella transizione ecologica, dando una mano a ridurre gli sprechi, e per superare le barriere linguistiche, per esempio con traduttori automatici sempre più efficaci». Del resto già da diversi anni le macchine intelligenti fanno parte della realtà in cui viviamo: vagliano curricula, concedono mutui e scelgono le notizie che leggiamo, più veloci ed efficienti di noi e talvolta addirittura più creative e brillanti. Si tratta però – come evidenzia Nello Cristianini, docente di informatica all’Università di Bath (Regno Unito), nel libro La scorciatoia (Il Mulino 2023) – di intelligenze a tutti gli effetti aliene, che invece di sviluppare un ragionamento logico basano le loro decisioni sull’analisi statistica di enormi moli di dati, per lo più forniti attraverso internet da miliardi di sensori disseminati nell’ambiente che ci circonda (a cominciare dal nostro smartphone). Una svolta tecnologica fondamentale dalla quale non si può rimanere esclusi, anche se i rischi non mancano, «come sempre quando l’umano e la tecnologia si mischiano: a partire dal deskilling, la perdita di abilità e competenze», continua il docente. È ovvio che come in ogni rivoluzione tecnologica qualcosa si guadagni, ma un po’ si perda anche: Socrate non aveva in grande simpatia la scrittura, perché a suo giudizio indeboliva la memoria e non rendeva la freschezza del dialogo. Il problema, secondo il filosofo è quando iniziamo a perdere competenze essenziali: «Chi è già esperto in un ambito o una materia con l’intelligenza artificiale prova l’ebbrezza del potenziamento; vedo semmai problemi per chi è all’inizio di un percorso e si avvia a una professione, per chi ha bisogno di stare in un ambiente per imparare come giovani e stagisti, che rischiano di essere completamente soppiantanti dall’intelligenza artificiale. Se poi ci si abitua fin dalla scuola ad affidarsi a ChatGpt per fare i compiti, allora ci si prepara a essere presto sostituiti dalle macchine». Al di là di questo, c’è poi un problema fondamentale: per quanto gli algoritmi si presentino come strumenti esclusivamente tecnici, essi in realtà nascondono scelte etiche e politiche che replicano i pregiudizi di chi li ha prodotti. Non solo: i sistemi informatici, tramite la continua opera di raccolta dati e di profilazione degli utenti, anche senza nessuna costrizione apparente sono sempre più capaci di indirizzare le nostre scelte. È la teoria del nudge (in italiano “pungolo”, “stimolo”): quella che Richard Thaler (Premio Nobel per l’economia 2017) e Cass Sunstein definiscono in un famoso libro “spinta gentile” (Feltrinelli 2014), come quando, per esempio, si mette una merce che si vuol vendere in determinate posizioni nei supermercati. Già oggi app e browser influenzano profondamente i nostri comportamenti, inducendoci a spendere e a passare sempre più tempo online (la cosiddetta “economia dell’attenzione”): con gli stessi sistemi però è già possibile anche influenzare l’opinione pubblica su scelte fondamentali del vivere comune. Le nuove tecnologie insomma sono troppo importanti per lasciarle al completo arbitrio di informatici e imprenditori della Silicon Valley. Per Grion «si dice a questo riguardo che servono abbondanti iniezioni di etica. Quale però? Basta sapere come funzionano i comitati etici oggi, nei quali spesso e volentieri ci si divide anche tra esperti, per capire quanto sia ardua questa richiesta. Eppure è problematico anche affidare alla più completa anarchia morale le regole che dovrebbero gestire la complessità di relazioni sociali». Ben vengano allora dibattiti come quelli sull’Ai Act europeo, con l’idea di una normativa che tenga conto dei diversi livelli di rischio delle singole attività, arrivando a limitarne fortemente alcune (come la cosiddetta face recognition). Altra cosa da fare è portare l’etica anche in azienda, spingere a considerare i valori in gioco – in particolare privacy e libertà della persona – già quando si progetta un prodotto. «La grande domanda però è soprattutto una – conclude il filosofo – chi mettere al centro, l’uomo o la macchina? Siamo noi a doverci adeguare alle macchine, cercando di diventare ogni giorno più efficaci e performanti, oppure spetta a queste aiutare l’essere umano a vivere meglio, a fiorire, come diceva Aristotele? Il destino non è già segnato: sono sfide enormi che richiedono riflessioni e scelte da parte nostra».
