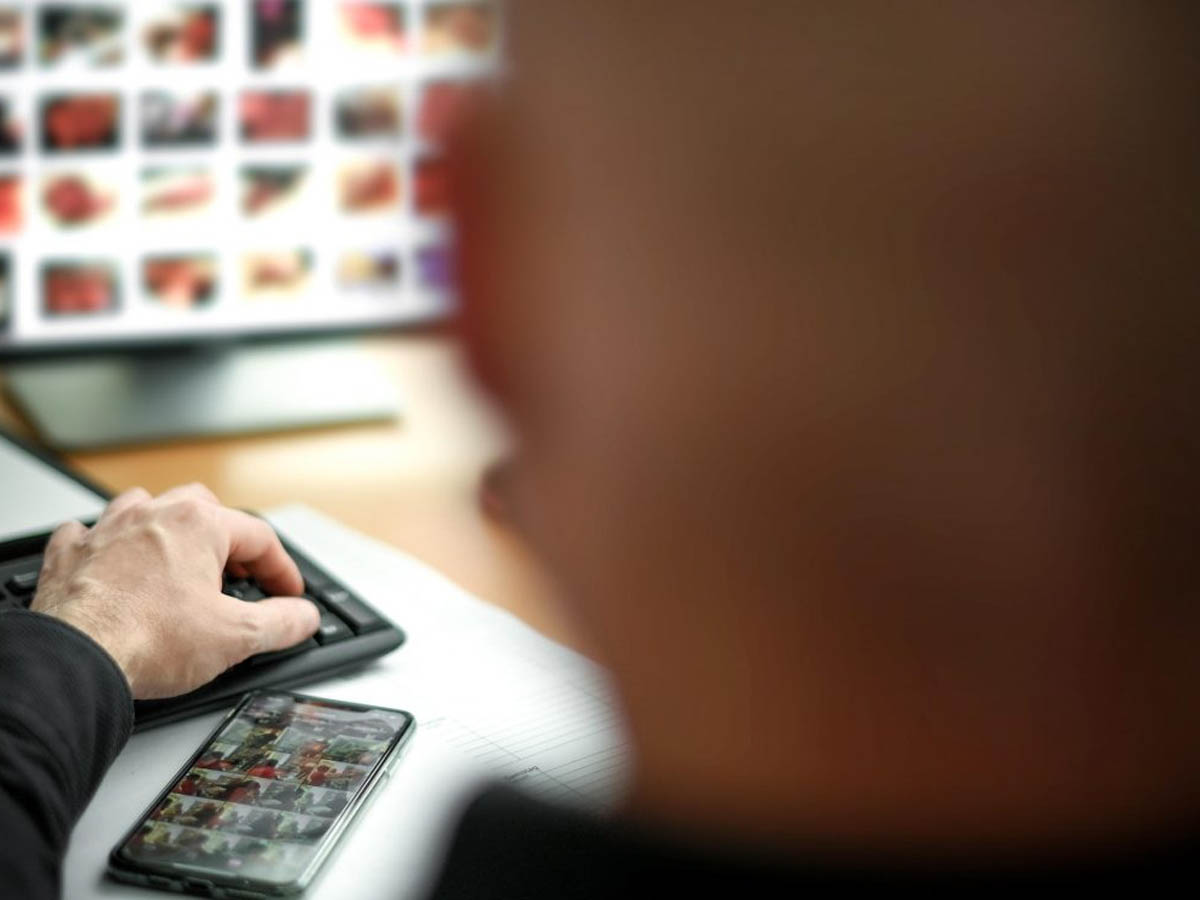
Cosa sarà mai passato per la testa a quei 33 mila individui – uomini qualunque, padri di famiglia, stimati professionisti etc… – ad entrare con il loro account – nome, cognome, faccia – nel gruppo pubblico di Facebook “Mia moglie”? Non solo hanno preso parte – a volte in prima persona – alla violazione della dignità di tante donne spesso ignare, ma ci hanno pure messo apertamente la faccia, in modo che tutti – quando lo scandalo è scoppiato – hanno avuto modo di vedere nomi, cognomi, foto e commenti abusanti. Allo stesso modo, che cosa mai passerà per la testa di quelle signore che su Facebook alternano immagini di preghiere a laconici commenti in stile “uno di meno” alla notizia della morte di un immigrato in un incidente stradale.
Nulla da dire sul florilegio di analisi di stampo etico su patriarcato, individualismo, razzismo che affollano i giornali in questa fine estate, ma forse sottovalutiamo quanto – per dirla alla McLuhan – sia lo strumento tecnico, il media, non solo a definire il messaggio, ma a plasmare il messaggero a sua immagine, travolgendone persino i valori e la visione del mondo.
Superbloom. Le tecnologie di connessione ci separano? edito in Italia da Raffaello Cortina, è l’ultima fatica di Nicholas Carr, già autore di Internet ci rende stupidi?. Carr mostra come l’entusiasmo iniziale per la “connessione totale” si sia trasformato in un paradosso: «condividiamo più informazioni che mai, ma più comunichiamo, peggio le cose sembrano andare». Non è soltanto che i social moltiplicano messaggi, immagini e opinioni: è che, nel farlo, modellano le persone che li usano, spingendole verso l’emulazione, la polarizzazione e il conformismo del branco. È un ecosistema fragile e travolgente, troppo veloce per la nostra mente, nel quale il desiderio di visibilità o di appartenenza prevale sul senso del limite. E siamo ancora lontani da trovare un punto di equilibrio.




