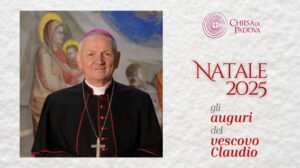Le migrazioni internazionali occupano un posto di sempre maggior rilievo nello scenario mondiale. Si tratta di movimenti consistenti: duecento milioni di persone – il tre per cento della popolazione mondiale – che vivono al di fuori dallo Stato in cui sono nate. Sono flussi che continuano verso la tradizionale direttrice Sud-Nord, in aggiunta a una forte componente che va da Sud a Sud, all’interno dei cosiddetti Paesi in via di sviluppo. La loro visibilità viene proiettata in maniera spesso drammatica sugli schermi del mondo. I mezzi di comunicazione indugiano a lungo nel darne uno “spettacolo” tragico, con una cronaca che potrebbe scuotere le coscienze, ma per la quale si rischia l’assuefazione. Le immagini televisive o le foto-notizie mostrano quasi sempre il lato problematico e drammatico delle migrazioni, e rispondono alla legge di mercato, che la stampa americana già di fine Ottocento aveva sintetizzato con “bad news is good news”, “le cattive notizie sono buone notizie”. Nel senso che un fatto con conseguenze negative
interessa l’opinione pubblica più di uno con conseguenze positive. Ma se è necessario essere informati sul fatto che da gennaio a oggi ci sono stati 456 migranti morti e 420 dispersi nel mare Mediterraneo, durante le traversate verso l’Europa, è altrettanto necessario dare uno sguardo positivo sulle migrazioni.
La positività delle migrazioni
La più recente occasione per guardare alle migrazioni da una prospettiva positiva viene dal messaggio di papa Leone XIV, scritto in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato (che in Diocesi di Padova si celebra questa domenica, ndr). Una positività espressa fin dal titolo “Migranti, missionari di speranza”. Potrebbe sembrare un adattamento forzoso al Giubileo della speranza 2025, mentre è una visione supportata da valide ragioni. La prima delle quali è data da «una chiara analogia con l’esperienza del popolo di Israele errante nel deserto, il quale affronta ogni pericolo fiducioso nella protezione del Signore». La seconda è che «i migranti e i rifugiati ricordano alla Chiesa la sua dimensione pellegrina»,
qui in riferimento alla civitas peregrina di sant’Agostino, ma con origine in san Paolo, in cui i cristiani sono detti pároikoi (parrocchiani), cioè pellegrini che non hanno qui una stabile dimora. Inoltre, «migranti e rifugiati possono diventare oggi missionari di speranza nei Paesi che li accolgono, portando avanti percorsi di fede nuovi (…)» e «con il loro entusiasmo spirituale possono contribuire a rivitalizzare comunità ecclesiali irrigidite e appesantite, in cui avanza minacciosamente il deserto spirituale. La loro presenza va allora riconosciuta ed apprezzata come una vera benedizione divina». Di quest’ultima espressione sembrano farne uso anche demografi ed economisti, che da sponda laica sempre di
benedizione parlano. Perché già da lungo tempo queste due categorie di professionisti superano in considerazioni positive i più positivi osservatori dei fatti migratori: i demografi sottolineando il contributo di nascite e l’immissione di persone giovani in società occidentali ormai asfittiche; gli economisti, per l’analogo motivo, con specifico riferimento alla forza lavoro immigrata che interviene a riempire gli spazi lasciati vuoti, e in più garantendo anche il sostentamento alle pensioni.
La sfida dell’integrazione
Il passaggio decisivo e positivo sarà quello dell’integrazione. Pochi ne parlano, ma è strategico per la costruzione consapevole di società che al loro interno fanno spazio a persone provenienti da altri contesti linguistici e culturali. Il processo di integrazione appare nella sua correttezza di interpretazione quando lo si rende con il termine “inter-azione”. Indica anzitutto un’azione che si fa assieme, un impegno che non è richiesto solo agli immigrati. Inoltre, i contenuti di questa azione riguardano il riconoscimento di reciproci diritti e obblighi sia per coloro che provengono da altri contesti etnico-culturali, sia per la società che accoglie. Cosicché questa garantisce un corredo di diritti a favore dei migranti, uno status giuridico tale da consentire agli stessi di partecipare alla vita economica, sociale, culturale e civile; e i migranti sono chiamati a rispettare le norme e i valori fondamentali della società che li ospita. È la fisionomia della società dell’avvenire, che già adesso si sta costruendo con le migliori forze umane e cristiane.