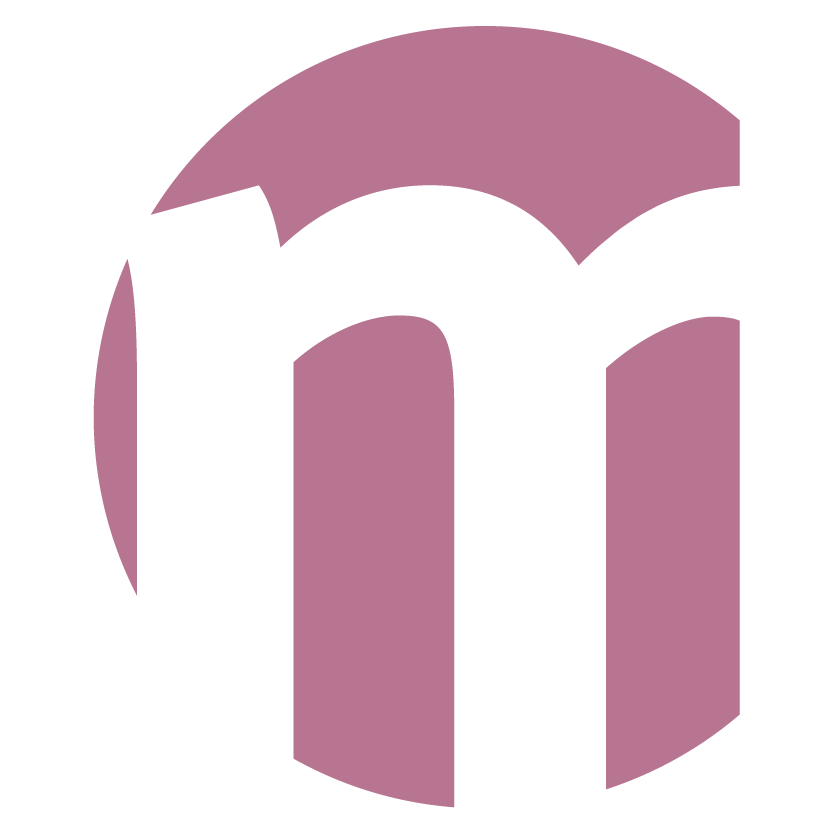Il 25 agosto “Born to run” compie ben cinquant’anni, e non li dimostra. Sembra ieri quando, aspettavamo l’apertura del negozio per portarci via il disco di Bruce Springsteen, dalla iconica copertina che mostrava, accanto al sassofonista Clarence Clemons, The Boss di profilo con la sua fedele, classica e mitica Fender telecaster.
Quell’album, restato nell’immaginario collettivo anche grazie a quella foto di Eric Meola, fu il primo grande successo planetario di The Boss che era, d’altra parte, già idolo di quanti avevano intuito la carica rivoluzionaria, eppure legata al passato rocker e Presley, blues del Delta e sguardo nostalgico, delle precedenti canzoni di Bruce. E fu il successo, anche quello, chissà quanto temuto, eppure vagheggiato, commerciale.
La canzone che dava il titolo all’album era la continuazione di una beat generation unita al mito delle bande dei rockers che sfrecciavano a velocità proibite nelle strade Usa e inglesi, e altrove.
Era un invito a muoversi, a non lasciarsi catturare dal mito della casa comoda, della buona cucina e della bella moglie, oltre che del televisore pronto a un metro dal divano ultimo tipo: perché questa città, urlava The Boss tra assoli elettrici e sassofoni sparati nelle orecchie grazie ad una amplificazione stratosferica, “è una trappola mortale, un invito al suicidio”.
E come scriveva Thomas Hardy, l’invito era perentorio: via dalla pazza folla, dal conformismo consumista, il che vuol dire che alcune canzoni non tramontano mai, anzi, come nel caso di “The sound of silence” di Simon and Garfunkel, uscita dieci anni prima, divengono poesie scritte sui muri delle metropolitane e agli ingressi dei caseggiati.
Anche se “Backstreet”, “Tunder road”, “Meeting across the river”, dove si parla dello spaccio della droga per avere un futuro, e le altre songs del disco ne fanno un unicum, ma anche il primo di una serie che porterà The Boss nell’olimpo mediatico e oggi anche politico, viste le sue parole contro Trump.
Ma il ’75 è anche l’anno di un disco che sembrerebbe non avere molto in comune con “Born to run”: “Rimmel” di Francesco De Gregori. E in effetti all’elettricità dura del disco di Bruce il cantautore romano opponeva la melodia, l’acustica, un silente garbo che non nascondeva però lo sguardo sui propri tempi, come The Boss: ed infatti in “Signor Hood” De Gregori parlava di un Marco Pannella solitario arciere che si batteva contro i signori della politica, il Pci e la Democrazia Cristiana con le sue battaglie e i suoi scioperi della fame.
Certamente facevano capolino la musica country, la canzone di protesta, ma anche l’intimismo della ballata, e questo accade a tutti, da Leo Ferrè a Springsteen, per rimanere in tema, come nel caso, tanto mal digerito dai contestatori che l’anno dopo gli inscenarono il processo proletario al Palalido di Milano, della ballad “Buonanotte Fiorellino”.
Canzoni d’amore e di abbandono, come accade in quella che dà il titolo all’album, storia di un addio da parte della ragazza amata, ma anche di attuale e dolorosa storia, con la maiuscola, perché collettiva: ricordava i luoghi comuni della citazione delle cose positive del fascismo, ad esempio, e la sua capacità di catturare l’immaginario collettivo con la trasformazione del suo linguaggio.
Insomma un lp, come si diceva allora, molto più dentro le cose del mondo di quanto sostenessero i suoi contestatori, impegnati in una paradossale ortodossia non ortodossa, che metteva insieme in modo non banale, amore, politica, canzone popolare (“Piccola mela”) diventando in poco tempo il logo dell’autore romano, una parte, un disco, al posto del tutto, il cantautore.


Che splendidi cinquantenni, anche se dischi.