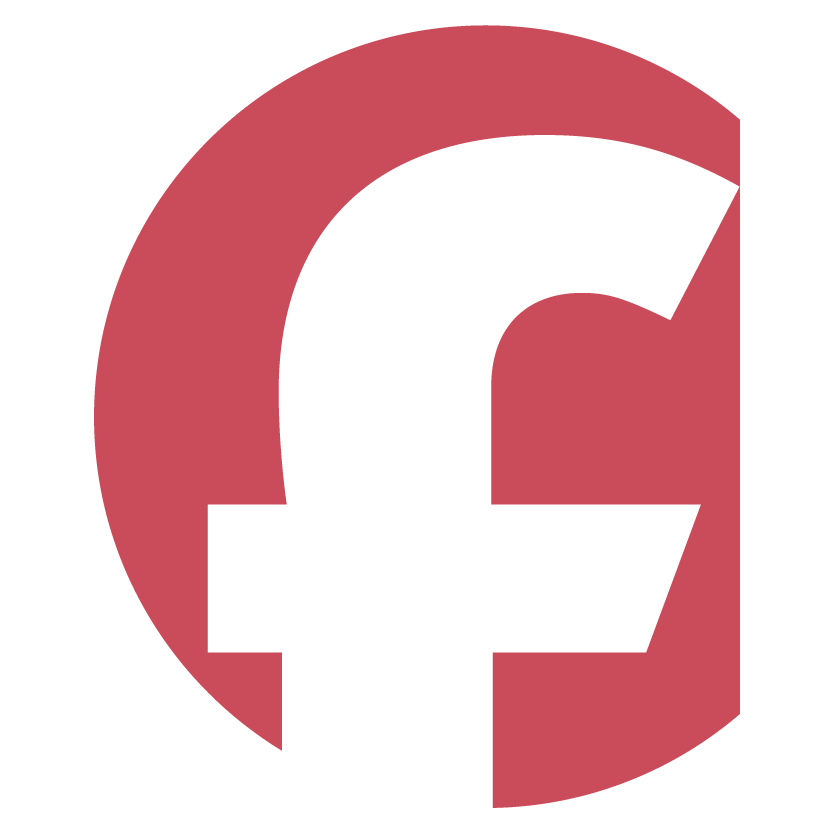Ancora una volta i 27 leader dell’Unione europea si sono dati appuntamento a Bruxelles, il 23 ottobre, con un ordine del giorno ambizioso: vi figurano Ucraina, Medio Oriente, Difesa e sicurezza europee, Competitività e duplice transizione, Alloggi, Migrazione. E per questa ennesima tappa si sono subito profilati dubbi, intralci, convitati di pietra, assieme a una infinita serie di freni interni e di incertezze internazionali.
Nella lunga lettera di invito ai capi di Stato e di governo, il presidente del Consiglio europeo, il portoghese Antonio Costa, promettendo di chiudere il summit in un solo giorno, ha fra l’altro scritto: “La Russia continua i suoi incessanti attacchi contro i civili e le infrastrutture civili dell’Ucraina. Discuteremo su come intensificare il nostro sostegno all’Ucraina, in particolare riconfermando il nostro impegno a fornire aiuto finanziario al Paese per i prossimi anni. […] Sia il sostegno all’Ucraina che la pressione sulla Russia rimangono i due requisiti necessari per raggiungere una pace giusta e duratura”.
Ma l’Europa, che sta pagando un prezzo elevato per il conflitto in Ucraina, compresa un’ingente spesa per gli armamenti, viene spiazzata dalle mosse di Trump, che si confronta direttamente con Putin per porre fine alla guerra.
Un dialogo che esclude l’Ue, tra due personaggi poco credibili in quanto a mantenere la parola data.
Un dialogo che tende ad accreditare all’autocrate russo – inseguito da un mandato di cattura della Corte penale internazionale – un ruolo che non gli spetterebbe. Addirittura Trump, dopo il fallimento dell’incontro con lo zar in Groenlandia, ha annunciato un nuovo rendez-vous a Budapest. Dove Putin non potrebbe mettere piede; e, per di più, nella capitale di un premier anti-Ue e filorusso. Dunque, un pasticcio assoluto, alle spalle del popolo ucraino che, da ormai tre anni, subisce un’invasione sanguinosa e distruttrice della quale si fatica a vedere un reale epilogo.
I ventisette leader dovrebbero poi discutere di Medio Oriente, con in primo piano l’accordo Israele-Hamas, sbandierato come risolutivo del conflitto eppure carico di incognite. Un accordo, è bene ricordarlo, nel quale l’Ue non ha avuto alcun vero ruolo politico.
Sugli altri temi emergono ulteriori interrogativi. Ad esempio, quanto costerà agli europei la “prontezza” difensiva dichiarata e ora tutta da realizzare? “Gli attacchi ibridi e gli avvistamenti di droni in prossimità delle nostre infrastrutture critiche, nonché le incursioni ostili nello spazio aereo degli Stati membri, sono – ha scritto ancora Costa – un’ulteriore dimostrazione dell’urgenza di accelerare i lavori per raggiungere la prontezza alla difesa comune europea entro il 2030” (entro il 2030, sic!). Ma la “regia” della difesa a chi sarà affidata, sapendo che si tratta di una politica nazionale, non contemplata nelle competenze dell’Ue, e che manca di una politica estera e di difesa comune?
I vertici dai leader europei hanno talvolta trovato, in passato, soluzione inedite, persino insperate, a grandi problemi cogenti.
Di fronte alle sfide della storia ci sono stati Consigli europei coraggiosi, persino risolutivi. Va detto, però, che sedevano attorno a quel tavolo altri capi di Stato e di governo, e forse il clima internazionale erano meno incandescente. Da tempo la “macchina Ue” gira a vuoto: chissà se questa volta i nostri responsabili di governo – con un surplus di responsabilità e di convergenze politiche – sapranno stupirci.