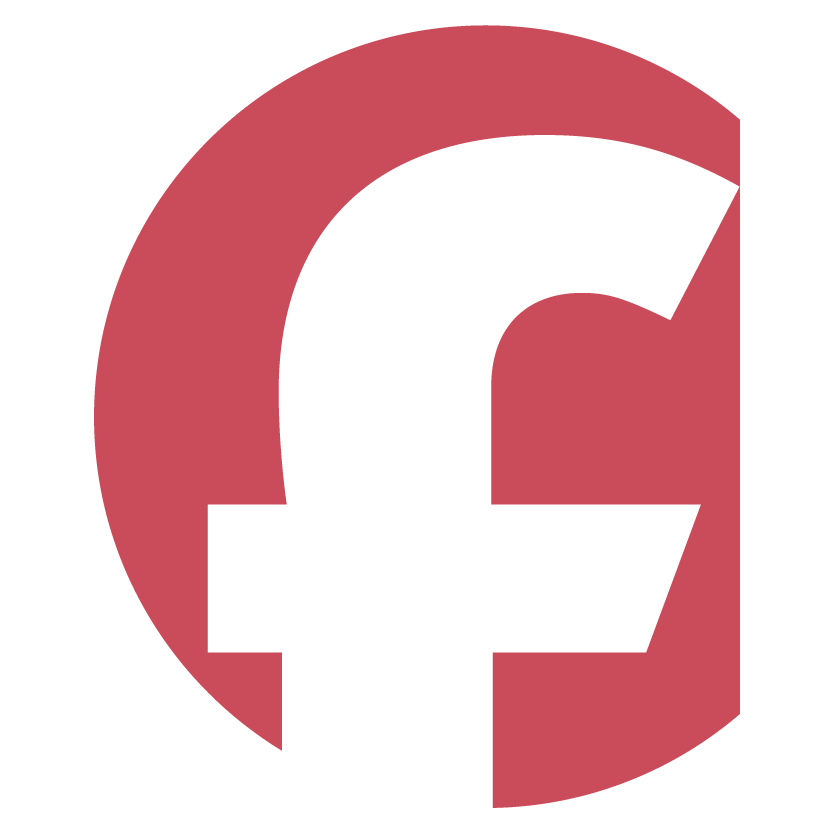 Fatti
Fatti
Occhio, gli alieni sono tra di noi: ecco le specie esotiche
Piante e animali giunti per caso tramite viaggi intercontinentali o a causa di esperimenti dell’uomo, sono diventati invasivi e non di rado procurano danni anche all’uomo
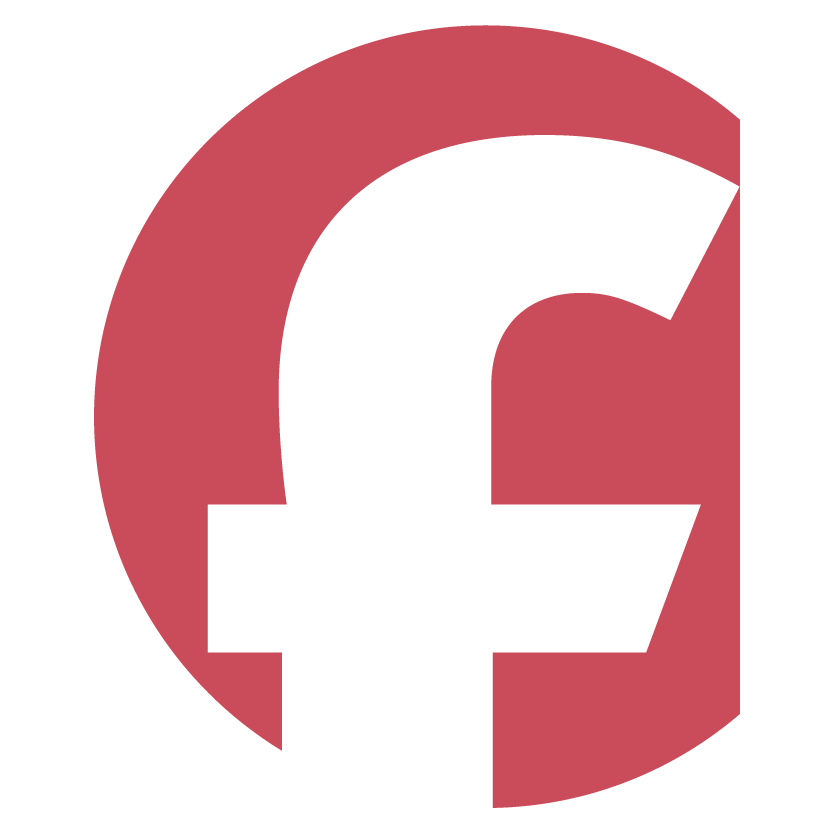 Fatti
FattiPiante e animali giunti per caso tramite viaggi intercontinentali o a causa di esperimenti dell’uomo, sono diventati invasivi e non di rado procurano danni anche all’uomo

Gli alieni sono tra noi? In qualche modo sì, perché tali si potrebbero considerare quelle specie animali e vegetali che nulla avevano a che fare con il nostro territorio e invece sono giunte, si sono insediate e… ci si trovano proprio bene. Solo che, più di qualche volta, hanno contribuito ad alterare gli equilibri e magari hanno fatto anche gravi danni all’ecosistema. E non di rado pure all’economia degli esseri umani. Ultimo tra tutti, ma non è il solo, il famigerato granchio blu. Di specie aliene e dei rischi che comportano si è parlato a inizio marzo in un incontro organizzato congiuntamente dalle associazioni regionali giornalisti agroalimentari e ambientali di Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, tre Regioni molto colpite da queste “invasioni”. È stato ricordato che nel 2014 un Regolamento europeo stabilì l’obbligo per gli Stati membri di eradicare gli esemplari di alcune specie esotiche invasive, ma ha avuto poco successo anche da chi ha adottato la normativa: e l’Italia è tra gli Stati deferiti per la mancata attuazione delle disposizioni. «Le volpi sono state la causa della completa sparizione dei caprioli del Carso», ha raccontato per esempio Marco Buzziolo, vicepresidente dell’Arga friulana. Altrettanto sorprendente è stato sapere che esiste una colonia di lupi nel delta del Po, in zona Porto Tolle, e vederne filmato uno che cattura una nutria. Queste ultime, note come castori di pianura e importate per la loro pelliccia dal Sudamerica e poi fuggite da qualche allevamento, sono forse il problema principale nelle pianure perché mettono a repentaglio gli argini e la sicurezza del territorio urbanizzato e delle coltivazioni. Il Consorzio di bonifica del Po sta portando avanti un progetto sperimentale per farvi fronte, che prevede anche un’apposita app per le segnalazioni e gli avvistamenti: per ora l’unica soluzione, che non ha tuttavia dato i frutti sperati, è stato l’abbattimento affidato ai “selettori”, cacciatori volontari. Nei territori lagunari e costieri i flagelli sono però anche altri: il già citato granchio blu, per il quale il Governo ha avviato un progetto di contenimento. C’è poi il temibile gambero della Louisiana, molto aggressivo, che però in questi ultimi anni sembra in regressione ma ha contribuito a impoverire la fauna dei nostri fiumi. Lo stesso ha fatto il vorace pesce siluro, che può raggiungere dimensioni enormi e fare un solo boccone di una placida anatra. Specie non autoctone sono anche la trota iridea e il persico sole; più danni ancora hanno però fatto le tartarughe acquatiche. Venendo alle zone boschive di pianura, sembra ormai una battaglia persa quella contro gli scoiattoli grigi americani, più grandi e aggressivi di quelli rossi e bruni autoctoni, che vengono regolarmente sopraffatti e stanno sparendo. Ed è proprio dall’America che, probabilmente, nasce la storia delle “invasioni” moderne. «Nel 1845 un microrganismo, la peronospora – spiega Buzziolo – comparve in Irlanda e devastò le coltivazioni di patate. Fu una delle principali cause della grande migrazione irlandese verso gli Stati Uniti. E pensiamo alla fillossera, un insettino che modificò totalmente la viticoltura moderna a fine Ottocento. L’intensificarsi dei viaggi transoceanici e l’accorciarsi delle loro durate oggi facilita molto la sopravvivenza di questi esseri durante lo spostamento: possiamo citare la vespa del castagno che ha distrutto molti castagneti, la xilella terrore degli olivicoltori, la diabrotica del mais o la cimice asiatica». A volte la causa di tutto furono le sperimentazioni umane. L’esempio più emblematico è l’Australia: i conigli, in mancanza di predatori, diventarono un flagello tanto che fu eretta una barriera lunga migliaia di chilometri per tenerli fuori dalle zone pastorali occidentali. I gatti devastarono la microfauna, come le volpi. E nel deserto australe viaggiano branchi di cammelli liberati dopo la costruzione della ferrovia. «Uno dei problemi – aggiunge Buzziolo – è che alcuni di questi animali sono “simpatici”, pensare di sterminarli viene emotivamente difficile. E porterebbe a opposizioni e polemiche, che i politici poca voglia hanno di affrontare. Per cui si fa poco o nulla». Di che animali stiamo parlando? Per esempio dell’ibis sacro, fuggito da uno zoo privato nel Torinese negli anni Ottanta, specie altamente invasiva. Oppure dei procioni americani oggi diffusissimi nelle valli bergamasche, o il già citato scoiattolo. E le piante? «Sono molteplici. Una tra tutte – continua Buzziolo – è l’ailanto, altamente invasiva. Meno diffusa ma pericolosissima per l’uomo è la Panace di Mantegazza: il contatto con la sua linfa può portare a dolorosissime vesciche, eruzioni cutanee e ustioni».
Non solo esseri animali o vegetali: anche i prodotti alimentari trasformati possono essere “invasivi”. È il caso dell’olio di oliva, di cui nel 2024 sono arrivati in Italia almeno 65 milioni di litri extra Ue, una vera e propria “invasione” che alimenta il rischio di frodi e inganni ai danni dei cittadini e fa crollare i prezzi del vero extravergine italiano. A denunciarlo è Coldiretti, che ha effettuato un recente blitz al porto di Civitavecchia in occasione dell’arrivo di una nave carica di prodotto estero. «Si è voluto lanciare un grido di allarme contro la concorrenza sleale – spiega Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova – considerata l’alta qualità del prodotto made in Italy e il fatto che quello straniero finisce spesso per essere venduto come tricolore, sfruttando il prezzo più basso. L’olio tunisino, è venduto oggi sotto i 5 euro al litro, con una pressione al ribasso sulle quotazioni di quello italiano che costringe gli olivicoltori nazionali a svendere il proprio al di sotto dei costi di produzione». Le conseguenze si fanno sentire per i produttori di olio extravergine di oliva di qualità e provenienza certa come quello dei colli Euganei, dove gli olivicoltori sono circa 650 e su oltre 450 ettari di terreno coltivano più di centomila piante di ulivo. La produzione media per la per la nostra provincia è di circa 20.500 quintali di olive, nel 2024 la produzione è stata abbondante e di ottima qualità anche se le rese, tra il 10 e l’11 per cento, sono state le più basse degli ultimi anni. Da un quintale di olive si sono ottenuti infatti 10-11 litri di olio extravergine. Il clima, spiega Coldiretti Padova, è il primo fattore che incide sulla produzione dell’olio d’oliva, soprattutto in questo periodo segnato da cambiamenti climatici ed eventi meteo estremi. L’altro fattore è quello sanitario, legato alle malattie, funghi e parassiti che possono colpire gli ulivi. In entrambi i casi è fondamentale l’apporto dell’olivicoltore, in grado di intervenire con tecniche che permettono di preservare la qualità delle olive e garantire una buona resa anche nelle annate più complicate. Coldiretti ricorda che l’obiettivo di chi acquista olio straniero è realizzare margini sempre più alti di profitto tramite speculazioni che mettono all’angolo i produttori nazionali a scapito della qualità. Un fenomeno che spinge ulteriormente il pericolo di frodi, contro le quali si sono peraltro intensificati i controlli delle forze dell’ordine, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. «Per questo – conclude Lorin – vogliamo mettere in guardia i consumatori: controllare sempre le indicazioni di origine sull’etichetta. Chiediamo poi una rigorosa tracciabilità».
Il Regolamento Ue 1.143 del 2014 è stato in gran parte inattuato; 18 Stati sono stati richiamati e l’Italia è tra i sei deferiti nel 2023 alla Corte di giustizia per inadempienza.
