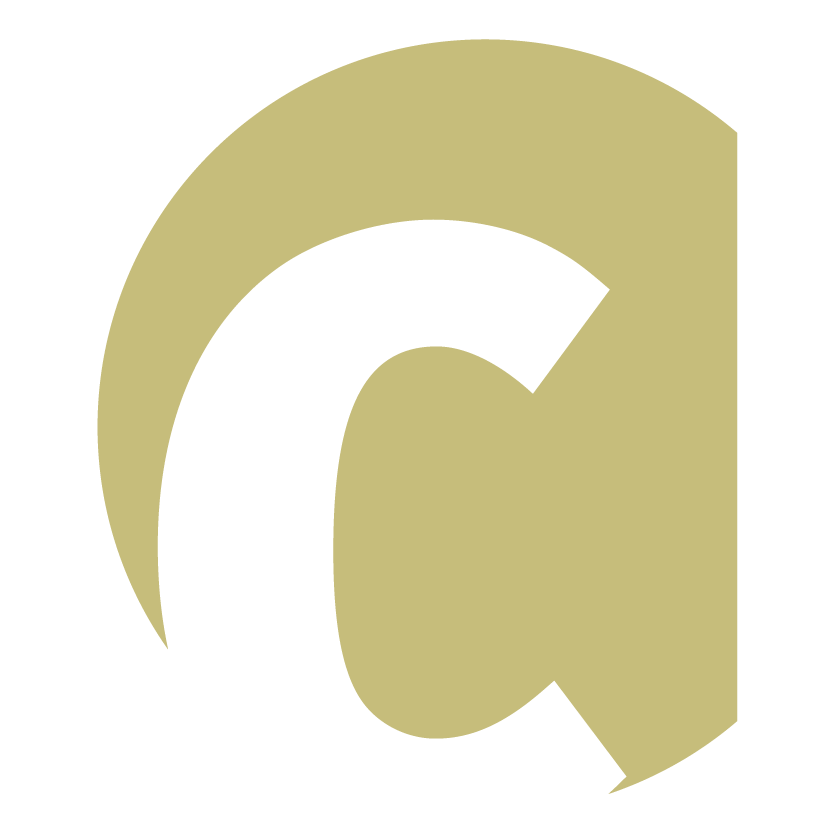Stiamo ancora vivendo il doloroso lutto per la prematura scomparsa di don Andrea Albertin, prete, biblista appassionato e, per molti, un vero amico. A pochi giorni da questa perdita così terribile per tutta la nostra Diocesi di Padova, è giunta anche la drammatica notizia di don Matteo Balzano, giovane sacerdote della Diocesi di Novara, che si è tolto la vita. Questi due eventi mi hanno colpito: il primo per la ferita che mi ha lasciato dentro, il secondo per il mistero di un male oscuro che abita le nostre profondità e che può soffocarci. In entrambi i casi la domanda resta la stessa: perché? È lo stesso “perché” che accompagna la morte degli innocenti, dei bambini, di tutte le donne e gli uomini che ci lasciano troppo presto. La morte di don Andrea ci ha lasciati attoniti, perché la sua preparazione e la sua capacità di comunicare lo rendevano una presenza importante per molti: basta leggere qualche suo testo per rendersene conto. Qualcuno, troppo in fretta, ha cercato di difendersi dal dolore aggrappandosi alla volontà di Dio, un tentativo di dare senso a ciò che sembra non averne. Ma come può essere volontà di Dio strappare così prematuramente un uomo all’apice della propria maturità umana e intellettuale, dotato di capacità innate e altre acquisite dopo anni e anni di studio? Con troppa velocità e ingenuità spesso si tende a spiritualizzare ogni evento: «È volontà di Dio! Il Signore lo ha chiamato perché aveva bisogno di lui in cielo; lo ha portato via per fargli contemplare la sua bellezza». Tutte espressioni che consolano e aiutano ad andare avanti, ma forse non ci aprono alla speranza di cui avremo bisogno in queste tristi occasioni. Nel caso di don Matteo, invece, non abbiamo nemmeno il coraggio di spiritualizzare un dramma simile. Chi osa dire che fosse volontà di Dio o che lo abbia chiamato a vita migliore? Rimangono solo il silenzio e interrogativi che non trovano risposta: le vere domande, dopotutto, non hanno risposta. Eppure, se vogliamo essere “pellegrini di speranza”, come ci invita a essere il Giubileo che stiamo vivendo, non possiamo evitare di interrogarci su questi fatti. Dobbiamo guardare la realtà così com’è, senza spiritualizzarla. La speranza nasce infatti nel riconoscere di essere dentro a un dramma: la morte di due giovani preti è un dramma. Solo quando prendiamo coscienza del buio sentiamo la necessità di accendere una luce; se non riconosciamo la nostra angoscia, non possiamo fare esperienza della speranza. Ed è proprio qui che speranza e ottimismo divergono: la speranza scaturisce quando ci troviamo sull’orlo del burrone, senza alternative. L’ottimismo, invece, ignora la negatività, non conosce né dubbio né angoscia, naviga nella bonaccia della positività, con le vele gonfie di indifferenza e nessun contatto con la realtà: «Va tutto bene! È volontà di Dio! Non aver paura, tutto si risolverà». Nel caso di don Andrea e don Matteo non si è risolto un bel niente! L’uomo (o la donna) di speranza, invece, conosce bene la disperazione, le bufere della vita; per questo la sua voce grida nel mezzo della burrasca per svegliare Gesù: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?» (Mc 4,38). Solo la speranza ci libera dalla prigione di un tempo chiuso che sembra precludere ogni nuovo percorso. La resurrezione di Gesù è un cammino nuovo che illumina ogni angoscia, ma se non entriamo con onestà nel dramma di certi passaggi della nostra vita, rimaniamo dei semplici ottimisti. Ho l’impressione che spesso le nostre riflessioni, anche davanti a grandi dolori, si fondino su un ingenuo ottimismo anziché sulla speranza che scaturisce dal Cristo. Siamo più legati alle nostre idee sulla realtà che ci siamo costruiti negli anni anziché alla vera realtà: idee che danno un po’ di consolazione e sicurezza, ma non ci salvano. Il Giubileo della speranza, a partire dalla bolla di indizione Spes non confundit, non vuole illuderci. La speranza che il papa ci propone per questo Giubileo non è un’idea ingenua secondo cui tutto si risolverà presto. «La speranza non delude», dice Paolo nella Lettera ai Romani (5,5), non perché noi siamo bravi o abbiamo capito tutto dalla vita, ma «perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è dato». È lo Spirito che illumina il nostro cammino. Non avere speranza, disperare, non significa semplicemente essere pessimisti, ma convincersi che le nostre aspettative non troveranno alcun riscontro né nel presente né nel futuro. Disperare significa rinunciare alla fede, alla gioia, a un sorriso, all’amicizia e a sognare. Infatti, noi abbiamo smesso di sognare. Eppure, la speranza si nutre di sogni; di uomini e donne che sanno ancora sognare a occhi aperti. I sognatori immaginano le azioni da compiere, anticipano nella mente e nel cuore ciò che poi cercano di realizzare. Un sogno stimola fantasia e inventiva, risveglia l’immaginazione, progetta percorsi nuovi per uscire dalle secche del «si è sempre fatto così». Spinge a uscire dal vecchio per entrare nel nuovo. Don Andrea sapeva sognare e aveva sempre nuovi progetti. Don Matteo forse aveva smesso di sognare. I veri miracoli, prima ancora di cambiare la realtà, si realizzano nel cuore e nella mente di persone che condividono lo stesso sogno. Un sogno da solo non cambia il mondo: tanti sogni condivisi diventano un progetto. Il cardinale Carlo Maria Martini, durante un ritiro spirituale per i politici di Milano, disse che il cristiano sa che la sua barca non è certificata per la forza del mare, ma crede che Dio gli dà la forza di andare avanti. La nostra barca non può affrontare da sola le tormente della vita, ma la speranza ci fa credere che Dio non ci lascerà soli: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?».