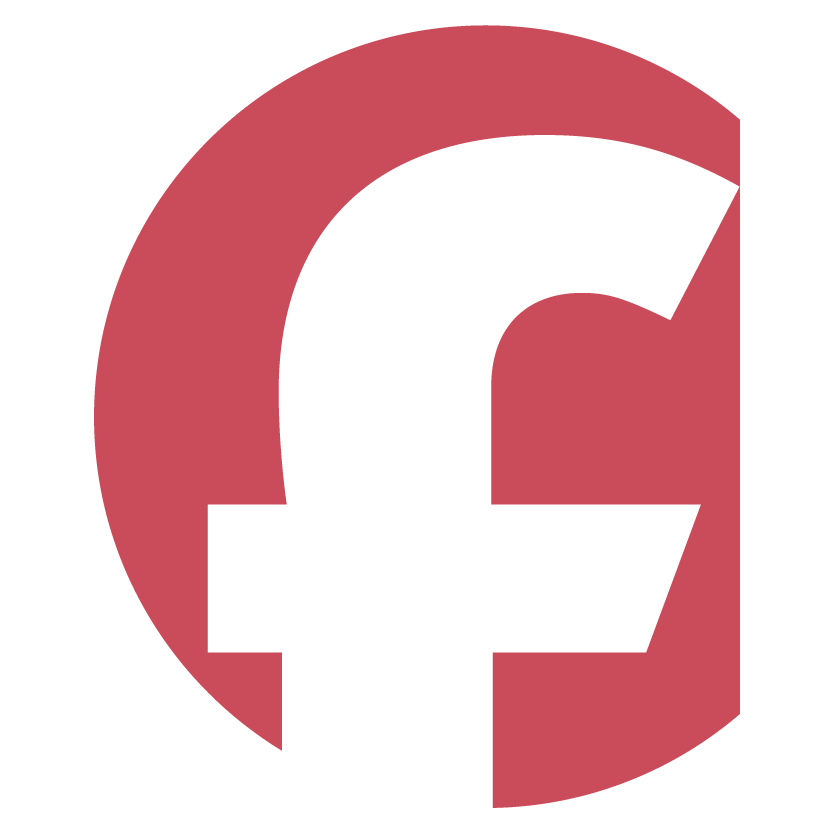“Pensare la sanità, terapie per la sanità malata” è il tema della tavola rotonda in programma il prossimo 20 febbraio nell’ambito dell’evento promosso dalla Fnomceo al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, in occasione della VI Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. In un tempo in cui la sanità italiana vive una fase di profonda trasformazione – segnata da criticità strutturali, da una crescente domanda di prossimità e dalla recente legge delega che punta a ridisegnare il Ssn – la domanda che ci accompagna oggi è semplice e radicale: “Quali terapie servono per una sanità malata?”. Lo chiediamo a don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei, che parteciperà all’evento del 20 febbraio.
Don Massimo, qual è la sua diagnosi sulla “malattia” della sanità italiana? Che cosa non funziona davvero?

Il nostro Servizio sanitario nazionale è ormai obsoleto e richiede un ripensamento complessivo.
Nato nel 1978, oggi mostra evidenti distorsioni: l’abbandono delle aree interne a favore delle metropoli, forti disparità tra Nord e Sud, crescente insoddisfazione dei cittadini e una spesa privata (out of pocket) che supera i 50 miliardi di euro, aumentando di circa 5 miliardi ogni anno. A questo si aggiungono enormi sprechi legati a medicina difensiva, inappropriatezza prescrittiva e uso non ottimale dei farmaci: solo queste tre voci pesano tra i 20 e i 30 miliardi. Non possiamo più limitarci a “manutenere” un sistema che assomiglia ad un secchio bucato.

Servono una riforma globale e un atto di coraggio politico, anche impopolare, che coinvolga davvero i professionisti.
A quale “terapia” pensa, in particolare?
Dobbiamo preservare l’universalismo delle cure, ma per farlo occorre correggere ciò che non funziona. Credo sia tempo di convocare degli “Stati generali della salute”, ascoltando chi opera ogni giorno sul campo e chi, dai territori, segnala inefficienze. Le risorse economiche e umane sono decisive. Anni di definanziamento pre‑Covid hanno indebolito profondamente la sanità pubblica. Oggi, pur con un fondo sanitario salito a 141 miliardi, gli sprechi restano altissimi. La regola dovrebbe essere semplice:

spendere bene per curare bene.
Oggi, purtroppo, non sempre accade.
La legge delega approvata il 12 gennaio in Consiglio dei ministri può rappresentare un cambio di paradigma?
È certamente un’opportunità importante, ma il suo esito dipenderà dal coraggio con cui si affronteranno le inefficienze strutturali. La domanda è semplice ma decisiva:

si avrà la forza di intervenire in modo incisivo, anche toccando interessi consolidati e assumendo decisioni politicamente impopolari?
Lei parla spesso di “doppia solitudine”: quella del malato e quella del curante. Che cosa intende?
Il malato, pur ricevendo cure, spesso non si sente realmente “curato”, non percepisce attenzione alla sua interezza. Il professionista sanitario, invece, fatica a vedere il senso del proprio agire, schiacciato da carichi di lavoro e da un’organizzazione che non valorizza la relazione.
Come si può superare questa doppia solitudine?
Occorre recuperare la dimensione empatica e personale della cura, dedicando più tempo al paziente. Ma l’attuale sistema, centrato sulla prestazione e sull’efficienza, non lo permette. Servono più professionisti qualificati lungo tutta la filiera: solo così si alleggeriscono i carichi di lavoro, si restituisce tempo alla relazione e si garantiscono condizioni di serenità e sicurezza a chi cura.
Dopo il Covid avete promosso un momento mensile di preghiera e ringraziamento per i curanti. Perché?
Ci sembra doveroso ringraziare quel milione e mezzo di persone – medici, infermieri e tutte le figure sanitarie rappresentate nei 32 Ordini – che ogni giorno si fanno carico del dolore e della fragilità dei cittadini. È un gesto semplice, ma necessario.
Il Papa, nel Messaggio per la XXIV Giornata mondiale del malato, ha richiamato la compassione del Samaritano come modello operativo delle professioni di cura. Quale può essere, in questo orizzonte, il ruolo della comunità cristiana?
La cura biologica e psicologica spetta ai professionisti; la cura spirituale è responsabilità della comunità dei credenti. Viviamo una solitudine sociale che il sistema sanitario non può affrontare da solo.

Le comunità cristiane devono costruire una rete solidale, ispirata al Buon Samaritano: fermarsi, ascoltare, donare tempo gratuitamente.
Oggi oltre 3.300 operatori spirituali accompagnano la sofferenza nei luoghi sanitari e socioassistenziali, ma non basta. Le grandi solitudini sono anche quelle degli anziani e dei malati nelle loro case senza una rete familiare, spesso invisibili. Qui servono comunità capaci di prossimità concreta. I ministri straordinari della Comunione – circa 100mila in Italia – sono antenne preziose, capaci di intercettare fragilità che altrimenti resterebbero nascoste.

E’ la gratuità la vera sfida del nostro tempo che tende a monetizzare tutto, ed è anche la chiamata di Papa Leone a tutti noi.