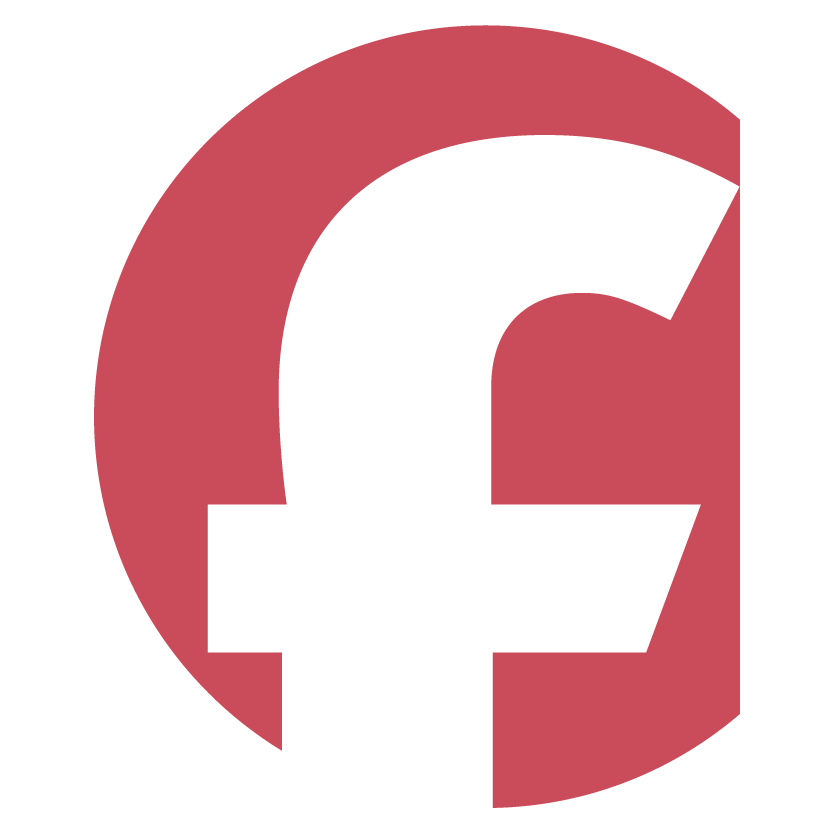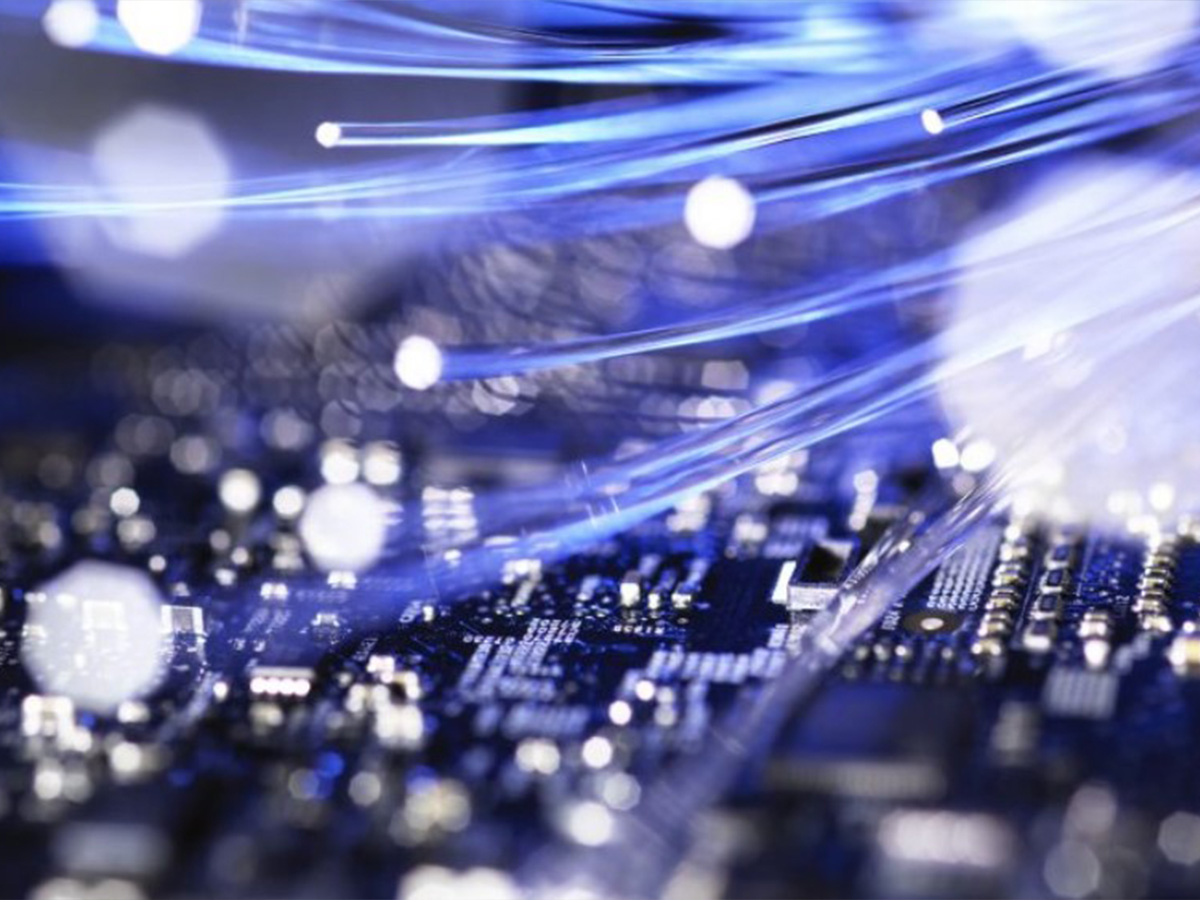
La trasparenza è diventata una parola di moda. Anche in ambito tecnologico.
Essa è uno dei principi spesso invocati nell’etica dell’intelligenza artificiale. Dobbiamo sapere come un sistema di IA arriva a certe conclusioni o offre alcuni risultati. Magari non lo deve conoscere nel dettaglio l’utilizzatore finale, ma certo chi realizza, produce e commercia questa tecnologia.
La necessità di questo principio denuncia una delle caratteristiche più complesse dell’IA: in realtà quasi nessuno, neanche gli esperti, sa esattamente come queste macchine funzionino. Si parla di black boxes: scatole nere. Sappiamo cosa entra, i dati di cui l’IA si alimenta; sappiamo cosa esce, il risultato finale che abbiamo richiesto; ma non sappiamo bene cosa succede dentro la scatola. Obiettivamente un problema, su cui fortunatamente scienziati e tecnici stanno lavorando, spinti proprio dal principio di trasparenza ovunque invocato.
La trasparenza è anche uno degli esiti della vita umana al tempo dei social. Tutto è esibito, mostrato, fotografato, commentato, giudicato. Gli spazi della vita privata si sono clamorosamente e pericolosamente assottigliati. Ha fatto scalpore qualche tempo fa la coppia di amanti americana fotografata durante un concerto e mostrata su tutti gli schermi dello stadio prima e del mondo poi: matrimoni andati in frantumi e licenziamenti istantanei. Il senso del pudore – ahimè – non è più una virtù e il privato è subito tutto pubblico. Senza nessuna mediazione, senza nessun muro di casa o tenda che oscura le finestre. Siamo ciò che si vede: la casa dei social è una casa trasparente.
Nel primo caso la trasparenza è un principio virtuoso da invocare e pretendere, nel secondo un’insidia che non riusciamo a maneggiare facilmente.
A ben vedere, la trasparenza non è una caratteristica umana. Noi siamo sostanzialmente opachi. Siamo fatti di carne e non di rado i nostri pensieri assomigliano più a un guazzabuglio insondabile che a una linearità cristallina. Cosa accade nel nostro cervello è ancora sostanzialmente un mistero che si perde nelle infinite connessioni dei nostri neuroni. E cosa siano davvero le emozioni che ci costituiscono e che rendono tutto più complicato e entusiasmante è ancora una questione decisamente aperta.
Siamo opachi ma non per questo cattivi. L’opacità ha che fare con il nostro essere radicati sulla terra, impastati di fango dice la Bibbia, in un qui e in un ora specifico che ci determina. Siamo sostanzialmente inspiegabili: una sfida a noi stessi, da sempre impegnati a riflettere su ciò che rende umani. Siamo un mistero: qualcosa che sfugge a ogni definizione totalizzante e al contempo rivela rimandando a qualcos’altro. Anche a qualcun Altro.
La trasparenza assoluta non fa per noi e quella qualità tutta umana che si chiama opacità merita di essere custodita, certo non per nascondere nefandezze, ma per rispettare il mistero che siamo e dobbiamo continuare a essere. E che ci rende diversi anche dalle macchine che costruiamo e che vogliamo giustamente trasparenti. Perché le macchine non sono come noi, anche se sono capaci di emulare alcune funzioni che fino a oggi pensavamo essere solo squisitamente umane. L’intelligenza artificiale non è intelligente, non pensa, non parla. Non si prende cura di noi e non ci apprezza, malgrado sia sempre gentile quando ci risponde. La gentilezza, come l’intelligenza, il pensiero, la coscienza, la passione, le emozioni, è cosa da uomini.
Noi umani, insuperabilmente opachi e carnali, dobbiamo esigere che le nostre macchine digitali siano trasparenti. Ne va di quella differenza che tanto ci preoccupa in questo tempo così sfidante.