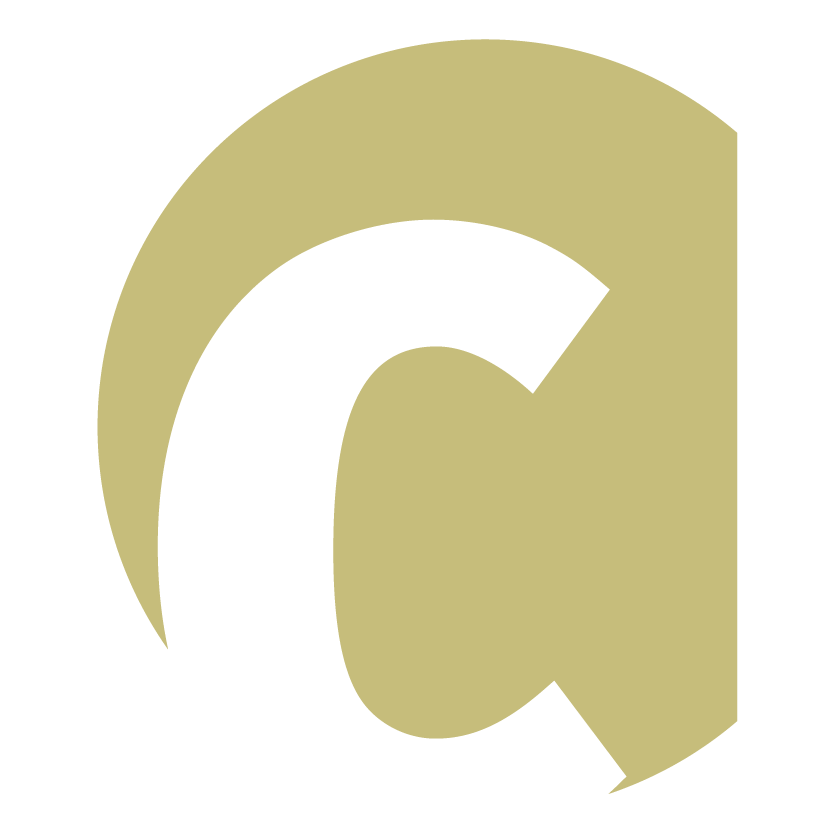«Ho sempre avuto due compagni di viaggio che non sono mai riuscita a lasciare indietro: la povertà e la fame». Un’affermazione di Betta Garuti, missionaria della Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23), che racchiude un mondo, racconta il suo instancabile impegno per gli ultimi e ricorda che la solidarietà non è solo un gesto, ma una scelta quotidiana che può cambiare la vita di tante persone. E la campagna “Un pasto al giorno”, di Apg23 è la prova vivente che anche un piccolo contributo può fare una differenza enorme. Abbiamo incontrato la missionaria in occasione della due giorni di celebrazioni per il 40° della campagna (27-28 settembre).
Betta, ci racconti il tuo primo incontro con la fame in Africa?
«Da ragazza vivevo una vita agiata: una buona famiglia, l’università, gli scout, la parrocchia… ma dentro sentivo una frattura. Guardavo le immagini del Biafra e mi chiedevo: “Perché io mangio cinque volte al giorno e quel bambino non ha neanche un bicchiere di latte?”. L’estate del 1983, durante un campo scout, incontrai don Oreste Benzi e la Comunità Papa Giovanni XXIII. Mi chiesi: “Se mi restasse solo un anno di vita, cosa farei?”. La risposta fu: “Partirei per l’Africa per combattere la fame”. Quando si aprì la prima missione della Comunità in Zambia, partii. Fu un dono immenso».
«Nel 1985 hai raccontato a don Oreste la realtà della fame. Che cosa ricordi di quel momento?
Don Oreste venne in Zambia poco prima di Natale. Visitò l’asilo nel bosco dove cercavamo di garantire almeno un pasto al giorno. Vide negli occhi dei bambini malnutriti la fame vera, quella che svuota e spegne. Mi chiese: “Quanto costa dare da mangiare a uno di questi bambini per un mese?”. Risposi: “Circa 10mila lire.” Lui disse: “Torno in Italia, lo dico a tutti. Vedrai che la gente ci aiuterà”. E così è stato».
Come è nata la campagna “Un pasto al Gìgiorno”?
«È nata da quella domanda e dalla risposta della gente. Quando don Oreste lanciò l’appello, persone di ogni età iniziarono a portargli le loro 10mila lire. Non era solo carità, era dire: “Io ci sono.” Da allora, ovunque ci sia una tavola della Comunità e una persona affamata, c’è anche “Un pasto al giorno”. È una scelta quotidiana, sostenuta dalla Provvidenza e dalla generosità della gente comune».
Che cosa ti ha insegnato la gente comune in questi 40 anni?
«Che chiunque, ma davvero chiunque, può fare qualcosa. Ho visto pensionati con pensioni minime donare le loro 10mila lire, studenti rinunciare a una birra con gli amici per far mangiare un bambino. Non tutti possono partire per l’Africa, ma ognuno può fare la sua parte. Questo è il cuore della campagna: la concretezza di un gesto semplice che unisce le persone da una parte all’altra del pianeta».
Come è cambiato il volto della fame in questi decenni? Penso ai bambini della Striscia di Gaza, ma anche a tanti altri in diverse parti del mondo…
«Il volto è sempre lo stesso: quello di un bambino che muore. Ma le cause sono cambiate: oggi la fame è legata a scelte economiche e politiche sbagliate, guerre, cambiamento climatico, disastri ambientali. Don Oreste parlava di una “società del gratuito” contrapposta a una “società del profitto”. Oggi il profitto ha vinto ovunque. Se non si rimuovono le cause profonde dell’ingiustizia, non cambierà nulla.
La fame non è una fatalità: è il risultato delle scelte di chi governa il pianeta».
Quali sono oggi le nuove sfide?
«La prima è non stancarsi, non pensare che il problema sia troppo grande o che sia troppo tardi. A volte ci si convince che sia tutto inutile, ma è proprio allora che il bene diventa più potente. Non possiamo cambiare tutto ma ogni pasto salva una vita. La seconda sfida è più profonda: mettere in discussione il sistema che genera povertà. Siamo di fronte ad un paradosso: prima si bombardano i popoli e poi si finanziano gli aiuti umanitari per salvarli, come se bastasse un sacco di farina lanciato da un elicottero per riparare ciò che le bombe hanno distrutto. Questo non è rispondere al bisogno: è continuare a ignorarne la causa. Per questo dico che l’elemosina non basta, Serve un profondo cambiamento culturale e politico, un sistema nuovo in cui la giustizia venga prima del profitto».
Che cosa ti preoccupa e che cosa ti dà speranza?
«Mi preoccupa il vuoto in tanti giovani: non riusciamo più a trasmettere loro un senso, uno scopo per cui valga la pena vivere. Ma la speranza arriva da chi ogni giorno non si arrende. Incontro persone che agiscono con tenacia, anche nel piccolo. E mi dà speranza il fatto che l’appello lanciato 40 anni fa sia ancora vivo».
Per te che cosa significa “nutrire” una persona?
«È accoglierla alla propria tavola. Non è solo cibo, è famiglia. È dire: “Tu sei con me, non sei più solo.” Chi arriva nei nostri centri trova cura, dignità, ascolto. La fame più profonda è non sentirsi parte di niente.
Nutrire è restituire un posto nel mondo».
Che cosa vorresti dire a chi parteciperà oggi e domani al 40° della campagna?
«Sostenere “Un pasto al giorno” non è beneficenza, è scegliere da che parte stare. Non si tratta di delegare, ma di mettersi in gioco, anche con un piccolo gesto. Un pasto condiviso può cambiare la vita di chi lo riceve e di chi lo offre. È un atto di giustizia».