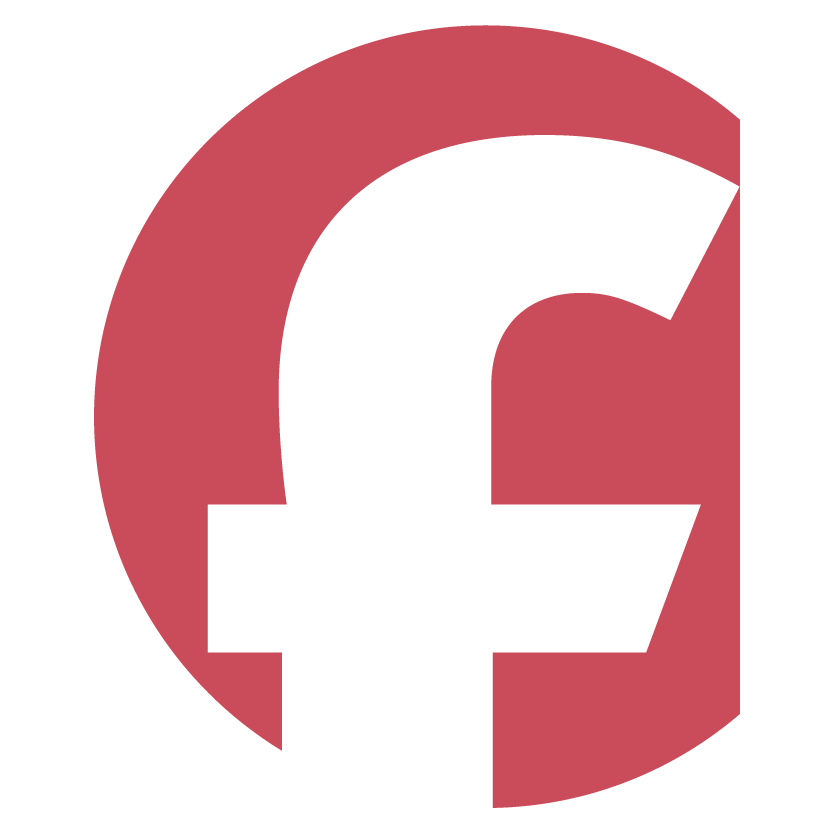Uno studio pubblicato sulla rivista Behaviour & Information Technology, coordinato da Antonella Marchetti, Direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica.
“Già a cinque anni i bambini giudicano le azioni in base a una sorta di ‘codice morale interno’ che li guida e che non dipende dalla natura del colpevole. Infatti, per un bimbo della scuola dell’infanzia rubare o non condividere è sempre sbagliato, sia che a farlo sia un coetaneo, sia un robot. Questa tendenza vale anche sul piano emotivo: i bambini di questa età attribuiscono emozioni negative – dispiacere, colpa – anche ai robot, come se fossero capaci di sentire”. È quanto scoperto in uno studio pubblicato sulla rivista Behaviour & Information Technology, coordinato da Antonella Marchetti, Direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica, Campus di Milano e del Ceritom (Centro di Ricerca sulla Teoria della Mente e le competenze sociali nel ciclo di vita) in collaborazione con i colleghi giapponesi Ishiguro, Itakura, Kanda, con la collega inglese Gummerum e con Davide Massaro, Cinzia Di Dio, Federico Manzi e Giulia Peretti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Professoressa Marchetti, da quali premesse nasce lo studio sul codice morale interno dei bambini realizzato in cooperazione tra Italia e Giappone?
La collaborazione con i colleghi giapponesi è avviata ormai da molti anni. Insieme abbiamo analizzato la capacità di comprensione degli stati mentali propri e altrui – la Teoria della Mente – in soggetti di varie età in situazione di interazione con altri umani o robot umanoidi.
Quali processi sono alla base dello sviluppo della coscienza morale dei bambini?
C’è chi sostiene che vi sia una predisposizione innata a comportarsi moralmente, ad esempio Jean Jacques Rousseau con il mito del “buon selvaggio” attribuisce alle influenze ambientali la responsabilità delle scelte non morali dei singoli. Nella visione di Thomas Hobbes, al contrario, l’espressione “homo homini lupus” raffigura un individuo in origine potenzialmente in conflitto con i propri simili per il possesso delle risorse. La costrizione sociale è vista da Hobbes come lo strumento grazie al quale si giunge ad adeguare la condotta al principio di una maggiore convenienza di comportamenti socialmente e normativamente regolati. A partire da queste concezioni, risulta di grande interesse in psicologia di occuparsi dello sviluppo della moralità nel corso della vita, presupponendo che essa possa cambiare nel tempo e accettando una posizione ormai condivisa, cioè che la dotazione innata e l’ambiente culturale esercitino entrambi una influenza in questo processo.
L’impostazione educativa e la formulazione dei giudizi morali dei bambini italiani e di quelli giapponesi presentano differenze significative?
I bambini italiani giudicano più severamente la trasgressione morale rispetto ai bambini giapponesi, indipendentemente dal fatto che questa avvenga nell’interazione con un pari o con un robot umanoide. Tuttavia i bambini giapponesi dimostrano di essere maggiormente empatici nei confronti di chi è vittima della trasgressione. L’impressione è che l’impostazione educativa in Italia tenda maggiormente all’individualismo e sia prevalentemente centrata sulla valutazione dell’esito di una azione negativa. In Giappone, invece, sembra avere maggior peso il fatto che la trasgressione violi il senso emotivo profondo della connessione interpersonale.
Quindi una cura più attenta della sfera socio-emotiva può arricchire lo sviluppo della coscienza morale nell’individuo?
Agire sulle emozioni può avere un significato importante per potenziare il senso morale fin dalla prima infanzia. Abbiamo chiesto ai bambini: “Come ti sentiresti se fossi tu il trasgressore?”. L’assunzione della prospettiva altrui ha ridotto il gap tra Italia e Giappone rispetto alle valutazioni emotive e questo ci fa comprendere come una educazione socio/affettiva e non puramente cognitiva sia opportuna per potenziare il senso morale. In Giappone, il valore della condivisione e dell’armonia sociale è insegnato molto presto e le emozioni sono uno strumento centrale per rafforzare i legami e correggere i comportamenti. Non a caso esiste in giapponese un termine che non ha corrispettivo nella nostra lingua – “Amae” – che indica l’emozione connessa al profondo senso di interdipendenza che pervade la cultura di quel popolo.
Quali trasformazioni subisce la coscienza morale nell’adolescenza?
In adolescenza la concezione e il comportamento morale risentono moltissimo dell’influenza del gruppo dei pari. Questo fattore deve sollecitare gli adulti a conoscere i valori di riferimento dei teenager, i loro miti e le loro rappresentazioni della realtà. Soltanto attraverso un ascolto attivo e non giudicante, genitori, insegnanti ed educatori possono mantenere vivo il dialogo educativo e coltivare il senso della responsabilità morale. Gli adulti sono chiamati cioè a esercitare il “coraggio dell’ascolto”. In generale, questa ricerca ci invita a guardare i bambini non come adulti in costruzione, ma come giudici morali già attivi, con una bussola interiore, emozioni vere e uno sguardo sorprendentemente lucido e profondo anche sulle macchine.