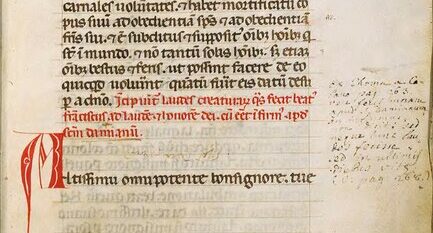
«Laudato si, mi’ Signore» chi non conosce l’incipit delle Laudes creaturarum, il Cantico di frate Sole? È la prima manifestazione di poesia religiosa in volgare italiano, è il testo che anima la spiritualità francescana e che ha suscitato, in ogni epoca, risonanze creative, nell’arte, nella musica, nel cinema.
Sono passati 800 anni da quando san Francesco compose questo testo. Concepito come preghiera, la sua potenza, la sua forza, non si sono mai affievolite. In questi otto secoli non ha perduto nulla del suo fascino, e rimane un’eredità da condividere. Qual è il segreto di tale longevità? Cosa lo rende ancora così attuale?
«Possiamo evidenziare tre punti – afferma padre Antonio Ramina, rettore della basilica di sant’Antonio di Padova – Come sappiamo è innanzitutto un testo poetico. Questo forse lo si dà per scontato, ma quando una persona canta, quando si esprime in poesia, sta utilizzando un linguaggio non tecnico o funzionale, ma gratuito e creativo. Il Cantico in questo senso non dà informazioni, ma apre orizzonti, aiuta chi lo ascolta ad aprire il cuore e a sollevarlo verso prospettive più ampie. È un testo che si rivolge a Dio in maniera gratuita. La seconda cosa da sottolineare è che san Francesco lo scrive avvicinandosi alla fine della vita. È un uomo malato che soffre. Tuttavia la sua prospettiva è una prospettiva di lode, di canto, di restituzione. E quindi ci dà l’idea proprio di un uomo che non è chiuso in se stesso, ma che si lascia trasportare da orizzonti più vasti, dalla speranza che allarga il cuore. Non vediamo un uomo ripiegato, ma un uomo aperto. Da un punto di vista spirituale quindi uno degli aspetti più evidenti è la qualità gioiosa e grata che emerge nell’esperienza di san Francesco. Si avvia alla fine della sua vita lodando e ringraziando. Pur nella malattia non c’è spazio per lamentele o disperazione, ma dà voce a un grande desiderio di restituire tutto. Francesco si sente una creatura fra altre creature, si sente ricevuto da Dio e vuole restituire, restituirsi. È un fortissimo antidoto contro ogni stile narcisista e autoreferenziale».
Qui si inserisce la dimensione dell’attualità.
«Francesco fondamentalmente ringrazia. Utilizza molte volte in altri suoi scritti il verbo restituire. Il Cantico è un testo che restituisce tutto al Signore. Allora anche in questo senso è un testo “buono” per l’oggi, lì dove sembrano prevalere solo prospettive narcisistiche autoreferenziali. Qui invece abbiamo un antidoto contro questo stile, perché riconosce di non essersi fatto da sé, ma riconosce di essersi ricevuto e quindi si restituisce assieme a tutte le altre creature. Il Cantico è l’espressione di un uomo che si coglie in relazione, non chiuso in sé stesso. La sua fede lo porta a togliere di mezzo i muri di separazione, le distinzioni nette; canta la sua condizione di persona in relazione con ogni creatura come segno della bontà di Dio».
Suggestivo è poi il modo con cui si pone di fronte alla morte.
«Essa non è la fine, ma la “sorella” che aiuta a compiere il passaggio verso la meta, verso la comunione con il Signore. Se c’è una morte da temere è quella del rancore e della violenza: nel Cantico vi è l’esortazione al perdono, sempre. Non può esserci comunione con Dio senza comunione tra di noi. E questi sono aspetti che possono toccare tutti, anche chi non ha fede o è in cammino. Francesco si sente in comunione con il creato. Ecco, una fede matura è una fede che va verso la comunione, non verso la separazione. E questo credo che sia valido anche in senso semplicemente umano, al di fuori di una prospettiva di fede. La bellezza di una persona sta proprio qui, nella sua capacità di non porre distinzioni e divisioni nette, ma di intuire punti di contatto e di dialogo».





