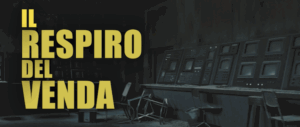I rovi sui fili spinati arrugginiti, i cartelli di divieto corrosi dal tempo, una sorta di caserma fatiscente color militare, abbandonata. Sono i resti sinistri e spettrali di quella che un tempo fu la base Nato 1° Roc (Regional operation command) sul monte Venda, il rilievo più alto dei colli Euganei. Scovare le poche strutture rimaste in superficie non è difficile, ma il vero cuore dell’edificio si nasconde nel ventre del monte, un tunnel lungo circa un chilometro che dal 1955 al 1998 ha ospitato militari americani e italiani impegnati in attività di rilevamento e monitoraggio. Ma perché costruire una base militare proprio in questa area? E, domanda ancora più spinosa: quando fu edificata, qualcuno era a conoscenza della pericolosità della zona dovuta alla presenza capillare del gas radon?
Sono questioni alle quali è difficile rispondere, se non altro perché tutto è stato top secret per molti anni e, in parte, lo è tutt’ora, come ripercorre il prof. Antonio Varsori, emerito di storia delle relazioni internazionali nell’Università di Padova: «Siamo nel 1949 e l’Italia aderisce al Patto Atlantico in veste di Paese fondatore, un accordo che in quel momento rappresenta più una garanzia politica. Poi, nel 1950, scoppia la guerra di Corea e si arriva a una rapida militarizzazione della Guerra Fredda con l’istituzione operativa della Nato».
Gli Stati appartenenti alla Nato si impegnavano a difendersi a vicenda da eventuali attacchi da parte di terzi, in particolare dall’Urss e/o dagli Stati satellite. Una difesa che doveva, dunque, poggiare su solide strutture militari: «Fin dagli anni Cinquanta gli Usa hanno adottato una politica di militarizzazione, perché ritenevano possibile una guerra. Quindi all’interno della cornice della Nato vengono create basi militari in tutta Europa, Italia compresa. Il nostro Paese è situato sul fronte sud della stessa Nato e a partire dal 1955 anche sul nostro territorio iniziano a comparire delle basi in seguito a un accordo bilaterale ancora oggi in parte riservato – prosegue il professore – Uno dei temi più controversi è la giurisdizione che, nelle basi Nato americane, è degli Stati Uniti. Pertanto chi commette reati all’interno queste strutture o chi lavora sotto l’egida della Nato nel nostro Paese viene giudicato negli Stati Uniti, come è avvenuto dopo la strage del Cermis del 1998 quando un aereo statunitense tranciò i cavi di una funivia in Trentino causando venti morti: i responsabili furono prosciolti dalle accuse ma in patria, non in Italia».
Oltre alla giurisdizione esiste anche un tema di responsabilità e di catena di comandi. Chi prendeva (e prende tutt’ora) le decisioni? Gli americani, gli italiani, o assieme? «La verità è che non lo sappiamo con esattezza, qualcosa è stato scritto negli accordi, poi ci sono dei “non detti”, delle convenzioni tacite. Per esempio negli anni Cinquanta gli americani in Puglia avevano installato una base militare con testate nucleari; vigeva il principio della doppia chiave, non avrebbero potuto essere sganciate solo dagli uni o dagli altri».

Molti punti restano da chiarire: com’era strutturata la collaborazione tra italiani e americani? Negli anni Cinquanta si sapeva della pericolosità del radon e si è taciuto?
Altra questione quella del rapporto costi e benefici. «Gli Stati Uniti ancora oggi chiedono che i paesi Nato si assumano buona parte dei costi della difesa. Nel corso della Guerra Fredda, quando si è percepito un allentamento della tensione e quindi del rischio (come a inizio anni Settanta), si è andati verso una riduzione del numero delle basi eliminando quelle non strategiche. Nel nostro territorio alcune sono tutt’ora importanti come quella di Aviano – dove sono stoccate testate nucleari – o quelle di Verona e Vicenza ancora attive perché sono visibili, quindi rappresentano un presidio simbolico – continua il prof. Varsori – Dal 1989 in poi, con la caduta dell’Unione Sovietica, alcune basi hanno perso la loro funzione. Quella del Venda a maggior ragione risultava poco utile visto che la tecnologia è avanzata e i controlli e i rilievi oggi possono essere eseguiti con altri sistemi, tramite gli aerei per esempio».
Oggi la base è del Ministero della Difesa, ma proprio in merito alla questione della giurisdizione sarebbe interessante capire se ci sono responsabilità per chi lavorò all’interno della base, respirando il radon, e chi dovrebbe giudicare. Molti punti restano insomma da chiarire: com’era strutturata la collaborazione tra italiani e americani? Quali erano effettivamente i compiti della base? Negli anni Cinquanta si sapeva della pericolosità del radon e si è taciuto?
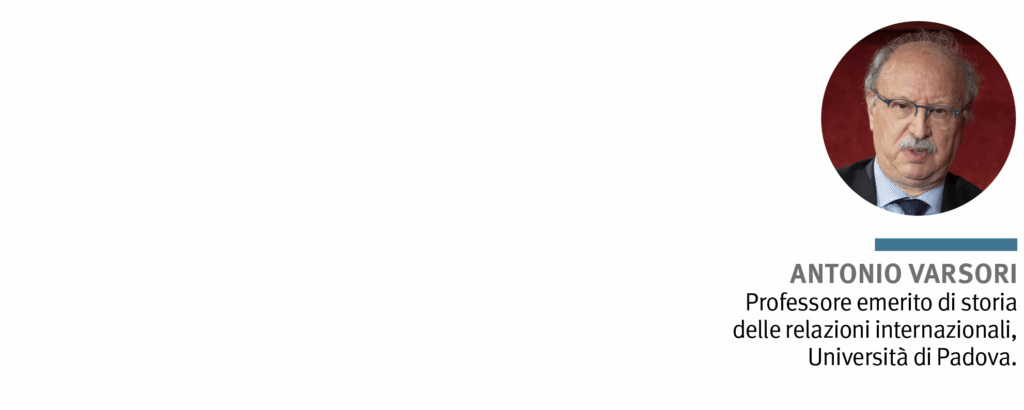
Nella stessa puntata: