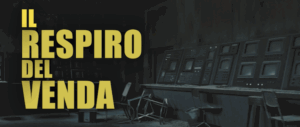A pochi passi da Padova è scoppiata una bomba. E nessuno se n’è accorto. Un’esplosione silenziosa, un gas radioattivo che ha contaminato un’area di quasi 200 chilometri quadrati causando effetti nocivi per gli ignari cittadini. Quando? Verosimilmente 30 milioni di anni fa, quando l’uomo ancora non esisteva. I problemi sono iniziati dopo.
«Sorgono isolati come scogli nel mare». Vengono definiti così i colli Euganei, in provincia di Padova dal geologo inglese John Strange nella seconda metà del Settecento. Vecchi vulcani ora spenti le cui viscere continuano a borbottare e regalare acqua termale a frotte di visitatori, desiderosi di ristorarsi in lussuose piscine o accoglienti fanghi. Sui clivi germogliano rigogliosi sconfinati filari di viti. Sui sentieri non si contano sportivi e turisti che si rilassano a pochi chilometri dal caos cittadino. Un ambiente bucolico e ospitale che tuttavia, di tanto in tanto, riscopre la propria conformazione geologica. Un territorio da vivere e popolare, ma dove bisogna prestare attenzione.
Dalla terra, infatti, fuoriesce il gas radon, classificato dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, come cancerogeno per i polmoni. «La probabilità del danno sanitario è proporzionale all’esposizione al gas: più elevata è l’esposizione (data dalla concentrazione di attività di gas radon in aria per il tempo di permanenza) maggiore è la probabilità – ricorda l’Arpav, l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto – Non ci sono evidenze che vi sia una soglia sotto la quale si può escludere il danno. Si stima che in Italia circa il 10 per cento dei casi di tumore polmonare sia attribuibile al radon (intorno ai 3.400 casi/anno), percentuale che aumenta tra i fumatori. In natura questo gas è presente ovunque, ma nell’area dei colli Euganei è particolarmente abbondante, al punto che ciclicamente vengono compiuti rilievi per testarne i livelli ed esiste un vademecum su come costruire gli edifici ed areare le stanze.
Il problema è lì da sempre, ma non ci si pensa. Così come nessuno ci ha pensato negli anni Cinquanta, quando si è costruita una base militare Nato nel ventre del Venda, il monte più alto dei Colli. Il periodo è quello della Guerra Fredda quando l’Italia è schierata assieme agli Stati Uniti contro l’Urss. Un territorio vasto come la Pianura Padana ha bisogno di presìdi, e quale posto migliore di un colle alto poco più di 600 metri per costruire una base con compiti di monitoraggio e rilevazioni? La scelta si rivelerà nefasta e la bomba, simile a una vera, scoppierà poco dopo l’arrivo dei soldati nella base. Uomini che dopo anni di lavoro, senza protezioni, si ammaleranno o addirittura moriranno in conseguenza dell’esposizione al gas tossico.
Sono molte le domande che ancora oggi circondano la triste vicenda e che, da questo numero della Difesa, si cercherà di dipanare in un’inchiesta a puntate. Inchiesta che non può non partire dall’ambiente e, quindi, dall’annoso tema del radon. Quanto annoso? O meglio, da quanto si è a conoscenza del problema? Relativamente da poco. Come ha spiegato pochi mesi fa Manuela Lanzarin, assessore alla salute della Regione Veneto, «fin dagli anni Novanta, nel contesto europeo, ha cominciato a delinearsi un’attenzione». Norma dopo norma (comunitarie, nazionali e locali) a maggio di quest’anno si è arrivati a un’individuazione puntuale dei Comuni con una maggiore presenza di questo gas. In provincia di Padova i territori di Vò, Cinto Euganeo e Torreglia sono diventati sorvegliati speciali dopo i rilievi dell’Arpav e sono stati inseriti, da una delibera regionale dello scorso maggio, nelle cosiddette aree prioritarie.
Queste ultime, puntualizza Arpav, «sono definite come le zone in cui si stima che la concentrazione media annua di radon superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici. Nelle aree prioritarie vi è l’obbligo della misurazione nei luoghi di lavoro al piano terra/seminterrato/interrato e vanno sensibilizzati i cittadini a fare misure nelle proprie abitazioni con azioni mitigative nei casi critici».

Il problema è lì da sempre, ma non ci si pensa. Così come nessuno ci ha pensato negli anni Cinquanta, quando si è costruita una base militare Nato nel ventre del Venda, il monte più alto dei Colli.
È a questo punto che la storia della base Nato e l’attualità si intrecciano. Se ormai per chi ci ha lavorato non si può fare più nulla, se non uno stretto monitoraggio e controlli medici, per cittadini e imprese che vivono nelle aree prioritarie s’impongono misure sempre più stringenti. «La Regione Veneto ha affidato ad Arpav il compito della misurazione della concentrazione di radon in tutte le scuole e le sedi delle Aziende sanitarie dei Comuni in area prioritaria» annota l’ente regionale. Per quanto riguarda cittadini e imprese, mentre i primi sono caldamente invitati a monitorare i livelli del gas radioattivo, in particolare al pian terreno delle proprie case, nei seminterrati e negli interrati, le imprese che hanno locali al piano terra, seminterrato o interrato sono obbligate da una legge statale del 2020, che ha trovato oggi attuazione proprio in seguito alla recente istituzione delle aree prioritarie. Per questo, a partire dal 19 novembre e per 12 mesi, dovranno essere compiuti rilevi per attestare i livelli di radon nei luoghi di lavoro.
«Ove sia superato il rispettivo livello di riferimento si procede con un intervento di risanamento (raccomandato per le abitazioni, obbligatorio per i luoghi di lavoro) per ridurre le concentrazioni del gas. Se fattibile, si può procedere con azioni mitigative anche per valori inferiori al livello di riferimento. Per i nuovi edifici è opportuno predisporre azioni che consentano di limitare l’accesso del gas nei locali al chiuso» spiega sempre Arpav.
Quanto sia strettamente attuale l’argomento lo dimostrano i tre incontri pubblici, tra ottobre e novembre, nei Comuni rientranti nell’area prioritaria dei Colli. Alla presenza di esperti e istituzioni, cittadini e imprese hanno “ripassato” le buone pratiche per disperdere il radon negli ambienti chiusi e le tecniche per rilevarlo. Una lezione che sarebbe certamente servita oltre mezzo secolo fa quando iniziarono a prestare servizio nella base 1° Roc (Regional operational command) decine di militari, popolando i tunnel sotterranei poco arieggiati e, tra l’altro, intrisi di strutture in amianto. Una bomba ecologica che a distanza di quasi trent’anni dalla chiusura giace abbandonata, custodendo domande e silenzi che, forse, è tempo di riportare alla luce.

Pericoloso e oltretutto incolore e inodore
Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore che si forma nel sottosuolo e deriva dalla disintegrazione del radio. È fonte di radiocontaminazione ambientale (il cosiddetto inquinamento da radon) a causa della sua presenza in alcuni materiali da costruzione o nelle rocce sottostanti gli edifici.
Monte o collina? La differenza sta nel metro in più…
Il monte Venda (601,3 metri), è la vetta più alta dei colli Euganei. Situato nei Comuni di Teolo, Cinto Euganeo, Galzignano e di Vo’, conserva ruderi del monastero degli Olivetani e ospita importanti impianti radiotelevisivi nazionali.
Nella stessa puntata: