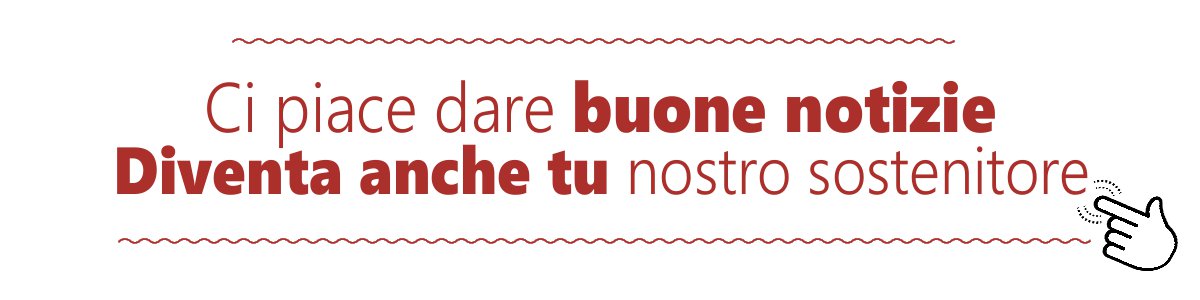Etica e cibo. Nutrirsi non è un gesto neutrale
Etica e cibo Se n’è parlato il 13 maggio in un seminario della Fondazione Lanza. La scelta di cosa (e di quanto) mangiamo dice molto di ciò in cui crediamo. Parlare di cibo, in definitiva, non è solo parlare di alimenti, ma di relazioni tra esseri umani, di saperi millenari sulla nutrizione e di organizzazioni sociali, sempre più diffuse, che permettono di scegliere con consapevolezza il cibo da mettere in tavola ogni giorno

Il cibo. Poche cose come il cibo e l’atto di mangiare accomunano le persone, scandiscono le nostre giornate, tanto nel lavoro quanto nel tempo libero. Iniziamo la giornata mangiando, la continuiamo pensando a cosa avremo a pranzo, parliamo persino di cibo finché stiamo desinando e poi ancora passiamo parte del nostro tempo a compilare lunghe quanto disattese liste della spesa con ciò che vorremmo – o dovremmo – mangiare in futuro per finire trascorrendo la serata in compagnia di cuochi e aspiranti tali, ristoratori e golosi di mille provenienze che dalla televisione rimestano, affettano, sorbiscono e sentenziano. Una vera bulimia di informazioni prima che di sapori ai quali la Fondazione Lanza, centro studi della Diocesi di Padova specializzato in etica delle professioni, ha cercato di rispondere attraverso l’incontro conclusivo del secondo anno di studi intorno al tema della vulnerabilità. Una ricerca della “diet-etica”, come ha riassunto con una battuta il presidente del comitato scientifico della fondazione, Antonio Autiero. «Quando parliamo di cibo, parliamo di relazioni – spiega Adriano Fabris, professore ordinario di filosofia morale all’Università di Pisa e autore del saggio Etica delle relazioni alimentari – relazioni degli esseri umani fra loro, quindi la convivialità, ma anche le relazioni fra gli esseri umani il mondo, l’ambiente in tutte le sue articolazioni e quindi la sostenibilità». Un concetto ampio, insomma, che si scontra con un dato di fatto: «Di solito mangiamo male – chiosa Fabris – Non perché mangiamo cose che ci fanno male, ma perché affrontiamo in maniera sbagliata la nostra relazione alimentare». Finiamo, insomma, per trascendere dando al cibo troppa o troppa poca importanza così come dimenticando di coltivare con esso un rapporto maturo, prima ancora che sano. «Tutto si incentra sul soddisfacimento del proprio gusto che è una categoria estetica sviluppata nel Settecento che è poi diventata una categoria etica – chiarisce il professore – si è passati dal sapere al sapore e poi, naturalmente, non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace e quindi via, liberi tutti. Ognuno ha il diritto di mangiare quello che gli pare e sostanzialmente di fare quello che gli pare». Spesso più nel dispetto che nel rispetto altrui, verrebbe da aggiungere. Per ritornare a coltivare relazioni equilibrate e responsabili, Adriano Fabris richiama tutti a un’assunzione di responsabilità e, per farlo, si affida a un decalogo, dieci “comandamenti” fra il serio e il faceto che però appellano le coscienze di ciascuno. E così eccoci esortati a non parlare del cibo a sproposito, non fare di esso un problema e neppure un idolo al pari di chi lo prepara. Non rubare il cibo ma neppure dire bugie su di esso, non distruggere per nutrirci e, ancora, rispettare gli altri esseri viventi. Mangiare, insomma, non è e non può essere un atto neutrale perché in larga misura possiamo scegliere – noi sì! – di cosa nutrirci, in che modo e in che quantità. Possiamo esercitare un arbitrio il cui limite è insito quasi esclusivamente nella nostra fantasia, nell’estensione del supermercato di quartiere e nel menù del ristorante. «Dal punto di vista delle scelte alimentari – riporta all’ordine Mariateresa Nardi, responsabile dell’unità operativa di dietetica e nutrizione clinica dello Iov – manca un apporto adeguato di fibre integrali, quindi la maggior parte di noi mangia farine raffinate, ha uno scarso apporto di verdure a fronte di un eccessivo apporto di sodio e scarso apporto di frutta». Mangiamo male, insomma: se il fumo di sigaretta è tra le principali cause di tumore ai polmoni, ciò che mangiamo non concorre sempre alla nostra salute. «Abbiamo circa il 18 per cento, una persona su sei, che fa un consumo di alcol a rischio – continua Nardi – Il cosiddetto binge drinking è l’atteggiamento, tipico per lo più dei giovani, che consiste nel consumo in un’unica volta di un quantitativo di alcol corrispondente a circa cinque unità alcoliche magari a stomaco vuoto». La quintessenza del bere male, insomma. A Davide Pettenella, docente di Economia e politica forestale dell’Università di Padova, è toccato invece il compito di ridare una dimensione politica al cibo, in rapporto a come viene prodotto, da chi e dove. «Esistono nuove forme di organizzazioni sociali – riflette Pettenella – Abbiamo tutti imparato a conoscere i Gas, i gruppi di acquisto solidale, ma siamo andati ben oltre questa prima forma di organizzazione sociale per premiare il cibo a basso impatto ambientale e ad alta valenza sociale. Le comunità del cibo con iniziative di co-progettazione della produzione, di pre-acquisto o di abbonamento, le community–supported agriculture, gli abbonamenti stagionali, cioè un sostegno dei costi di gestione, le food coop, le cooperative di comunità e così via». È il grande mondo dell’agricoltura e dell’allevamento responsabili che sulle nostre montagne ha permesso a tante piccole realtà produttive di costruirsi mercati nuovi, più redditizi e sostenibili.
Fabris: «Siamo passati dal sapere al sapore»
Durante il seminario su etica e cibo della Fondazione Lanza (a destra nella foto), il prof. Adriano Fabris ha sottolineato come, a partire dal Settecento, con l’introduzione della categoria estetica del gusto, siamo passati dal sapere al sapore, facendo poi di quest’ultimo un criterio etico. La conseguenza è che oggi ognuno ha il diritto di mangiare (e fare) tutto ciò che gli va. E di solito mangiamo male.
Un biennio di approfondimenti sulla vulnerabilità
Vulnerabilità, diritto e diritti hanno rappresentato il file rouge che in questo secondo anno di studi ha accompagnato la Fondazione Lanza nel primo semestre del 2025. In attesa di scoprire le iniziative per il prossimo anno accademico, le registrazioni di tutti i webinar sono disponibili su YouTube nel canale della Fondazione mentre su fondazionelanza.it è possibile ripercorrere l’intero itinerario attraverso una serie di articoli tematici originali.
Lo studio della Fondazione Foresta. 18enni maschi, il 18 per cento è già obeso
La curva dell’obesità giovanile, dopo un breve rallentamento negli anni passati, torna a salire: lo certificano i dati dell’Istituto Superiore di Sanità e lo conferma, con cifre ancor più dettagliate, il “Progetto Scuola” promosso dalla Fondazione Foresta, con sede a Padova, che nell’ultimo anno ha coinvolto quasi 6 mila studenti delle scuole superiori. I risultati parlano chiaro: il 18 per cento dei diciottenni maschi presenta obesità, a fronte del 12 per cento tra le coetanee. Otto anni fa, il divario era di soli due punti. Oggi si allarga, e preoccupa. Lo studio è stato illustrato all’interno del diciottesimo convegno di endocrinologia e medicina della sessualità sul tema “Obesità, osteoporosi, infertilità: un complesso sindromico dilagante”, tenutosi a Lecce il 9-10 maggio. Queste tre patologie sono infatti frequentemente interconnesse: basti pensare che quasi il 50 per cento dei giovani infertili è infatti obeso e presenta una ridotta densità dell’osso, prodromica all’osteoporosi. «L’obesità non è solo un problema di chili in eccesso: coinvolge la salute e le relazioni» spiega il prof. Carlo Foresta, andrologo ed endocrinologo, già docente presso l’Università di Padova. Lo testimonia anche uno studio pubblicato sulla rivista Endocrine, condotto su oltre cento ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. Oltre il 90 per cento dei soggetti obesi e ben il 76 per cento dei normopeso mostrano livelli insufficienti di vitamina D, fondamentale per il metabolismo osseo e la regolazione ormonale. In presenza di una carenza marcata il rischio di sviluppare almeno un fattore di rischio cardiovascolare (ipertensione, glicemia o colesterolo alti) raddoppia. Il cuore del problema sta però anche altrove: soprattutto nei più giovani il sovrappeso spesso si accompagna a relazioni più fragili e crescente isolamento, in cui la sedentarietà si combina con una relazione alterata con il cibo, tra compensazione e sfogo emotivi. «Abbiamo ad esempio osservato che il rischio di obesità aumenta in presenza di famiglie con genitori anziani o separati, in cui spesso abbiamo figli unici che passano molto tempo da soli», continua Foresta. In gioco non c’è solo il corpo, ma anche la psiche: isolamento sociale, uso eccessivo dei dispositivi digitali, rifugio in relazioni virtuali che sostituiscono quelle reali. E un circolo vizioso che si autoalimenta: più isolamento, più fame nervosa; più sovrappeso, meno fiducia nel proprio corpo e nelle proprie relazioni e spesso anche più consumo di pornografia online: «Il 20 per cento degli adolescenti obesi dichiara inoltre già a 18 anni una qualche disfunzione sessuale, più del doppio rispetto ai coetanei normopeso». Il messaggio degli esperti è chiaro: serve un cambio di passo, e in fretta. Serve restituire centralità alla prevenzione con screening nelle scuole, educazione alimentare e attenzione alla salute psicologica; occorre però anche recuperare uno stile di vita attivo. «È inutile ripetere che bisogna fare sport, se poi questo si riduce a un paio d’ore settimanali, magari da raggiungere in macchina, per poi tornare subito davanti a uno schermo, stesi sul letto o sul divano – ribadisce il professore – Il dinamismo è fondamentale: un tempo da giovani si era sempre in giro, attivi per tutta la giornata. Oggi invece tendiamo a “ghettizzare” l’attività fisica, separandola dalla vita e dal lavoro: questa dovrebbe essere invece parte integrante della quotidianità, non un’eccezione programmata».
In Italia un 17enne su quattro è in sovrappeso
In Italia oltre il 22 per cento degli adolescenti è in sovrappeso (ovvero con un indice di massa corporea compreso tra 25 e 29.9 kg/m²), con punte del 24 per cento tra i maschi di 17 anni, mentre il 3,9 per cento classificato come obeso (dai 30 kg/m² in su). Il fenomeno colpisce soprattutto il Sud, dove in alcune regioni come la Campania e la Puglia oltre un quarto dei ragazzi presenta un eccesso ponderale, a fronte di percentuali sotto il 15 per cento nel Nord. La tendenza è in crescita, in particolare tra gli 11 e i 14 anni. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’obesità giovanile in Italia è quadruplicata dal 1990, configurandosi come un’emergenza sanitaria legata a stili di vita sedentari, cattiva alimentazione e fattori sociali e familiari.