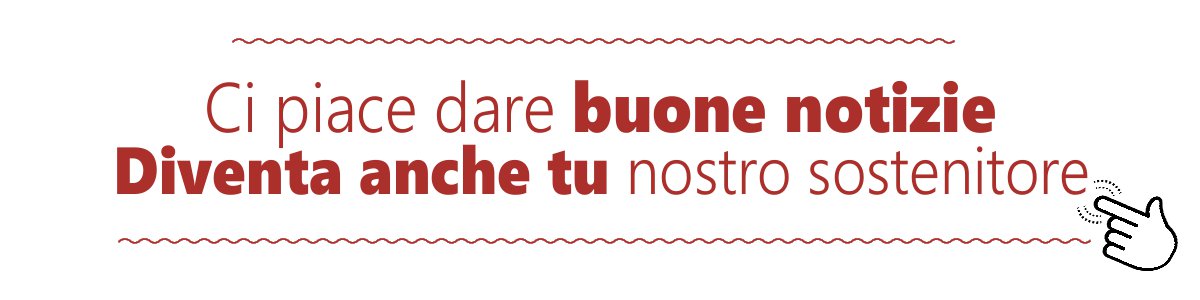150 anni fa la battaglia di Lissa, tra nuove corazzate e antichi "speroni"
Il 20 luglio del 1866 al largo di Spalato la flotta italiana subì una umiliante sconfitta dall'impero austroungarico, in quello che fu il primo scontro navale in cui si affrontarono le nuove navi a vapore protette da corazze di ferro, ma anche l’ultima sfida in cui fu usato a scopo offensivo il “rostro” di antica memoria per speronare e affondare le navi nemiche.
Da quella guerra il Veneto sarebbe uscito annesso all'Italia, ma veneti erano in gran parte gli equipaggi e per molti storici Lissa può essere a ragione considerata l'ultima vittoria della marineria veneziana.

La storia della marineria la ricorda come la prima battaglia tra grandi navi corazzate, e contemporaneamente come l’ultima in cui fu usato il rostro, o sperone, come arma intenzionale per attaccare le unità avversarie.
La battaglia di Lissa, avvenuta il 20 luglio di 150 anni fa al centro del mare Adriatico, nel contesto della terza guerra d’indipendenza, è rimasta per la storiografia italiana una sconfitta, imputata, come la parallela battaglia terrestre di Custoza, all’inesperienza e alla scarsa coesione dell’esercito e della flotta del giovane stato italiano.
Per contro, è “celebrata” come una vittoria non solo dall’ormai defunto impero austroungarico, e dall’attuale Croazia, ma anche da una parte del popolo veneto, poiché la flotta austriaca che sconfisse quella italiana era in buona parte erede della marineria veneziana, attingendo allo stesso bacino veneto-triestino-istriano-dalmata, che ne aveva costituito per secoli il dominio. Ma prima di frugare nel carro dei vincitori e dei vinti, operazione ormai peregrina, vediamo in breve come si sono svolti i fatti.
Lissa è un’isola al largo di Spalato storicamente occupata da una base navale veneziana, e poi austroungarica.
Durante la guerra del 1866 fu attaccata, il 18 luglio, dal grosso della flotta italiana comandata dall’ammiraglio Carlo Pellion di Persano, pressato dal governo perché chiudesse il conflitto con un successo navale in modo da compensare la sconfitta di Custoza e chiudere la guerra da vincitori. Guerra che comunque si stava chiudendo, perché i tedeschi, alleati dell’Italia, il 3 luglio avevano sbaragliato l’Austria nella decisiva vittoria di Sadowa.
Pur di ottenere l’armistizio gli Asburgo si erano dimostrati disponibili a cedere il Veneto, ma non direttamente all’Italia, bensì alla Francia, che l’avrebbe poi “girato” a Vittorio Emanuele II (come alla fine avvenne).
Persano non aveva avviato l’impresa volentieri: sulla carta la flotta italiana era stata oggetto di un notevole rammodernamento e, sempre sulla carta, era superiore quantitativamente e qualitativamente a quella austriaca. L’ammiraglio aveva a disposizione 13 unità corazzate e 17 di legno, mentre gli austriaci, guidati dal giovane ammiraglio Wilhelm von Tegetthoff, contavano su sette navi corazzate e 11 di legno.
Ma nella realtà gli italiani avevano non pochi problemi: le nuovissime fregate corazzate Re d’Italia e Re di Portogallo, costruite negli Stati Uniti, avevano una corazzatura che lasciava troppi punti vulnerabili, tra cui il timone. Il nuovissimo Affondatore, costruito in Inghilterra, la prima nave italiana con artiglieria in torri corazzate, si rivelò una delusione per la scarsa maneggevolezza e per la stessa novità di concezione, a cui i marinai non erano addestrati. E poi, soprattutto, le quattro marine che erano confluite in quella italiana (sarda, napoletana, toscana e pontificia) erano ancora divise da profonde rivalità e da rancori di vecchia data.
Così il 20 luglio 1866 quando arrivò la flotta austriaca, in formazione a triplo cuneo, con l’ordine di sopperire alla deficienza numerica e di artiglieria concentrando il fuoco sulle singole unità nemiche e andando a speronare “tutto quello che è grigio” (le navi asburgiche erano nere), la flotta italiana stentò a schierarsi in ordine di fila. A causa della diversa velocità e dell’improvvida decisione dell’ammiraglio di passare dalla fregata Re d’Italia all’Affondatore, si creò un vuoto tra la prima e la seconda squadra, in cui si inserirono gli austriaci.
La battaglia quindi si trasformò in una serie di scontri isolati in cui, anche a causa dell’inazione di due delle tre squadre tricolori, la superiorità numerica fu sempre dalla parte degli austriaci.
La Re d’Italia, immobilizzata da un colpo al timone, fu speronata dalla fregata corazzata ammiraglia, la Ferdinand Max, e affondò in breve tempo. La cannoniera corazzata Palestro, che aveva incautamente accatastato 20 tonnellate di carbone sul ponte, si incendiò ed esplose. Invece i ripetuti tentativi di speronamento italiani furono elusi e nessuna nave nemica, neanche quelle seriamente danneggiate, affondò. Lo scontro si chiuse con 620 morti e 40 feriti italiani (612 furono i morti sulle due navi affondate, compresi i comandanti) contro 38 morti e 138 feriti austriaci. Gli esperti militari furono portati a sovrastimare l’apporto dello “sperone” alla vittoria austriaca, mentre in realtà la Re d’Italia fu centrata solo perché era immobile mentre l’Affondatore fu una vera delusione.
Dopo pochi anni la strategia navale cambiò radicalmente con l’introduzione dell’artiglieria in torri girevoli blindate e soprattutto con sistemi di puntamento e di munizionamento che la rendevano ben più micidiale di quella in uso a Lissa, perlopiù ad avancarica, a canna liscia e caricata a palle di ferro piene.